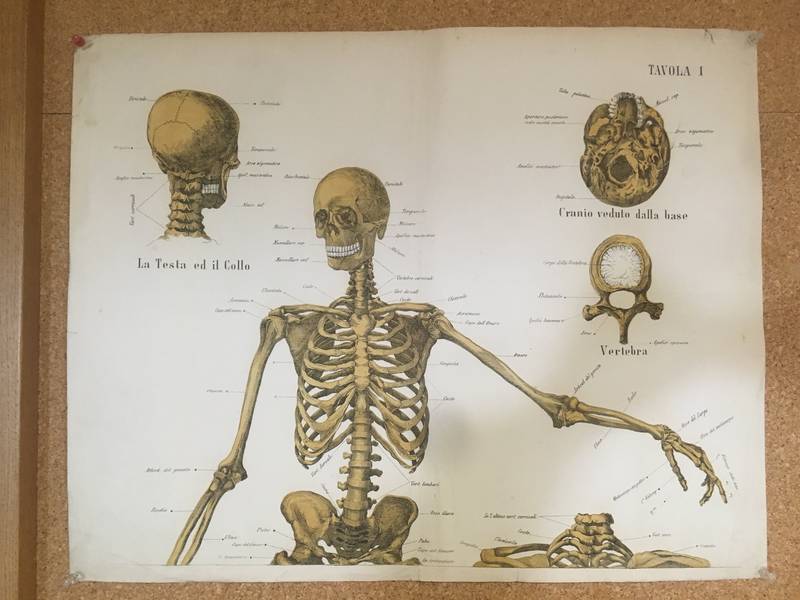Il pensionato
Lo sento da oltre il muro che ogni suono fa passare,
l’odore quasi povero di roba da mangiare.
Lo vedo nella luce che anch’io mi ricordo bene
di lampadina fioca, quella da trenta candele
fra mobili che non hanno mai visto altri splendori,
giornali vecchi ed angoli di polvere e di odori
fra i suoni usati e strani dei suoi riti quotidiani:
mangiare, sgomberare, poi lavare piatti e mani.
A svegliarlo fu al solito l’urgenza di liberare la vescica. Aperti lentamente gli occhi fu trapassato dalla crudele luce del mattino: gli fece male, cercò rifugio tra le coltri schiacciando la faccia contro il cuscino e sollevando la coperta, ma lo stimolo alla vescica era opprimente. Quando era bambino resisteva per un’ora prima di alzarsi e andare a scaricarsi nel bagno, ora avrebbe rischiato di farsela addosso, non era il caso di fidarsi troppo della resistenza delle sue valvole.
Metà stanza era ancora immersa nel buio. Appena lo schermo bianco che gli era calato sugli occhi si dissolse, la stanza prese forma e riconobbe tutto: il comò di fronte al letto con le foto di famiglia, il pizzo su cui facevano polvere vecchi oggetti della moglie che non riusciva a metter via per non fare torto alla sua memoria, poi le pareti crepate, una marina appesa accanto alla pergamena egizia che gli regalò qualcuno un tempo, l’armadio del matrimonio con le ante cigolanti e lo specchio opaco, sopra la sua testa il crocifisso ligneo incombente con la fronte del cristo coronata di spine e il sangue che gli colava sugli occhi.
Alzarsi ogni mattina era divenuta nel tempo un’incombenza amara, come recarsi ogni giorno al cimitero a scavarsi la fossa e poi seppellirsi fino a soffocare. Ogni giorno si celebrava il rito della nascita con il suo strazio, il dolore di essere proiettati in un mondo ostile; la notte celebrava il rito della morte, il quieto ritorno al buio cosmico.
L’odore del caffè, simile a un puzzo di verdure marcite in qualche angolo remoto della cucina, gli faceva venire la nausea, e poi non c’era più sua moglie Ada a metterlo sul fuoco, gli piaceva sentire l’aroma mentre in bagno, infreddolito, si vestiva in fretta. I panni messi sul calorifero a prendere calore, gli spifferi gelidi che infierivano sulle gambe nude, l’acqua troppo fredda o troppo calda, la luce debole della lampadina sospesa sulla testa, lo specchio buio che rimandava un’immagine impalpabile mentre cercava di radersi il viso, riti del mattino, obsoleti, rinnovati, quotidiano a cui non si può scampare.
Nel soggiorno trovava gli abiti stirati, la tazza di caffè e il pane da mangiare nel latte.
Di solito mentre preparava il caffè e le medicine da prendere ascoltava i rumori dei vicini di casa. Al piano di sopra c’era una giovane coppia di sposi: trottavano avanti e indietro prima di correre al lavoro, trangugiavano il caffè in fretta e discorrevano confusamente mentre finivano di vestirsi, poi un calcio al portone e li sentivi precipitarsi giù per le scale, sempre in ritardo, per quanto ricordasse.
Accanto, la vedova più anziana di lui di qualche anno — aveva seppellito suo marito talmente tanto tempo fa che a malapena si ricordava di essere stata sposata —: la sentiva ciabattare in cucina con la radio sintonizzata su radio Maria, l’avrebbe spenta solo alle nove, prima di coricarsi.
Quella mattina non si sentiva nulla, silenzio sepolcrale. Si chiese se fosse accaduto qualcosa.
Come ogni mattina aprì l’unica finestra che illuminava la cucina. Le imposte erano chiuse a chiave per volontà della moglie, il loro appartamento era al primo piano, bastava appoggiare una scala e chiunque sarebbe entrato. Negli ultimi anni sua moglie era stata tormentata dall’idea che qualcuno potesse intrufolarsi in casa, l’idea si era fatta via via più delirante con richieste che gli erano parse assurde, come quella di schermare la finestra del bagno che dava sul giardino in modo che nessuno la spiasse mentre si faceva la doccia, o quella di mettere le serrature a tutte le imposte.
Il caffè cominciò a gorgogliare nella caffettiera, lo versò nella sua tazza bianca. Nel ripiano dei bicchieri, c’era la tazza preferita della moglie, una tazza bianca con decorazioni floreali cinesi e il bordo dorato, l’aveva presa a una bancarella dell’antiquariato per il suo sessantesimo compleanno; le era piaciuta tanto quella tazza, alla sera lui le portava a letto la camomilla, e lei la contemplava prima di sorseggiare: c’era un pavone tra una decorazione e l’altra e lei lo osservava sempre, un giorno gli disse che quel pavone era come se cambiasse ogni volta di posto, così doveva scorrere la tazza facendola ruotare su se stessa fino a ritrovarlo. Negli ultimi mesi invece la tazza le era divenuta estranea, come tutto, la sorreggeva a fatica con le dita scheletriche e tremanti, lui la doveva aiutare, qualche volta gli era parso che sorridesse, ma poi pensava sempre che era un’illusione, l’incantevole sorriso che tanti anni addietro lo aveva stregato, la dolcezza dei suoi occhi neri appena velati di malinconia, tutto divorato dalla demenza.
Ogni luce si spense in lei salvo in punto di morte, quando per un attimo i suoi occhi tornarono quelli di un tempo, profondi e malinconici, devastati dalla malattia ma ancora segnati dai sentimenti, occhi che gli sorrisero, che ricordarono i giorni dell’amore fisico e poi quelli dell’amore quieto, del volersi bene andando oltre la spossatezza fisica, oltre le stanche membra del corpo, della tenerezza senza carezze.
Prima ancora di aprire la porta della veranda che dalla cucina porta al piccolo giardino nel retro, sentì quello strano rantolo e poi quel suono quasi impercettibile eppure distinto, una specie di pigolio. Sbirciò tra gli spiragli della persiana ma la visuale era parziale, riusciva a vedere solo il pavimento della piccola veranda, la porta del ripostiglio dalla parte opposta e uno spicchio di giardino con la siepe alta di alloro che lo separava dal giardino dei vicini. Il suono veniva dalla parte nascosta del giardino, lo avrebbe visto bene dalla porta-finestra della camera da letto. Si chiese che cosa potesse essere, forse un grosso gatto ferito. Ruppe gli indugi, aprì la porta della cucina e uscì sulla veranda. Subito scorse un corpo sulla sinistra, a ridosso del piccolo orto di erbe aromatiche. Era il corpo di un grosso animale, a prima vista gli sembrò un cane di grossa taglia, molto grasso, era sdraiato, dalla sua posizione vedeva solo la parte finale del corpo, le zampe erano nascoste sotto la grossa mole dell’addome gonfio, poi vide la coda e rimase senza fiato, era una coda grossa come una corda, una coda da ratto. Fu tentato di tornare sui suoi passi. Il corpo dell’animale gemeva, il suono, quel lamento costante, veniva dalla testa, l’addome gonfio dell’animale si abbassava e si alzava, qualcosa pulsava lentamente in lui. Il vecchio fece un passo verso destra per visualizzare l’intero corpo. L’animale era lungo un metro e mezzo circa, la coda misurava quasi un metro ed era attorcigliata. La testa più affusolata era affondata nel timo. Sembrava anche la testa quella di un ratto; era il ratto più grande e spaventoso che avesse visto in tutta la sua vita e in passato quando lavorava come impiegato nel magazzino di un’azienda ne aveva visti di belli grossi, grassi come maialini e arditi, non scappavano quando ti avvicinavi, restavano fermi a fissarti con aria di sfida. Si avvicinò ancora all’animale e sentì quel rantolo alzarsi e divenire stridulo, la testa fece un movimento brusco, emerse dal cespuglio del timo per poi stramazzare nell’erba e rimanere lì a sfiatare. Ora poteva vedere il muso nella sua interezza. Era più largo di quello di un topo e le narici erano ovali e profonde, sbuffavano vapore, sotto il labbro inferiore pendevano come dei bargigli, dalla bocca dischiusa balenavano denti gialli, grossi e aguzzi. Gli occhi minuscoli erano rossi e leggermente schiacciati. Nel complesso un brutto animale, di una razza a lui ignota.
Se telefono al veterinario penseranno che sono ubriaco. Alzò la testa per vedere se c’era qualcuno ai balconi e alle finestre dei palazzi di fronte: tutto silente, nessuna traccia di esseri umani. Solo lui e quella bestiaccia immonda nel giardino.
Rientrò in casa e pensò al da farsi. Certo non poteva far finta di niente, come se quella strana bestia non ci fosse stata. Avrebbe voluto, avrebbe voluto fare finta di niente, come se si fosse trattato di un sogno, o una di quelle visioni malate di Ada. Ma era là e ci sarebbe rimasta per molto tempo, prima di morire e poi marcire e infine impregnare l’aria del quartiere di un orrendo malsano olezzo. Lo avrebbero sfrattato, lo avrebbero cacciato via in malo modo, forse condotto al sanatorio. Incapace di intendere e volere, incapace di provvedere a se stesso, arrecava grave nocumento al vicinato. E quella bestiaccia, si sarebbe difeso, non l’avete vista? Come avrei potuto portarla via da solo? Quale bestiaccia, gli avrebbero risposto, non c’era nulla in quella casa, solo la sua trascuratezza, imputabile alla sua età e alla demenza senile acclarata.
No, non poteva lasciarla così, a crepare. Improvvisamente gli venne pietà. Era una bestia brutta, d’accordo, una creatura da incubo, ma era pur sempre moribonda, stava soffrendo, sentiva il suo gemito disperato entrargli in testa, era stato ingiusto a ritenerla solo una scocciatura, un ingombro, non si può essere indifferenti alla sofferenza, in fondo anche lui un giorno poteva finire come quella bestia, agonizzante nel giardino, dopo un attacco di cuore, ignorato e dimenticato, una morte lenta e solitaria, lontana da ogni affetto, senza nessun volto pietoso a stringergli la mano prima del momento. Tornò fuori e guardando l’animale morente cercò di pensare a come alleviare la sua sofferenza. Forse poteva dargli da bere, sì, è così che si fa sempre ai moribondi, a parte gli annegati, si intende. Gli venne da ridere immaginandosi sulla spiaggia mentre infilava una bottiglia di acqua panna nel gargarozzo di uno che aveva sputato litri di acqua salata. Ma forse non era così peregrina l’idea, forse anche gli annegati hanno bisogno di bere per ritemprarsi, forse alcolici, come quelli che cadono sotto le slavine. Non aveva alcolici in casa, solo una grappa al mirto, ma non gli sembrava il caso di darla da bere alla bestia. Prese una ciotola dalla credenza e la riempì d’acqua. Tornò nel giardino. L’animale non si era mosso. Il suo ventre gonfio continuava a espandersi e contrarsi. Dalla bocca gli colava un liquido giallastro, si era raccolto in una piccola pozza sotto il muso. Che schifo, non toccherò mai più queste erbe aromatiche. Aggirò il corpo, l’animale non diede segno di averlo scorto, gli occhi vitrei sembravano fissare la siepe, qualcosa in quelli dava il senso di una disperazione abissale, che lui non avrebbe mai compreso. Si chiese se la cosa non fosse arrivata da un’altra dimensione, si domandò come si sarebbe sentito lui al suo posto se fosse andato a morire in un mondo dove lui era un oggetto strano e ingombrante. A fatica si piegò per infilare la ciotola sotto il muso, la lasciò sotto e poi si rialzò inarcando la schiena e tenendosi i fianchi. Ogni volta che si piegava sentiva dei sinistri scricchiolii. Sono come una vecchia sedia di legno, sono ancora buona all’uso ma non c’è da farci troppo affidamento, se dondolo finisce che mi strappo una gamba e finisco a ruzzolare. L’animale non beveva, i bargigli lambivano l’acqua ma la bocca non si apriva. Forse era troppo incosciente. Pensò di toccargli il muso per spingerlo a bere, ma l’idea gli fece senso. Con qualcosa, con qualcosa potrei toccarlo, senza fargli del male. Guardò nel ripostiglio, trovò i guanti da giardinaggio. Li infilò e si fece coraggio. Lo toccò delicatamente sul muso spingendo la bocca a contatto dell’acqua. Ma l’animale restò inerte. Lo toccò sopra la nuca ma fu tutto inutile. Provò anche a parlargli, come faceva con i gatti che ogni tanto transitavano nel suo giardino. Coraggio, apri la bocca, devi bere o farai una brutta fine. Con sua enorme sorpresa l’animale schiuse la bocca e una lingua nera e viscida uscì a lambire l’acqua, seguirono rumori orribili mentre l’acqua veniva aspirata tutta in pochi secondi. Poi la bestia provò a muovere il muso ma per quanti sforzi facesse non riusciva. I rumori del ventre sembrarono aumentare come se l’acqua avesse attivato ancora di più le attività all’interno del corpo. Il vecchio vide il contorno di un verme o qualcosa del genere premere contro lo stomaco dilatato. Che razza di bestia sei. L’animale sembrò riprendersi, sollevò il muso e digrignò i denti aguzzi contro di lui, i lineamenti contratti in una smorfia feroce.
Ma gli occhi rossi sembravano arresi all’evidenza di un corpo indifeso, in balia dei predatori.
Rientrò in casa e si sedette sul divano pensando al da farsi.
Pensò di chiamare la vicina di pianerottolo, Marisa, in fondo lei lo seccava per ogni stupidaggine, come quella storia delle foglie del gelsomino di Ada che secondo lui ostruivano le grate di scolo nel garage rischiando di provocare un’alluvione, preoccupazione che sarebbe stata legittima se le foglie in questione non fossero che due rosicate foglie ingiallite e ormai marce cadute nell’ingresso dei fondi. Il vecchio sospettava che la propensione a disturbare gli altri per quisquilie fosse un estremo tentativo di superare l’angoscia rimossa di essere sola da anni e se vogliamo da sempre visto che il marito era stato una presenza impalpabile, tanto che ci si accorse di lui solo quando la bara uscì dal condominio. Poveretto, donna noiosa, due solitudini a contatto, una coppia terrificante, orribile connubio. Chissà che fa quella povera bestia.
Prima di uscire controllò come stava, come per convincersi ancora una volta che esisteva realmente, con disgusto e pietà la osservò ancora distesa, ansimante, con quella linguaccia oscena di fuori.
Morirà presto, che sollievo. Con una punta di invidia ne considerò la parabola. All’inferno dove si troverà bene, senz’altro, nel buio tra le fiamme, con altre disgustose creature.
Strano che Radio Maria sia spenta, in tanti anni di vita condominiale non ricordava un solo giorno in cui la radio di Marisa non fosse sintonizzata ad alto volume su quella stazione bigotta. Ogni giorno la preghiera a Maria insozzava l’aria. Litanie a largo consumo, prediche roche, preti dissoluti e sinistri.
Bussò alla porta timidamente, l’idea di seccare la gente era sempre stata radicata in lui fin da bambino, era un uomo silenzioso, non voleva mai disturbare, perché i rumori lo infastidivano e chi lo cercava gli metteva paura, non odiava gli uomini ne aveva però paura, una paura che non lo aveva mai abbandonato anche se Ada gliel’aveva spesso rimproverata. Quel po’ di vita sociale che aveva condotto nella sua esistenza era dovuta ad Ada che ostinata aveva sempre tentato di coinvolgerlo nelle sue relazioni sociali così ricche e impegnate. Il circolo dei lettori, il coro gospel, il trekking in alta montagna, Ada era pervasa di voglia di partecipare, di esserci, anche se poi una volta a casa si sfogava a letto sparlando di tutti quelli a cui aveva affabilmente sorriso: Ada era così, le piaceva incontrare persone per poterle sminuire, ridicolizzare, in privato con lui. Era forse il suo modo di sentirsi appagata e realizzata socialmente, lei che sentiva in fondo di aver sprecato la vita dietro un uomo così timido e impacciato, e incapace di darle figli e una buona rendita, un uomo buono a cui voleva bene ma che segretamente talvolta aveva odiato e tentato di ferire.
Per quanto i colpi sulla porta fossero timidi, in quel silenzio assoluto i rumori rimbombavano ed era impossibile ignorarli. Suonò allora il campanello, il trillo acuto lo fece sussultare, sembrava tanto forte il suono che temeva di aver allertato tutto il quartiere. Attese invano. Pensò di lasciar perdere quanto sentì qualcosa, proveniva dal giardino di Marisa, un suono soffocato, come un gran morso. Il portone era spalancato. Macchie rosse sulla maniglia e sul pavimento. Sangue, ancora fresco. Avvicinandosi al portone i rumori di masticazione aumentavano. Ricordavano lo zio Maurilio quando rosicchiava la carne che restava attaccata alle ossa delle costolette. Scrunch, scrunch… slarc, slabbr… mentre strappava la carne come un cane affamato, latrava in un cantuccio sordo e sporco, il suo stomaco brontolava come un temporale vicino, sempre affamato, prossimo a stramazzare al suolo vinto dall’inedia perenne.
Il vecchio si affacciò e guardò a destra dove il giardino di Marisa terminava in una piccola nicchia con la lavatrice e un piccolo sgabuzzino per scope e utensili da giardino. Una volta aveva visto uno dei figli dei vicini entrare nel giardino per recuperare il pallone, un discolo dall’aria monella e innocente. Aveva socchiuso la porticina e aveva scorto una trappola in cui si dibatteva agonizzante un topino di campagna, era rimasto incastrato con la testa, sangue zampillava allegro dal collo, agitava frenetico le zampette. Il bambino lo aveva osservato freddo e curioso, poi aveva preso la palla ed era scappato via, turbato da qualcosa.
Lì di fronte alla porta in legno dello sgabuzzino, nello stesso punto in cui quel bambino aveva osservato quel topo morente, una creatura come quella che stava agonizzando nel suo giardino si stava nutrendo della vedova. Se ne cibava lentamente, senza fretta, strappando la carne con pazienza e meticolosità. Alla vedova mancava già gran parte del volto, la carne delle spalle, e delle braccia, ora la bestia le stava divorando lo stomaco.
Il vecchio non ne fu stupito, o meglio, non ne fu turbato come credeva, in qualche modo se lo aspettava: il silenzio, la radio spenta, forse tutti in quel momento erano divenuti cibo per queste bestie. Sarebbe accaduto anche a lui se la bestia toccatagli in sorte non fosse incorsa in qualche incidente, o magari gli era toccata una bestia malata, chissà. Ciascuno ha la sua bestia, a me è toccata in sorte una povera creatura bisognosa di cure, una creature che una volta guarita probabilmente non esiterà a uccidermi per nutrirsi della mia carne, in fondo è la sua natura, e io non posso certo oppormi alla natura.
La bestia, incurante del vecchio, continuò a consumare il suo pasto. Il vecchio tornò in casa. Forse dovrei chiamare la polizia, pensò, ma fu un pensiero fuggitivo, un pensiero che apparteneva ad un’altra epoca.
Sedette sul divano afflitto come se avesse commesso un errore irreparabile. Come se si sentisse responsabile della rovina del mondo. Di quell’apocalisse assurda che stava colpendo il suo quartiere e magari l’intero pianeta.
Accese il televisore senza troppe aspettative. Non c’erano segnali, una nebbia fitta copriva lo schermo, in sottofondo oltre il ronzio pensava di percepire urla atroci.
Tornò in giardino attirato dai nuovi rumori che la bestia moribonda produceva. Si stava contorcendo come presa da convulsioni, spettacolo orribile a vedersi, aveva quegli occhiacci rossi strabuzzati, la pancia era tesa come da un corpo estraneo che volesse uscire. Dalla bocca le usciva un liquido verdastro che formava pozze maleodoranti nel giardino. Dove si formavano l’erba avvizziva rapidamente. Il vecchio arretrò alla porta temendo che la bestia potesse rotolargli addosso e schiacciarlo sotto il suo peso. Ma d’improvviso si calmò e mettendosi in piedi faticosamente sputò un orrendo verme grasso e lungo come un serpente, un verme con due teste provviste di tenaglie. La bestia lo fece a pezzi con le zampe affilate, lo ridusse in tante parti che continuavano a contorcersi di vita riflessa, una delle teste finì a pochi passi da lui, puzzava in modo osceno, il vecchio dovette stringersi il naso per non vomitare.
Le bestia sembrava guarita, si reggeva sulle zampe affannata ma il peggio era passato. Il vecchio non sapeva se rallegrarsene o dolersene.
Ora mi farà a pezzi, si ciberà delle mie carni, tenendomi vivo fino all’ultimo come fanno certi predatori, mi mangerà pezzo per pezzo e io sentirò tutto, sentirò i denti, quel rumore disgustoso di masticazione, sentirò il mio corpo andarsene a poco a poco, mi abituerò forse al dolore, forse perderò conoscenza.
La bestia lo fissò a lungo, però invece di balzargli addosso se ne andò. Il vecchio sconcertato guardò lo scempio del giardino, tanto duro lavoro per riportarlo all’antico splendore. Si concesse un po’ di riposo, si accomodò su una seggiola sotto la veranda e contemplò la desolazione del quartiere. Notò solo ora quel rivolo di sangue che scorreva dai terrazzi, un filo rosso che a terra formava pozze scure.
Non passò molto tempo che la bestia tornò, accompagnata da altre bestie come lei. Gli furono attorno minacciose, a semicerchio. Riconosceva la bestia di cui si era preso cura, era più magra e macilenta delle altre, nelle fauci stringeva la testa di un uomo: era il vicino del piano di sopra, l’uomo della giovane coppia, chissà che fine aveva fatto la ragazza. Le bestia avanzò e depositò ai suoi piedi la testa del giovane del piano di sopra. Mancava di un occhio e il naso era rosicchiato ma lo riconosceva. Con un muto cenno del capo la bestia indicò la testa mozzata e poi si allontanò saltando la siepe, così fecero le altre bestie.
Gli avevano risparmiato la vita e gli avevano reso omaggio portandogli la testa mozzata. Che cosa si aspettavano? Che mangiasse quella testa in segno di gradimento? Il vecchio immaginò il resto dei suoi giorni sulla terra, unico sopravvissuto in un mondo dominato da quelle bestie, ne fu atterrito. Sollevò la testa mozzata e rientrò in casa. La mise in una teglia, accese il forno, poi andò a rigovernare la stanza come faceva sempre prima di pranzo.
In copertina: Bert I. Gordon, The Food of the Gods (Il cibo degli dei), 1976. Un fotogramma.