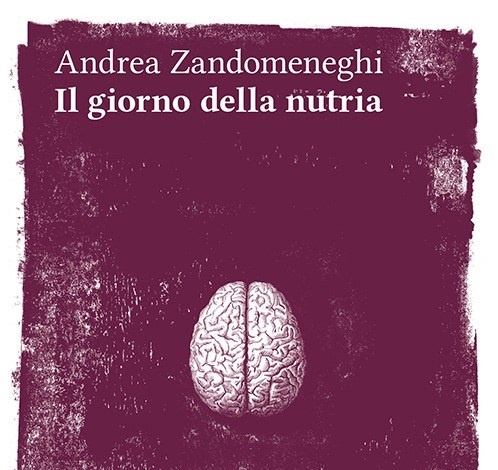La formula di partenza in sintesi
Anzitutto mettiamo a punto il dispositivo concettuale disortopneumatologico che percorre trasversalmente tutta l’opera di Dostoevskij; per farlo – invece di astrarre e strologare fumosamente – è bene da subito incarnarlo. Scelgo per comodità l’esempio di Rodion Romanovič Raskol’nikov, il protagonista di Delitto e Castigo, perché è uno dei simboli più lineari della nullificazione dell’altro e dei suoi tragici risultati e risvolti: la spina dorsale del romanzo riguarda proprio l’angosciosa, enigmatica ed esiziale questione della privazione del senso e della strumentalizzazione dell’altro.
Rodion è un ragazzo buono; non una di quelle anime sfigurate e disgregate dalla dissoluzione che abbondano nell’opera di Dostoevskij. Rodion è un dilaniato, un Ivan Karamazov più sano, meno colto, meno scettico, ancora salvabile; certamente fagocitato dai propri pensieri pseudosuperomistici e corroso dai succhi gastrici dei medesimi; ma non ancora sdoppiato: non ha infatti «scimmia», non ha Smerdjakov, né conversazioni allucinatorie con il diavolo (l’ultimo stadio della rovina e del crollo spirituale in Dostoevskij, che raggiungono solo Ivan e Nikolaj Stavrogin); al massimo si può ipotizzare come suo «sosia» orribile – rectius: come specchio deformante, come presaga ammonizione, come incubo – e sordidamente degenerato Svidrigajlov.
«Posso essere un Napoleone?» si chiede il giovane studente attanagliato dalla miseria nelle sue notti insonni, affamato, in una stanzetta claustrofobica. Posso io ridurre l’altro a nulla, fosse anche l’altro più infimo (una vecchia odiosa e crudele, vedova, usuraia, parassita sociale dannosa)? Posso nullificarlo e strumentalizzarlo a mio piacimento? Dostoevskij risponde negativamente. Il volo ergo possum è infatti l’aberrazione ribaltante del superomismo che inevitabilmente trasfigura il volto umano della persona che lo vive, prima subumanizzandolo poi disumanizzandolo infine necrotizzandolo; è l’incubo collettivo della nostra società contemporanea che tutto riduce, mercificata e mercificante, consumata (l’erosione dell’interiorità e della relazionalità) e consumante, che – scellerata – idolatra l’individualismo libidico. Memorandum: Dostoevskij talvolta è «profetico».
Nullificando l’altro da sé, si nullifica se stessi: non conta la morgana di una crescita spirituale potenziale (l’altro come esperimento), non contano le ragioni utilitaristico-filantropiche, non conta il fatto che sopprimendo la vecchia si possano inverare i più magnifici sogni di progresso socio-umanitario e di solidarismo – il fine non giustifica mai i mezzi. Anche questo ideale apparentemente splendido e giusto impallidisce dinnanzi all’automostrificazione fatale di chi perpetra la riduzione dell’altro da sé.
Formalizzo il dispositivo:
Il volo ergo possum (l’azione di Rodion) presuppone il mensuro ergo possum (il rovello di Rodion), produce il possum ergo volo (il seminare per noia demoni, nefandezze e morsi di Stavrogin) e sfocia nel mensuror ergo non sum (il suicidio di Stavrogin).
Dopo qualche necessaria precisazione, tento di mappare un territorio completamente inesplorato, cioè l’applicabilità del dispositivo disortopneumatologico a quell’alterità che è addirittura oltre il semplice altro da sé: bambini, jurodivye (individui in bilico tra follia e santità) e, nello specifico, animali.
Teniamo ben presente che, nell’opera di Dostoevskij, se le pagine di più alta ispirazione metafisica sono dedicate alla riduzione sistematica dell’altro (Leggenda del Grande inquisitore, programma di riforma sociale di Sigalev, messianismo slavofilo reazionario di Satov) e a quelle particolari patologie dialogiche del sé che sono lo sdoppiamento di sé (Ivan e il Diavolo), l’annidarsi dell’altro travisato nel sé (Memorie dal sottosuolo), la rivolta dell’arbitrio deicida contro il sé (Kirillov); se le pagine di maggior impeto passionale e coinvolgente turbine emotivo sono costituite dalle indimenticabili scene corali scandalose (compleanno della Filippovna con i centomila rubli bruciati; Generalessa Epancina, nichilisti e principe Myskin nel portico della dacia di Lebedev; salotto di Varvara Petrovna dopo la messa; Fedor Pavlovic e figli prima dallo Starets poi alla mensa dell’Igumeno); quelle più struggenti, commoventi e partecipate sono dedicate agli animali (spesso in correlazione non casuale con i bambini) – la qual cosa è già ictu oculi sintomaticamente significativa.
Pneumatologia versus psicologia
Dostoevskij considerava la lettura psicologica delle dinamiche interiori dei suoi personaggi un tradimento e che colse più volte l’occasione per precisarlo, ci basterà in proposito la sua celebre interpretazione autentica epistolare: «voglio trovare l’uomo nell’uomo… mi chiamano psicologo: non è vero! Io sono solo realista nel senso più alto, cioè raffiguro tutte le profondità dell’anima umana». Da qui l’insistenza ad esempio di Igor Sibaldi, Luigi Pareyson e di Berdjaev (prima di loro) per una lettura squisitamente «pneumatologica». Non reazioni psicologiche ma tragici destini dell’anima occidentale, lui dipinge. Non in «sensi di colpa» consiste il castigo di Raskol’nikov, si tratta piuttosto di putrefazione e di necrosi spirituale. (Per un esempio classico di arida interpretazione psicoanalitica rimando al celebre, per quanto datato, Dostoevskij e il parricidio di Freud).
Cosa pensasse l’autore della psicologia (e quanto la deprecasse e considerasse pericolosa) lo si ricava facilmente dai discorsi e dalle invettive di Mitja Karamazov in carcere su Rakitin e su Bernard, dal progetto rivoluzionario di Petr Verchovenskij nei Demoni, dalle arringhe degli avvocati nel processo che chiude i Karamazov (mettere in bocca a Dostoevskij le parole dei suoi personaggi è sempre un errore, a meno che non sia lui stesso a dare indicazioni inequivoche in proposito). La psicologia per lui è una delle tante forme del riduzionismo e in ultima analisi del nichilismo.
Le patologie dialogiche del sé, la malattia contratta nel rapporto con l’altro disconosciuto e la guarigione
Dostoevskij vuole trovare «l’uomo nell’uomo» – dove cercarlo? Dal suo punto di vista non esiste nulla di simile a «l’uomo-monade»: l’uomo si realizza ed «esiste» autenticamente solo nel rapporto con l’altro da sé, da qui la celebre critica di Bachtin (Dostoevskij, poetica e stilistica, Torino, Einaudi, 2002) che parla dell’uomo nei romanzi dello scrittore russo come di «essere eminentemente, ontologicamente, dialogico». É solo nel dialogo con l’altro da sé che l’uomo mostra il suo vero volto e questa concezione ha forti ripercussioni sul piano stilistico, estetico e teorico: viene superato il romanzo – e quindi il personaggio – monologico, in favore di quello polifonico.
Quando il rapporto tra sé e altro da sé esce dai binari del riconoscimento del valore nell’altro, della dignità e della libertà altrui, la relazione sé/altro entra in una fase patologica. L’uomo, ammalato nella sua dimensione più radicale, quella dialogica, inizia a deflagrarsi nel profondo, ad autonullificarsi, a diventare subumano.
Se questo processo di sgretolamento progressivo non viene arrestato – il che è difficilissimo – la malattia porta alla morte: in Dostoevskij non c’è vera distinzione tra malattia fisiologica, mentale, esistenziale e metafisica (si pensi oltre che a Raskol’nikov anche a Ivan, a Kirillov, a Nastasja Filippovna, a Ganja Ardalionovic, a Stepan Trofimovic, al Generale Ardalion Ivolgin, a Svidrigailov, a Marmeladov, a Smerdjakov).
Rodion è uno dei pochi che si salva. La sua salvezza avviene nuovamente sul piano relazionale/dialogico: l’unico possibile, nell’incontro autentico con Sonja Marmeladova. Lei può guarirlo perché ha fatto il percorso inverso al suo: non l’arbitrio del volo ergo possum, non la riduzione dell’altro, ma il martirio, lo svilimento e il sacrificio di sé, nella prostituzione, allo scopo di salvare l’altro da sé: i suoi fratellini che muoiono di fame, suo padre alcolizzato, la sua matrigna impazzita per il dolore. Vedremo poi come in verità Sonecka sia condizione necessaria ma non sufficiente per la guarigione
In apparenza solo altri tre soggetti si salvano: Mitja Karamazov, lo Starets Zosima e il fratello maggiore dello Starets Zosima. Ma Mitja non s’ammala mai cronicamente, in lui pulsa il cuore vigoroso e salvifico del popolo russo, scorre il sangue caldo del genio contadino, incorruttibile perché saldamente ancorato alla santa madre terra. Zosima si salva, sì, ma perché diventa un santo: la via della santità è la via stretta, eccezionale, che può essere percorsa da pochi, è la via degli eletti, sbarrata e inaccessibile per l’uomo comune. Il fratello dello Starets guarisce nell’estasi mistica cantando lo splendore del Cantico delle creature, ma lo fa morendo adolescente.
L’unico che sfugge veramente alla morte una volta intrapresa la via patologica è Raskol’nikov. A nulla vale l’acuta e geniale mente di Ivan Karamazov, l’eroe intellettualmente più dotato; a nulla valgono per Stavrogin, l’eroe dall’energia più poderosa, i doni elargitigli dalla natura a piene mani (fascino, bellezza, carisma manipolatorio, forza e resistenza inaudite, ingegno multiforme e penetrante).
Gli altri con plus di alterità
Tutti gli studi più interessanti su Dostoevskij analizzano il rapporto sé/altro, ma non elaborano in maniera compiuta e sistematica il concetto di «patologia dialogica del sé» né quello di «guarigione», inoltre delimitano il tema dell’alterità al solo essere umano adulto. Questa restrizione del campo d’analisi non permettere di mettere a fuoco il tema in Dostoevskij in tutta la sua pienezza e originalità.
Il discorso su bambini e jurodivye merita un approfondimento separato. In questa sede saranno sufficienti due precisazioni:
Bambini: la nostra sensibilità plasmata dal ‘900, «secolo del fanciullo e della pedagogia», non ci permette di renderci effettivamente conto di quanto in passato (e anche oggi in non poche zone nel mondo) il bambino fosse pensato in maniera completamente differente: ridotto a un «non ancora adulto» incapace, inaffidabile, demente, privato del suo sé autentico e visto come un improduttivo, stupido, essere umano potenziale. Un tipico altro da sé con plus di alterità, svilito e incompreso.
Jurodivye: è un antichissimo termine russo che identificava individui in bilico tra la santità e la follia. Se prevaleva il primo elemento avevamo un «profeta-mendicante», se al contrario prevaleva il secondo avevamo strambi, «urlone», minus habens, pazzi. Questi soggetti erano trattati con il massimo rispetto e compassione, venivano adottati dai paesi e dalle città. Oltre che al profondo spirito solidaristico-religioso della Russia rurale, questo comportamento caritatevole era dovuto a una precisa pietas risalente ai «profeti danzanti» (ad esempio: Samuele, 1, 10) del Vecchio Testamento e a un’accezione letterale dei vv. 18 e sgg. della Prima lettera ai Corinzi: «poiché la parola della croce è follia…»
Gli animali
Veniamo agli animali in Dostoevskij. Mi limito a due esempi esplicativi e macroscopici: l’incubo del cavallino picchiato a morte di Rodion in Delitto e Castigo e la malattia di Iljusecka nei Karamazov.
Raskol’nikov e la cavallina: Rodion è malato, per salvarlo saranno necessari due martirii: quello consumato di Sonja e quello sventato di Dunja. Saranno necessari il tenero amore materno e quello sano e robusto di Razumichin. Sarà necessaria l’orribile identificazione con Svidrigailov, prima del suo suicidio. Ma tutto questo non basterà.
La guarigione inizia ed è resa possibile da un’illuminazione: l’illuminazione appunto dell’altro da sé con plus di alterità come valore indisponibile; è resa possibile dalla sofferenza del cavallo, dalla compassione per il cavallo.
Il sogno di Raskol’nikov: Ecco il sogno che fece: lui e suo padre camminano lungo la strada che porta al cimitero e passano davanti alla bettola; egli tiene il padre per mano e si volta timorosamente a guardare la bettola. Una circostanza speciale attrae la sua attenzione; sembra che là dentro, ora, ci sia una festa, con una folla di mogli di piccoli commercianti e artigiani, tutte agghindate, e di contadine con i loro mariti, e con ogni sorta di gentaglia. Sono tutti ubriachi, tutti cantano canzoni, e vicino all’ingresso della bettola c’è un carro da contadino, uno strano carro; uno di quei carri a cui si attaccano grossi cavalli da tiro e che servono al trasporto di merci e botti di vino. A lui era sempre piaciuto guardare quelle enormi bestie da tiro, con le loro lunghe criniere e le loro zampe massicce, andarsene tranquille, con passo cadenzato, tirandosi dietro un’intera montagna di roba senza il minimo sforzo, come se con il carro dietro si sentissero perfino più leggere. Ma ora, strano a dirsi, a un così pesante carro era attaccata una piccola e magra rozza cavallina, color baio chiaro, una di quelle che – come spesso aveva visto – non ce la fanno, a volte, a tirare un carico di legna o fieno, specialmente se il carro affonda nel fango o in un solco della strada; e i contadini le frustano con incredibile violenza, a volte perfino sul muso e sugli occhi, e lui ne provava tanta ma tanta pena, che per poco non piangeva, e la mamma, allora, doveva allontanarlo dalla finestra. Ma ecco, improvvisamente, un gran baccano: dalla bettola escono tra grida e canti, con le loro balalajke, ubriachi fradici, contadini ben piantati dalle camicie rosse e azzurre, il gabbano gettato sulle spalle: «Montate, montate tutti!» grida uno di loro, un giovane, con il collo taurino e il volto carnoso, rosso come una carota. «Vi porto tutti a casa, accomodatevi!» Ma subito echeggiano risate e proteste: «Ma dove vuoi che ci porti questa vecchia rozza?»
[…]
«Montate, vi porto tutti a casa!» grida di nuovo Mikòlka, e saltando per primo sul carro afferra le redini e si erge a cassetta in tutta la sua statura. «Il baio è andato via l’altro giorno con Matvèj,» grida dal carro, «e questa cavallina, miei cari, mi fa proprio morire: quasi quasi vorrei ammazzarla, tanto mangia il mio frumento a sbafo. Su, sedetevi! La metterò al galoppo! Vedrete come galopperà!» e piglia in mano la frusta, accingendosi, tutto felice, a frustare la bestia.
«Ma sì, coraggio, montiamo!» sghignazzano dalla folla. «Lo hai sentito, si andrà al galoppo!»
[…]
Tutti salgono sul carro di Mikòlka tra scherzi e risate. Sono già saliti in sei, e c’è ancora posto. Pigliano con loro una contadina, grassa e rubiconda. Ha una veste di cotonina rossa, una cuffia con le perline di vetro e zoccoli ai piedi; schiaccia nocciole con i denti ridacchiando. Anche tra la folla, intorno, si ride; e, del resto, come non ridere? Una cavallina così malandata, mettersi al galoppo con un simile peso! Subito due giovanottoni, sul carro, afferrano la frusta per dare una mano a Mikòlka. Si sente un «su-u!» La rozza ce la mette tutta ma, altro che galoppo! riesce a malapena a spostare il carro, non fa che agitare le zampe, gemere e rattrappirsi sotto i colpi delle tre fruste, che le piovono addosso come una gragnola. Sul carro e tra la folla raddoppiano le risate, ma Mikòlka si arrabbia: tutto furioso, fa piovere sulla cavallina colpi sempre più fitti, come se credesse davvero di farla partire al galoppo.
«Fatemi posto, ragazzi!» grida dalla folla un giovanotto che ci ha preso particolarmente gusto.
«Monta! Montate tutti!» urla Mikòlka. «Vi deve portare tutti. La frusterò a morte!» E frusta, frusta, e per la gran furia non sa nemmeno più con che cosa picchiarla.
«Babbo, babbino,» grida il bambino al padre, «babbo, che cosa fanno? Babbo, picchiano quel povero cavallino!»
«Andiamo, andiamo!» dice il padre, «sono ubriachi, se la spassano, quelle carogne: andiamo via, non stare a guardare!» E vorrebbe portarlo via, ma lui si strappa dalle sue braccia e, fuori di sé, corre verso il cavallino. Ma il povero cavallino, ormai, è allo stremo. Ansima, si ferma, dà di nuovo uno strattone e per poco non cade.
«Frustiamolo a morte!» grida Mikòlka«Lo farai fuori!» grida un terzo.
«Sono affari miei! È roba mia! Faccio quel che voglio! Montate ancora! Montate tutti! Voglio vederlo galoppare e basta!…»
A un tratto si leva una salva di risate che copre ogni altro rumore: la cavallina non sopporta più quei colpi così fitti e, impotente, comincia a scalciare. Perfino il vecchio non può fare a meno di sorridere. Una bestia così malridotta, ecco che si mette a sparar calci!
Due giovanotti della folla ti pigliano anch’essi una frusta per uno e corrono presso la cavallina per frustarla sui fianchi: uno da una parte, uno dall’altra.
«Dagli sul muso, sugli occhi, sugli occhi!» grida Mikòlka.
«Una canzone, ragazzi!» grida qualcuno sul carro fra il consenso generale. Si leva nell’aria una canzone sfrenata, accompagnata nei ritornelli da fischi e dal suono del tamburello. La contadinotta schiaccia nocciole coi denti e ridacchia sempre.
Il bambino accorre verso la cavallina, corre più avanti e vede come la frustano sugli occhi, dritto sugli occhi! Allora piange: il cuore gli si gonfia e colano le lacrime. Uno di quelli che si accaniscono sulla bestia gli sfiora con la frusta il viso, ma lui non sente; si torce le mani, grida, si slancia verso il vecchio con i capelli e la barba bianca, che sta scuotendo il capo perché disapprova tutto questo. Una donna lo prende per un braccio e vuol condurlo via, ma lui si divincola e corre di nuovo verso la cavallina, che è già ai suoi ultimi sforzi, eppure ancora una volta si mette a scalciare.
«Che ti venga un colpo!» esclama Mikòlka, fuori di sé per la rabbia. Getta la frusta, si china e tirata su dal fondo del carro una lunga e grossa stanga, l’afferra con tutt’e due le mani e l’alza a fatica sopra la bestia.
«Ora la fa in pezzi!» gridano intorno.
«L’ammazza!»
«È roba mia!» urla Mikòlka, e con tutto lo slancio di cui è capace fa ricadere la stanga. Si sente un tonfo sordo.
«Frustatela, frustatela! Perché vi siete fermati?» si levano voci dalla folla.
Mikòlka, intanto, brandisce un’altra volta la stanga, e un altro colpo piomba sul dorso dell’infelice rozza che si accascia con tutto il deretano, ma subito balza di nuovo sulle zampe e tira, tira con le sue ultime forze ora di qua, ora di là, per smuovere il carro. Ma da ogni lato le arrivano addosso sei fruste, mentre la stanga si solleva e ricade per la terza volta, poi per la quarta, con ritmo regolare, con slancio. Mikòlka è furioso perché non è riuscito ad accopparla con un sol colpo.
«Ha la pelle dura!» gridano intorno.
[…]
«Che ti venga il cancro! Fate largo!» si mette a urlare come un pazzo Mikòlka; getta via la stanga, si china di nuovo a cercare nel carro e tira su una spranga di ferro. «Attenzione!» grida, e molla con tutta la sua forza un gran colpo al suo povero cavallino. Ecco, il colpo è partito; la bestia barcolla, si accascia, fa come se volesse ancora tirare, ma la sbarra le ricade sul dorso ed essa stramazza a terra, come se le avessero tagliato tutte e quattro le zampe d’un sol colpo.
«Finitela!» grida Mikòlka, mentre balza giù dal carro, completamente fuori di sé. Alcuni contadinotti, anch’essi rossi e ubriachi, afferrano quel che gli capita sotto mano, fruste, bastoni, la stanga, e corrono verso la cavallina ormai sul punto di crepare. Mikòlka si mette di fianco e continua a menarle inutilmente altri colpi sul dorso. La rozza allunga il muso, emette un pesante sospiro e muore.
«L’ha proprio fatta fuori!» gridano nella folla.
«È roba mia!» urla Mikòlka, con la spranga in mano e gli occhi iniettati di sangue. Sta lì, e sembra scontento di non aver più nessuno da picchiare.
«Davvero non sei cristiano!» gridano numerose voci dalla folla.
Il bambino, ormai, non sa più quello che fa. Gridando si fa largo tra la folla, si avvicina alla bestia morta, ne cinge con le braccia il muso insanguinato e la bacia, la bacia sugli occhi, sulle labbra… Poi, d’un tratto, balza in piedi, e fuori di sé si slancia con i piccoli pugni alzati contro Mikòlka. Proprio in quel momento il padre, che già da un pezzo lo rincorre, finalmente lo acchiappa e lo conduce via dalla folla.
«Andiamo! Andiamo!» gli dice, «andiamo a casa!»
«Babbo! Ma perché… hanno ammazzato il povero cavallino?» domanda singhiozzando, mentre gli manca il respiro e dal petto oppresso le parole gli escono come strida.
«Sono ubriachi, se la spassano, non è roba che ci riguarda, andiamocene!» dice il padre. Il ragazzo lo abbraccia, ma il petto gli si serra, gli si serra sempre di più, vorrebbe tirare il fiato, gettare un grido, e si sveglia.
Si svegliò tutto sudato, con i capelli bagnati di sudore, sentendosi soffocare, e si sollevò pieno di spavento.
[Delitto e Castigo, trad. it. di Matteo Grati, Milano, Baldini & Castoldi, 2009]
Proprio quando Raskol’nikov stava per cadere per sempre nell’abisso senza ritorno della nullificazione, l’illuminazione realizzante della sacralità intangibile della vita nell’altro, nell’animale, gli tende la mano.
Molto altri fattori concorrenti occorreranno per salvarlo, lo abbiamo già detto. E non c’è salvezza senza adeguata espiazione. Rodion confesserà infine l’omicidio e andrà in Siberia ai lavori forzati, ma lo farà essendosi ritrovato, avendo sconfitto le metastasi di quel cancro che è la relazione distorta con l’altro da sé.
Iljusecka e Zucka: Iljusa è un bambino povero, indigente. Vive in un’unica stanza in affitto, buia e laida, con tutto il resto della famiglia. La sorella e la madre sono delle povere infelici, allettate, impedite nei movimenti, semicoscienti e infantilmente lamentose e bizzose. Il padre è ora disoccupato e non ha di che sfamare i familiari. Mitja Karamazov l’ha preso un giorno per la barba, in un osteria, trascinandolo fin in piazza tra le suppliche e le preghiere del figlioletto perché lo risparmiasse.
Iljusecka era un bravo scolaro, prima, aveva anche fatto amicizia con Kolja, un altro studente, più grande, carismatico e sveglio: un capobanda rispettato. Dopo la vicenda del padre umiliato il fanciullo non è più lo stesso, il suo povero orgoglio di bambino è ferito, diventa introverso e aggressivo con i compagni che lo prendono in giro per il padre. Si scatenano risse e sassaiole.
Un giorno Iljusa (dietro suggerimento di Smerdjakov) prepara un bocconcino, ci mette dentro degli spilli e lo lancia a Zucka, un cane di strada abbandonato e mal messo. Zucka lo inghiotte e il bambino scappa. Quando racconta l’episodio a Kolja, questi lo allontana da sé.
Non è solo una questione d’orgoglio: vedere il padre trattato in quel modo ha sconvolto Iljusecka nelle fondamenta, non si riesce a dar pace, il suo cuoricino sanguina. Impossibile qui ricostruire la sua tempesta interiore.
Come a somatizzare il trauma, il bambino si ammala. I dottori non riescono a capire nulla, non sono in grado di curarlo. Tutti credono che dipenda esclusivamente dalla violenza di Mitja sul padre, ma nel suo delirio il bimbo continua parlare di Zucka, di aver ucciso Zucka e a piangere. Grazie all’intercessione di Alesa Karamazov le condizioni materiali della famiglia migliorano e tutti i compagni vanno a trovarlo. Ma lui non guarisce, peggiora; e il suo pensiero fisso è Zucka. «Sono malato papà, perché quella volta ho ucciso Zucka ed ora Dio mi punisce» ripete all’infinito tra i sudori delle febbri.
Iljusecka sta infine morendo, quando del tutto inaspettato si presenta a casa sua Kolja con un cane, Perenzvon. Nell’agonia il bimbo capisce che Perenzvon altri non è che Zucka: il suo vecchio amico Kolja l’ha cercato per settimane e infine è riuscito a trovarlo, vivo, e l’ha portato a lui per una sorpresa.
Iljusecka muore, ma riconciliato con se stesso. Zucka vive e questo era il suo unico e ultimo desiderio.