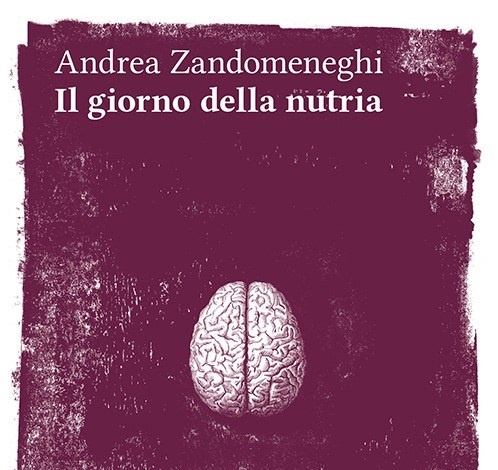Andrea Zandomeneghi: Grazie Giordano di aver accettato di prendere parte a questo piccolo colloquio con me e Alfredo Zucchi.
Tabù e I segnalati, quale dei due romanzi è più importante e perché secondo te? Più importante dal punto di vista del tuo percorso autoriale, ma anche più importante dal punto di vista della nostra letteratura nazionale.
Giordano Tedoldi: Sulla questione dell’importanza nella nostra letteratura nazionale, pudicamente mi sottraggo alla risposta. La stessa questione, del resto, sembra particolarmente adatta a suscitarmi mai sopite insofferenze: qual è questo punto di vista? A chi appartiene? Se mi si risponde che il punto di vista “della nostra letteratura nazionale” è il mio, devo rispondere che io non ho alcun concetto chiaro – sciorinabile in un canone, in un elenco che abbia anche, magari, una corrispondenza con una determinata visione culturale – della nostra letteratura nazionale, e che non sento alcuna esigenza di farmelo. Se mi si risponde che tale punto di vista è quello espresso, saltuariamente, a volte con passo esitante altre con impettito marciare, da altri scrittori o critici, rispondo, un po’ a brutto muso: fatevi le letterature nazionali vostre che io mi faccio la mia. Quanto all’importanza dei miei due romanzi per me, cosa posso dire se non la banalità che non reputo l’uno più importante dell’altro e che, nemmeno all’interno dei miei testi, oltre una certa soglia di valore (escludendo dunque le cose malriuscite, o incompiute, o immature) faccio gare? Se lo scarto fosse quello tra la prima sinfonia di Mozart e la Jupiter, potrei effettivamente dire con sicurezza che preferisco la Jupiter. Ma poiché non mi sembra esserci, tra “I segnalati” e “Tabù” un simile abisso, ed anzi tendo a considerarli, per proseguire con la stirata similitudine, due sinfonie contigue, non posso dirlo.

Andrea Zandomeneghi: Perfetto, assolutamente legittimo da parte tua sottrarti pudicamente alla domanda relativa alla collocazione nella letteratura nazionale; aggiungo, per i nostri lettori, che la redazione di Crapula (rectius: Antonio Russo De Vivo) – nella sua sfacciataggine malandrina e probabilmente sciocca – tempo fa ha deliberato l’inserimento de I segnalati nel proprio ristrettissimo (e necessariamente arbitrario) Canone della letteratura italiana a partire dall’anno duemila (i classici italiani del nuovo millennio) con la seguente motivazione: “perché c’è morbosità, c’è ambiguità sessuale; perché la storia di giovani alla deriva è accompagnata da musica classica di cui si parla con sapienza; perché ogni frase, ogni dialogo confermano il talento dell’autore; perché il talento non si compiace di sé”.
Io però non t’ho chiesto quale dei due romanzi è più importante – da intendersi magari come “bello”, “riuscito”, “realizzante” – per te come in una gara tra opere, in un’infantile ottica statica e agonistica; ma al contrario – dinamicamente – nel tuo percorso di autore, considerando i due testi come due pietre miliari del tuo sviluppo umano, artistico e intellettuale: ammetto la puerile formulazione del quesito, al contempo ti faccio notare che il Tedoldi che scriveva I segnalati anni fa non può essere lo stesso Tedoldi che poi ha poi scritto Tabù, non può esserlo in rerum natura – scrive Cartarescu (lo riporto nella speranza di riuscire a ridurre il margine di equivocità delle mie parole): “Poiché non è descrivendo cose andate che si scrive il passato, ma parlando dell’aria nebbiosa che da esso ci separa; del malinteso che regna fra il mio animo di adesso e quello di un secondo fa, e quello di dieci anni fa. Quando penso a me stesso in età diverse, ossia ad altrettante vite interiori consumate, è come se parlassi di una di una serie ininterrotta di morti, di un tunnel di corpi che muoiono uno dentro l’altro”. Vorresti parlarci di come era – chi era? – quel Tedoldi de I segnalati, di quali istanze lo abitavano, di cosa si aspettava dalla scrittura e da se stesso nella e con la scrittura? Vorresti parlarci di come è cambiato nel tempo, di come poi è diventato alla luce delle esperienze, delle ingiurie e dei fasti degli anni, in rapporto alla propria percezione del romanzo, alla propria scrittura, alla relazione tra vita (ciò che primariamente esperisco) e opera (ciò che primariamente restituisco)?
Giordano Tedoldi: Messa così, sul piano esistenziale, la questione sembra semplificarsi, ma forse invece si complica. L’immagine di Cartarescu è suggestiva, ma come mi pare di poter dire dal ben poco (rispetto alla sua imponente produzione) che ho letto di questo esuberante scrittore, un poco incerta e sbrigativa sul piano del rigore speculativo; mi sembra solo rinviare il paradosso della memoria: dalle cose passate, al mezzo – l’aria nebbiosa – che da quelle ci separa, e che pure però, questo mezzo, rispetto a noi deve essere passato, o comunque distinto, e quindi non essere a noi presente e tantomeno in noi presente, e quindi, a suo modo, anch’esso passato. Voglio dire, uscendo da labirinti dialettici, che non è impresa da poco dire “chi ero” al tempo della scrittura de “I segnalati”, né tentando di fissare com’ero allora, né, cosa che come ho tentato di spiegare non cambia in effetti nulla, parlando della nuvolaglia che da quel passato mi separa, e che pure non coincide con me, ed è dunque anch’essa prima di me esattamente come quelle cose passate. Abbandonando dunque aporetiche pretese di descrizioni dinamiche degli anni trascorsi da allora, posso semplicemente restituire alcuni ricordi fotografici, impressioni di stati emotivi di allora, e dunque dire che “I segnalati” è stato scritto sotto un alone di vergogna, ansia, debolezza, fragilità che difficilmente avrei potuto esprimere più compiutamente che in quell’opera. In un certo senso, penso a quel romanzo come al giorno in cui un paziente abbastanza gravemente ammalato per via di pensieri fissi e ossessioni paralizzanti va dal suo psichiatra o psicoanalista (forse meglio) e nella seduta trova la chiave, immaginativa e verbale, per dichiarare efficacemente e compiutamente la sua condizione. Il che non lo salva, ma perlomeno indica – segnala – ciò con cui egli stesso, oltre che il suo medico, si devono confrontare. Questa è solo un’analogia per parlare di chi ero allora, di come mi sentivo scrivendo quel libro, e naturalmente molte altre emozioni e pensieri ne esulano, ma sostanzialmente direi che l’immagine è fedele. Con “Tabù”, che è nato persino con intenzioni comiche, poi, come si può vedere, tradite, perlomeno tradite se si sta a una definizione standard del comico, la differenza è dunque enorme. L’idea del divertimento, scrivendo i “Segnalati” non mi ha quasi mai sfiorato; in “Tabù” mi ha accompagnato anche quando l’iniziale proponimento comico era palesemente deragliato. Infine, per infastidire ulteriormente il lettore con i miei prediletti parallelismi ispirati ad Euterpe, direi che “I segnalati” si svolge come un dramma musicale prevalentemente incardinato nella tonalità di re minore, mentre “Tabù” assomiglia a una fuga in si bemolle maggiore.

Andrea Zandomeneghi: Cosa pensi di ciò che nel 1919 Bachtin scrisse in Arte e responsabilità: “Di ciò che ho vissuto e compreso nell’arte, io devo rispondere con la mia vita, perché tutto ciò che è stato vissuto e compreso non rimanga in essa inattivo”?
Giordano Tedoldi: Che è una frase piuttosto banale e vacua, se suppongo di averla capita; se invece non l’ho capita, com’è probabile, mi è appunto oscura.

Andrea Zandomeneghi: Quali sono e come si articolano le tue posture artistiche e intellettuali in relazione al morboso?
Giordano Tedoldi: Una certa consentaneità e congenialità alla categoria del “morboso” mi è stata attribuita presto e, poi, con una certa ricorrenza, ma devo confessare, a costo di passare per falso ingenuo, che mi è sempre sembrato che altri volessero far corrispondere a un loro ben stereotipato concetto del “morboso” quanto leggevano nelle mie pagine, mentre io quel loro repertorio di immagini, letture, e altri materiali “morbosi” o non lo conoscevo, o non lo condividevo, o se lo conoscevo non lo tenevo isolato nel rassicurante e un po’ sciocco contenitore degli svaghi “malati”. Cercando di approfondire: non solo non scrivo per temi isolati, per argomenti giustapposti come formelle, ma non scrivo nemmeno per emozioni isolate, o per classi psicologiche isolate. Il mio modo di scrivere si basa su variazioni di intensità di un materiale di fondo che a me sembra (e devo dire, è) omogeneo dal principio alla fine, non su variazioni di qualità: scena sana, scena morbosa, scena realistica, scena visionaria. Dunque la risposta più adeguata, se proprio vogliamo insistere sulla categoria del “morboso”, è che essa rientra ed è in tutto determinata dalla mia gestione delle intensità, e non è “il morboso” a determinare alcunché.
Andrea Zandomeneghi: Visto che rispondi «io quel loro repertorio di immagini, letture, e altri materiali “morbosi” o non lo conoscevo, o non lo condividevo, o se lo conoscevo non lo tenevo isolato nel rassicurante e un po’ sciocco contenitore degli svaghi “malati”»; la farò molto semplice, ponendoti due domande estremamente lineari: cosa è e come è secondo te il morboso, come categoria fenomenologica generale? Cosa è e come è secondo te il morboso in letteratura? Potresti infine indicarmi alcune opere e/o autori nei quali è possibile riscontrare un forte tasso di morbosità per come tu la intendi?

Giordano Tedoldi: Poiché non credo, come ho detto, di avere un interesse specifico per la categoria del “morboso” non posso dire cos’è per me, come elaborazione personale, ma solo cosa mi sembra essere, in generale, nell’analisi psicologica e nei testi, visto che questo mi chiedi. Facendo alcuni esempi. Senz’altro il morboso è il rimosso, nel senso psicoanalitico del termine. “La disubbidienza” di Moravia, l’unico testo che ho letto dello scrittore romano, e che mi è piaciuto, direi che rientra in questa concezione freudiana del morboso, anche se non mi è piaciuto per questo, ma perché, per parafrasare Dirac, è un racconto che “ha lo stesso livello di precisione in ogni punto” (la frase di Dirac, riferita a un dipinto impressionista, era ben più brillante: «Mi piace perché ha lo stesso livello di imprecisione in ogni punto»). In altro senso “il morboso” lo si ritrova ad esempio in Kafka, come contatto, incisione impudica tra spirito e materia, tra logos e creaturalità. L’uomo stesso, come fango vivente, instabile, trasformantesi, squassato da sferzate di un ineffabile agente, è, nei testi di Kafka, una vista che suscita imbarazzo, pietà, crudeltà: tutti sintomi ed effetti del morboso.

Andrea Zandomeneghi: Quali sono e come si articolano le tue posture artistiche e intellettuali in relazione al sacro?
Giordano Tedoldi: Qui la risposta è molto semplice e drastica: non credo al sacro. Nemmeno alla sacralità, va da sé, del blasfemo, dell’immondo, degli ultimi che saranno i primi. La mia posizione di fronte a chiunque ambisca a ripristinare qualunque forma di metafisica è quella del rifiuto. Un tempo si muoveva con successo, a costoro, l’accusa di “irrazionalismo”, e un po’ rimpiango quel tempo. Naturalmente poi, ma qui dobbiamo solo intenderci sull’uso delle parole, possiamo dire di “venerare” una donna, di avere un sentimento di “sacro rispetto” o altre espressioni del genere, ma non credo che la domanda volesse chiarire aspetti così triviali. Quanto invece alla presenza di luoghi, oggetti, persone sacre all’interno dei miei libri, questi non hanno nulla a che fare con la metafisica o con la religione, ma con l’arte. Sono miscredente e resto egualmente stupefatto, oserei dire schiacciato dalla Maestà di Simone Martini o dalla Messa in si minore di Bach. Ho conosciuto atei che non riuscivano ad apprezzare opere nate da e per un contesto religioso, e ho pensato che la loro esigenza di purezza, benché capovolta, dovesse essere per loro insidiosissima, di certo non meno del crocifisso.

Andrea Zandomeneghi: Hai perfettamente ragione, dobbiamo intenderci sull’uso delle parole e aggiungerei sull’uso dei concetti. Parlando di sacro non mi riferivo neppure lontanamente alla fede ma a quell’immaginario – proprio dell’antropologia e della storia delle religioni, ma ormai più in generale della nostra cultura umanistica occidentale condivisa – ricchissimo (senza ora mettersi a tirare in ballo Eliade, Kerényi, De Martino, Klossowski, Calasso e compagnia bella) fatto di miti, riti, simboli, luoghi, soggetti. Nella tua opera tutto ciò è assai frequente, spero che non mi costringerai a dover elencare il materiale in questione a partire dalla statua di Emilia, la chiesetta sul mare, i vari sacerdoti (uno dei quali è addirittura io narrante e quindi filtra il narrato con la sua peculiare coscienza e psicologia, cosa che viene anche esplicitata). Dato che non vuoi parlare di sacro, cercando di evitare anfibologie, sarà bene riferirsi alle concrete ierofanie (per me che sono ateo un crocifisso non è nulla di significativo, né di sacro, né di spirituale, ma è culturalmente una ierofania, come è ierofania l’occhio di Horus o la detronizzazione di Crono) – quale è la funzione, quale la ragione, quale lo scopo (possono benissimo essere puramente estetici o estetizzanti, questo non lo so) della fitta – martellante! – presenza di ierofanie in Tabù e ne I segnalati?
Giordano Tedoldi: Le “ierofanie” – adotto il termine purché sia chiaro che non si sottintende alcunché di miracoloso nella loro apparizione – nei miei romanzi sono “solo” effetti. O se preferisci, segnali. Indicano. Che poi lo facciano in modo improntato a particolare solennità o enigmaticità o misteriosità, sarà paradossale da parte mia confessarlo, conta poco, o meglio conta perché quella solennità o enigmaticità o misteriosità anch’esse svolgono il compito dell’indicare; nello specifico, indicare la loro stessa peculiarità in quanto indicatori. Ma cosa indicano così peculiarmente? Forse il Dio? L’Ente supremo rispetto al quale l’uomo non può che essere inferiore ed assoggettarsi, umiliarsi in un rapporto di tale sproporzione che non è nemmeno misurabile? Nego, perché questo è proprio quel sacro in cui non credo. La statua di Emilia non rinvia alla Dea o Deessa Emilia, ma alla donna Emilia. Rinvia a un’assenza? Certamente, come ogni segnale rinvia a un altro da sé con cui è variamente in rapporto. Ma allo spettro estremo dell’enigmaticità dell’assenza, non c’è necessariamente il sacro; anche questo, lo nego. Anzi, il sacro è proprio la negazione rassicurante, o l’iperbole idealizzante, e dunque svisante, dell’enigma. Qui – nemmeno nella figura di padre Eusebio, a ben vedere – non si respira mai quel peso metafisico, ma dagli effetti fin troppo materiali, che schiaccia la creatura al cospetto del suo creatore. Varie volte, al contrario, nell’illusione prospettica, pare addirittura che il tradizionale, e sacro, rapporto sia invertito, e il (presunto) creatore sia sottomesso alla (non meno presunta) creatura, ai suoi scarti, ai suoi strappi. Ripeto: le ierofanie stanno all’intersezione di enti e forze che nulla devono all’invisibile, all’ineffabile, al mistico. Eppure perché questi “nodi” sono intrecciati in forme diverse dai normali raccordi, per dir così, non ierofanici? La mia risposta è che la “ierofania” indica (o esprime) l’esperienza – umana, non metafisica – di essere entrati in contatto con persone, cose, che pur incluse nel mondo naturale di persone e cose, senza alcuna ombra di misticismo dunque, non possono rivelare il segreto per il quale sono quello che sono: non possono essere spiegate quanto alla produzione dei loro effetti. Per, appunto, spiegarmi, faccio l’esempio della poesia. Cos’è la poesia? Come sprigiona la poesia la sua poeticità? Non è possibile rispondere direttamente alla domanda, per la semplice ragione che la poesia è la poesia, bisogna leggerla, passare attraverso quella determinata scansione e ordine delle parole, e qualunque discorso che da esso si discosti non è più poesia. Si potrà dire qual è il significato di una poesia, cosa descrive, parafrasarla, individuare da cosa ebbe origine in senso materiale e concettuale, ma purché si sia consapevoli che con ciò non si rispecchia nemmeno in minima parte la poesia, le si gira attorno senza, direi, nemmeno sfiorarla. Cioè non si potrà mai spiegare perché una poesia comincia con quella prima parola seguita da quella seconda parola e via di seguito intessendo la poesia stessa. Lo si può spiegare tecnicamente in generale, in un modo miseramente combinatorio, ma non in quell’intreccio necessitante – o se si vuole, casuale eppure non arbitrario – di quella determinata parola seguita da quell’altra determinata parola, e così via. Analogamente si può dire dell’amore, come quello di Piero per Emilia. Perché Piero è innamorato di Emilia? Non si può dire, perché la risposta è l’amore stesso da cui la domanda nasce. Si potrà dire che significato ha l’amore di Piero per Emilia, parafrasarlo come fosse una poesia, criticarlo, raccontare il giorno in cui è sbocciato o finito ma non entrare nell’amore in sé. Ma questo mistero non ha nulla di sacro, di metafisico, di irrazionale: così come la poesia è una cosa, una pagina scritta, una recitazione, un mistero in piena luce, così in piena luce è il mistero dell’amore, e della sessualità, verso e con una donna in carne e ossa, come in “Tabù” quello tra Piero ed Emilia. La fusione della Emilia reale e del suo mistero (non mistico, ma in piena luce) induce Piero a esprimere questa, se si vuole, singolarità o irriducibilità del sentimento amoroso nella forma della statua dedicata al suo oggetto, statua dunque profana, addirittura miscredente, ma non per questo meno conturbante.
Alfredo Zucchi: Il caso ha voluto che, dopo aver letto Tabù pochi giorni dopo il Salone di Torino, mi sia immerso di nuovo in Twin Peaks. Ho rivisto la scena della morte di Leland Palmer e il finale di Twin Peaks: Fuoco cammina con me e mi è parso – con molta più chiarezza ora – che la peculiare fuga fantastica adottata da Lynch (e Frost e gli altri autori) sia riuscita a illuminare il tema (l’incesto e l’omicidio del figlio) in modo del tutto inedito: Laura sfugge alla possessione di Bob grazie al gesto del padre.
Hai scritto sopra che Tabù parte con intenzioni comiche, intenzioni poi tradite; hai discusso inoltre delle ierofanie, della loro natura e funzione. Puoi descrivere come hai avvertito mutare la relazione tra il tema del libro e i “segnali” utilizzati di volta in volta – a quali scossoni è stata sottoposta?
Si tratterebbe di una mera misurazione a posteriori – imprecisa e parziale per definizione, ma non per questo meno interessante, almeno per noi che ti leggiamo.
Giordano Tedoldi: Non sono sicuro che l’idea di cominciare a scrivere Tabù con intenzioni comiche non fosse altro che uno stratagemma per iniziare a scrivere. Come ho detto, iniziando a scrivere il romanzo, volevo anche liberarmi dell’angoscia che mi era persino stata funzionale alla scrittura dei Segnalati. Ma se è vero che non avevo intenzione di tornare a quei gelidi climi psicotici (una lettrice molto attenta e molto sensibile mi ha rimproverato l’uso di questo termine in Tabù, lei preferiva “folli”; ma I segnalati pur con tutto il suo alone romantico e postromantico ha una sua brutale oggettività e porta i segni direi persino di uno squallido, concreto realismo, che giustifica l’uso di un termine controverso come tutti quelli afferenti alla sfera clinica specie nel campo dei disturbi mentali, e lo stesso mi pare si possa dire di Tabù) è pure vero che questa bella idea di “voltare pagina” ha inevitabilmente un che di illusorio, di frivolo persino. L’attività letteraria è molto meno un gioco di quel che si crede, e in ogni caso è un gioco non così semplice da cambiare a piacimento o per soddisfare un, in fin dei conti sciocco, desiderio di varietà. Il che non vuol dire che io sia a favore delle scritture seriali, del ripetere più o meno variato lo stesso tema, come mi pare si possa dire abbiano fatto, per citare casi su cui forse ci sarà qualche accordo, Houellebecq o Easton Ellis. (A proposito di questi autori, un inciso curioso: ho cominciato a leggerli credendo fossero due autori di modesta caratura, poi alla lettura ho creduto fossero molto importanti, e ora penso di nuovo che siano di modesta caratura, benché non così modesta come ritenevo prima di leggerli a fondo. Il paragone sarà balzano, ma credo che per la mia generazione abbiano rappresentato qualcosa di simile a Sartre e Camus per le generazioni fiorite attorno alla metà del Novecento, e che come quelli la loro importanza sul piano strettamente letterario sia dopotutto accidentale). Tutto il contrario. Ma credo nell’idea di un’evoluzione, non di una rivoluzione nello stile e nelle opere. E in effetti, scrivendo, non ho provato alcuno scossone, né alcun preciso, chiaro “segnale” o bisogno di modulare Tabù da un piano borghese-comico o brillante o buffo a quello che poi risulta chiaro al lettore alla fine, e che è tutt’altro che comico brillante o buffo. Se posso usare un’immagine, è come quando fissiamo il volto di una persona che ci colpisce per qualche motivo, e ne riceviamo un’impressione. Questa prima impressione è molto forte, ad esempio ammettiamo che ci sia parso di riconoscere dai tratti un carattere aperto ma frivolo, simpatico ma superficiale. A quel punto una conoscenza più approfondita di questa persona può confermare l’impressione e eventualmente far perdere interesse a proseguire “lo studio”, oppure può complicare il quadro, e spostarlo per occupare anche diciamo pure il “negativo” di quella prima impressione, e addirittura l’imprevedibilmente opposto all’interno di quel “negativo”. Un nuovo negativo. Mi spiace per l’immagine scarsamente a fuoco, ma è qualcosa che esprime abbastanza fedelmente come sono andate le cose con la scrittura di Tabù. Si sono profilati come da sé nuovi negativi, che si affiancavano e contrastavano – o per meglio dire, si mettevano in un qualche rapporto, in una qualche successione – con i positivi che avevo prefissato iniziando il lavoro con la costruzione della storia, dei personaggi, e così via. Ecco dunque che lo stato finale di Tabù – e prima di esso, l’itinerario narrativo – non deriva tanto da interventi strumentali, da interferenze univoche e totali, quanto da una continua e stretta osservazione del materiale così densamente molteplice nel suo continuo rivelare il suo positivo e il suo negativo. Ho creduto, questo molteplice, di accompagnarlo alla sua logica conclusione senza forzare riduzionismi, benché ogni conclusione debba, in qualche misura, unificare il quadro. Se posso dire il pregio di questo romanzo e di quello che lo precede, è la sua logica. Perché è una logica che si applica a un’osservazione scrupolosa e ricettiva di quanto vi è di più illogico, cioè di quanto esula dalla mia mente, di quanto proviene evidentemente dal suo esterno, e che non mi sento di dire che coincida esattamente col mondo ma diciamo così con una sensazione primordiale del mondo.

Andrea Zandomeneghi: Ti chiesi tempo addietro: «In questi giorni sto rileggendo Tabù e l’epistolario di Nietzsche e mi sono imbattuto in una cosa su cui mi sto arrovellando: il riferimento al vivere in tre, due uomini e una donna, come assetto ideale in Tabù non può non richiamare – almeno così credo – la “trinità”, “il giardino di Epicuro”, Salomé/Rée/Nietzsche; ora, esiste un documento, si chiama Libro domestico di Stibbe [Stibbe è feudo di Rée]. È un testo di massime di Salomé, con alcune massime aggiunte da Rée e poi le correzioni apportate Nietzsche; sulla prima pagina di quel manoscritto, sta scritto: “PADRE/FIGLIA SORELLA/FRATELLO”. Questo m’ha fatto pensare alla Nota genealogica di Tabù; ti volevo chiedere se c’è correlazione – anche minima, a livello di eco o suggestione – tra le due cose o se sto scavando in una direzione del tutto campata in aria»
Tu rispondesti: «Una correlazione certo c’è, ma devo esserci arrivato per altre strade perché non conoscevo il documento che citi, quanto alla nota genealogica mi è venuta in mente da ambiti piuttosto distanti, anche nel tempo, dalla trinità (fallita) N.S.R. La stretta antropologica di Tabù, in altre parole, mi sembra provenga da un prima di Nietzsche e da un dopo di Nietzsche; è il momento in cui il romanzo se ne allontana di più. Poi è logico che la Trinità anche in N non poteva che fallire, proprio perché struttura contraddittoria rispetto alla sua più intima filosofia. E questo dissidio credo si risenta anche in Tabù.»
Mi piacerebbe che mi spiegassi meglio cosa intendi precisamente – noto che ne son state date molte interpretazioni differenti, anche tra i tuoi recensori – con “La stretta antropologica di Tabù” e con “da un prima di Nietzsche e da un dopo di Nietzsche”.

Giordano Tedoldi: Quello che intendo è che in “Tabù” a un certo momento (molto presto in effetti e, forse, larvatamente, fin dal principio) ho perso interesse, o meglio, ho guidato la narrazione senza procedere lungo linee psicologiche individuali, ma lungo correnti collettive, movimenti di gruppi, clan, stirpi, persino razze. Cinematograficamente si potrebbe dire che, pur avendo a che fare con personaggi singoli, ho lavorato muovendo le masse. La celebre trinità agognata da Nietzsche e dai suoi compagni, e naufragata, aveva senz’altro, anch’essa, come sostrato, un movimento di masse, una qualche velata idea di “razza superiore” se non altro nella forma di “spiriti eletti” che è una forma più aristocratica, e più presentabile, di razzismo. Ora questa idea di una cellula trinitaria in cui impiantare se non una superiorità razziale perlomeno una rigenerata, superiore esistenza collettiva (e queste due fasi in “Tabù” sono accennate, e talvolta equivocamente presenti e compenetrantisi) si ritrova nella trinità nicciana unita al richiamo a un sostrato per così dire “fatale”, cioè di stirpe in cui i membri si riconoscono, si somigliano, si congiungono più o meno promiscuamente, e cui si consegnano; ma laddove questo sostrato, nell’esperimento nicciano, resta implicito e viene distrutto dal conflitto insanabile tra ideale di superiorità individuale, da un lato, e necessità di parità ed eguaglianza che ogni trinità (come ogni sogno di compenetrazione collettiva) implica, dall’altro, in “Tabù” il sostrato emerge in tutta la sua nuda neutralità e per così dire senza scontare contraddizioni teoretiche, è semplicemente un legante, un cemento deprivato di ogni illusione aristocratica. In breve: essere in tre, solo noi tre, non fa di noi tre gli eletti, i migliori, fa solo un piccolo clan e un sistema di determinati asimmetrici rapporti (così come asimmetrico è il triangolo, precedentemente esposto nel romanzo, dell’adulterio). È vero, Piero approda all’idea della “trinità” come a una decisione “fatale” ma perché può ricondurgli Emilia, e farla così sua de jure e de facto. Questa fatalità è governata da quelle leggi naturali, democratiche oserei dire, e tutt’altro che entusiasmanti, che governano tutti i fatti e i diritti non delle razze o dei filosofi della volontà, ma degli uomini, essendo l’umano determinazione ben più generale e significativa di quella di razza o di homo philosophicus. Mi pare che la differenza dal pensiero e dal vissuto di Nietzsche non possa essere più grande.

Andrea Zandomeneghi: Io più che Nietzsche nel tuo romanzo vedo i moralisti francesi, vedo addirittura La Rochefoucauld e soprattutto poi Huysmans – una sfaccettatura di Houellebecq ci sta anche, ma nulla di realmente essenziale. Orecchiando tra le pieghe della tua magnifica voce sento riecheggiare – il che pare assurdo, e nulla esclude che la mia sensibilità sia assurda – più Paolo di Tarso che Nietzsche. Ti vedo molto francese e molto poco tedesco.
Giordano Tedoldi: Qui siamo nel campo della liberta interpretazione del lettore, e davvero non posso intromettermi. Né del resto sarebbe di grande utilità se dicessi quale degli autori che citi ho letto o non letto, o se mi senta più francese o tedesco o cos’altro. L’accostamento a Paolo di Tarso è la prima volta che lo sento, ma prevedo che non sarà affatto il più singolare tra quelli di cui sarò vittima.
Andrea Zandomeneghi: Ci sono tre passaggi del tuo romanzo che ho percepito come forti stonature:
a) certamente la scrittura di Tabù è raffinata, non direi neppure ricercata, direi di classe – classe cristallina in un forbito italiano cristallino; questa tensione stilistica sontuosa – la costruzione di alcuni periodi raggiunge vette assolute – prolassa lessicalmente, arriva a essere strappata da un passo falso (prendo questo come il caso più eclatante e quindi esemplare – da notare che questa tua fraseologia talvolta fallace è caratteristica solo delle prime 35 pagine del romanzo): l’uso della parola “idioletto” – perché voler strafare inciampando? Non avverti anche tu un’eterogeneità nell’ordito che dovrebbe essere iperbolica e funzionale e invece è in odore di ridicolo?
b) vorrei che mi facessi un secondo luce sull’universo semantico, simbolico e narrativo in cui si inserisce la Nota Genealogica, mi risulta indigeribile narratologicamente.
c) mi piacerebbe capire meglio perché hai deciso di introdurre una cosa così peculiare e apparentemente stramba come il liquor filialis. Come deve essere inteso, perché c’è? è un’immagine o un simbolo o entrambi? È surrealismo?
Giordano Tedoldi: Rispondo sinteticamente e un po’ sbrigativamente perché qui mi sembra si tocchino questioni di minore rilievo: a) no. b) la Nota Genealogica è un documento, la sua analisi andrebbe affidata non alla narratologia ma alla diplomatica. c) naturalmente non è surrealismo, corrente artistica dalla quale mi sento lontanissimo. Sull’esempio di Tarkovskij che, richiesto di spiegare cosa fosse la Zona di Stalker, rispose “la Zona è la Zona”, rispondo che il liquor filialis è il liquor filialis.
Andrea Zandomeneghi: Quale è il tuo rapporto con Jung, se ne hai uno?
Giordano Tedoldi: Nessun rapporto, perlomeno nessun rapporto intenzionale.
Andrea Zandomeneghi: Cosa pensi della letteratura italiana contemporanea? Cosa leggi?
Giordano Tedoldi: Leggo innanzitutto i libri di chi mi è vicino, degli scrittori che sono anche i miei amici. Ma come ho già detto in un’altra intervista, non mi piace fare liste di nomi e titoli. Le liste non servono a nulla, in questo ambito. Non ho un’opinione definita della letteratura italiana contemporanea, voglio dire né positiva né negativa dunque. A volte ho provato a domandarmi il perché di questa mia insofferenza a formarmi questi concetti generali, complessivi, queste puntualizzazioni periodiche. L’unica risposta plausibile che mi sono dato è che sono troppo impegnato a occuparmi dei miei libri.
Andrea Zandomeneghi: Quali sono gli autori che t’hanno cresciuto e che t’hanno nutrito?
Giordano Tedoldi: Di nuovo, niente liste.
Andrea Zandomeneghi: E ora? C’è ancora qualche autore che ti nutre sul serio? Chi?
Giordano Tedoldi: Ora, Dante.

Alfredo Zucchi: Lo spirito della musica. Si avverte in Tabù – e in alcune delle risposte di questa intervista – il peso e l’influenza della musica sulla tua scrittura. Hai mai avuto l’ambizione di comporre musica? Se sì, cosa ti ha spinto a metterla da parte in favore della letteratura?
Giordano Tedoldi: Non ho mai avuto l’ambizione di comporre, l’ho fatto per gioco molti anni fa, per mio diletto come si dice. Il mio odio profondo per la mediocrità (parlo solo di mediocrità artistica) ha scongiurato che prendessi la cosa più seriamente. Sicuramente l’influenza della musica sulla mia scrittura è enorme, ma non saprei dire esattamente, perlomeno non adesso, in che termini. A volte penso, non so con quanto fondamento, che ogni scrittore dovrebbe essere un fallimento su un altro campo artistico. Un pittore mancato, un musicista mancato. L’idea di uno scrittore che è solo tale, tanto più se è un prosatore, mi sembra asfittica. Ma d’altronde direi lo stesso di un musicista: Schoenberg era un pittore della domenica, per molti anni smise di comporre solo per dipingere, e credo che questa sua scissione si riscontri nelle sue opere musicali. E devo dire che anch’io, se avessi avuto il dono di un’arte diversa dalla letteratura, avrei scelto non la musica, ma la pittura, benché passi molto più tempo ad ascoltare musica che a osservare dipinti. Il fatto è che fare arte è strettamente connesso a un’idea molto primordiale di benessere. Quando scrivo provo, a suo modo, questo benessere. Ma il benessere che posso immaginare se fossi stato un pittore dotato è infinitamente maggiore. In ogni caso, per rispondere più puntualmente alla domanda, ho messo da parte la musica perché farla non mi dava particolare piacere; tutto il piacere musicale che sono capace di fabbricare lo fabbrico con la scrittura.