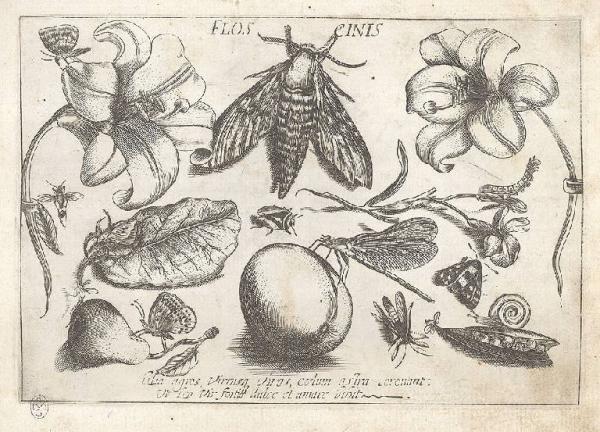Non voglio svegliarmi.
Sono già sveglio e non voglio svegliarmi.
Nausea, mi gira la testa. Labirinto infiammato, vertigini distese. Non esco di casa, non vado in ufficio, non parlo con nessuno. Ho sonno, ho dormito tredici ore e ho già sonno. Ho dieci, quindici minuti di autonomia. Sono un rottame, finito. Muoio.
Mi guardo allo specchio e mi faccio paura. Sono brutto, bruttino, bruttarello, paffutello – anzi grasso da fare schifo. Voglio sparire, non fare niente. Uscire, andare al lavoro, sacchetto di plastica in faccia che non mi fa respirare. Pulisco lo specchio, ancora non mi vedo. Bagno l’asciugamano, strofino. Nello specchio vedo ancora Frau Marlow, Gerhard Richter. Sfocato.
Cammino e mi sento troppo leggero. Non ho consistenza, non ho una vita. Sto buttando via il tempo. Lo spazio.
Quand’è che ho iniziato a non sopportarmi? Sono la persona con cui non vorrei mai trascorrere del tempo. Sono un’interferenza. Almeno anni fa correvo. Adesso a malapena cammino. Non mi posso ascoltare, ho una voce del cazzo. Quando ero un bambino mi prendevano in giro per la mia erre. Quasi inesistente, una pausa tra una lettera e l’altra. La avverto anche nei pensieri, non mi lascia mai solo.
Davanti al computer, Sigur Rós nelle orecchie. Cerco un momento zen, un po’ di silenzio. Intorno a me le persone si agitano, litigano, ridono. A loro tutto questo sembra reale. A me non sembra neanche un lavoro vero. Una simulazione, un videogioco. Sono Guybrush Threepwood intrappolato in un’avventura punta-e-clicca che nessuno ha voglia di giocare. Mouse abbandonato, il mio sprite immobile strizza gli occhi a intervalli regolari. Pixel neri, pixel rosa-faccia.
Tengo premuto il tasto della erre a lungo, fino a riempire pagine e pagine. Vorrei leggerle ad alta voce davanti a tutto il mondo e sentirlo ridere di me, come facevano Simone e Cristiano quando andavo all’asilo.
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Puntuale arriva il sonno. Paludi nella nebbia, paludi della tristezza. Artax, stupido cavallo! La storia infinita. A volte bevo caffè, altre acqua fredda in faccia. Stavolta non ce la faccio. Voglio sparire, non mi sopporto.
Colla negli occhi. Risate e voci che riconosco.
Ubriaco.
Ha bevuto.
La droga.
Licenziarlo no?
Sto solo dormendo, anzi non più.
Mi chiedono se sto bene, se è tutto a posto. No, non è tutto a posto. Sono una brutta persona. Qualcuno mi dà una pillola e un bicchiere d’acqua. Pillole per dormire, pillole per restare svegli.
Odio le mie paure. Di rompere gli occhiali, di perdere il portafogli. Paura di fallire, di riuscire, di scopare, di non scopare, di innamorarmi, di stare solo, della famiglia, di non averne una.
Ho tre paia di occhiali, due portafogli. Nessun orologio. Molti pesci di vetro e pupazzi a molla. Un coniglietto Jeff Koons che sembra fatto di plastica e infatti è così, due euro al centro commerciale. Gli oggetti curiosi mi individuano, il resto è rumore.
Non posso restare, oggi il disgusto che provo per me riempie la stanza, il palazzo, le strade. Nuvola bianca che si gonfia fino a scoppiare.
Vorrei essere qualcun altro. Avere una vita normale. Avere una vita. Solo per un giorno, una settimana. Per vedere com’è, per sentirne l’odore.
Esco e il cielo è coperto da me. Sono enorme, galleggio, occupo tutto lo spazio a disposizione. Tengo gli occhi incollati a terra, con il terrore di incrociare una pozzanghera e vederci dentro il mio riflesso. Mi concentro, chiedo al mago Zoltar di farmi sparire. Incontro qualcuno che mi somiglia. Sento scricchiolare i denti, cerco di mordermi per trattenermi. Vorrei picchiarlo, vorrei picchiarmi. Ne vedo un altro, stessa faccia. La mia faccia brutta, deforme, sproporzionata, malfatta, mostruosa, antiestetica, orrida, orrenda, orribile, orripilante, schifosa, disgustosa, ripugnante, ributtante, immonda, grottesca, abominevole. Diciassette aggettivi non sono ancora abbastanza. Ogni giorno cerco di impararne uno nuovo, ci tengo a esprimere quanto sia repellente. Non ci riesco.
In ascensore, premo il pulsante del piano e il dito si deforma, si scioglie, lascia una traccia di colore e di gelatina. Ectoplasma, perdo consistenza a poco a poco. Già mi immagino appiccicoso, colare da un armadio.
Di nuovo davanti allo specchio. Il volto è passato da un Gerhard Richter a un Francis Bacon. Presto sarà una torta in faccia di Adrian Ghenie.
Mi distendo sul letto e mi concentro. Materasso inghiottimi, materasso mio. Inghiottimi e non risputarmi altrove. Inghiottimi e tienimi dentro di te, dentro di te per sempre. Voglio nascondermi e non ricordare più niente, voglio non essere più in grado di pensare. Voglio essere un materasso, voglio essere sempre stato un materasso. Comodo, morbido ma non troppo. Uno di quei materassi su cui ci si può distendere e dormire anche senza mettere le lenzuola.
Mi rilasso, respiro piano. Sempre più piano, per essere un materasso. Penso alle cose da cui sono scappato. Ai funerali a cui non sono andato. Alle volte in cui non ho risposto al telefono e alle cose cattive che ho detto, che ho fatto e di cui neanche mi sono pentito.
Disteso, almeno la pancia si vede di meno. Il pensiero invece si vede di più, è una coperta di lana che pizzica. Mi gratto le braccia, il collo, la faccia. Mi gratto anche se so che lo schifo non è in superficie. È profondo, mi riempie, dovrei aprirmi e usare un cucchiaio per svuotarmi di tutto.
Non sarò mai un materasso.
Chiudo gli occhi e cerco di pensare a qualcosa di bello. Al mare, al vento. Immagino di evaporare, voglio lasciar gocciolare il novanta per cento di me fino a bagnare il materasso, inzupparlo. L’altro dieci per cento può volare sul mare, trasportato dal vento, lontano. Lontano.
Mi concentro, spingo per buttare fuori quello che ho dentro, che ho fuori e che odio. Riesco ad avvertire tutto. Le unghie che crescono, per esempio. Le sento scorrere sulla pelle, come una carezza tagliente al rallentatore. I pensieri confusi, i muscoli poco allenati, il peso del corpo che mi schiaccia. Sono ogni giorno più basso, più vecchio e più affaticato. Sento il mio corpo come mai l’ho sentito. Passo le dita tra i capelli e mi resta una ciocca in mano. Poi sulla faccia, il naso sembra fatto di plastilina. Si schiaccia, si deforma, sembra che non torni più come prima. Le mani coperte da uno strato appiccicoso. Il materasso si colora, inizia davvero a inzupparsi di me. Conto i respiri, questo è il momento giusto per scappare da me. E ci provo, a uscire, mentre ancora mi sciolgo.
Chiudo gli occhi, li riapro, mi rilasso e guardo oltre il soffitto, oltre il cielo, oltre quello che c’è oltre il cielo.
Non è un processo graduale, succede tutto in fretta, all’improvviso, come quando ti svegli vecchio e le occhiaie, che il giorno prima non c’erano, adesso ci sono e non se ne andranno dopo un’ora di sonno né dopo un giorno, un mese, mai più. Sei vecchio ed è successo stanotte. Quando non avevi difese e non potevi reagire.
Il corpo mi abbandona e io abbandono lui.
Mentre esco da me sono minuscolo. Luce improvvisa, aria fresca. Vedo lingua e palato. Devo schivare i denti per non tagliarmi. Viaggio veloce, più del previsto. La spinta finisce, posso voltarmi e guardare in basso, il materasso. L’unica cosa che ancora riconosco sono i piedi in via di scioglimento. Il resto è colore, che racconta la storia di una brutta persona e della traccia che ha lasciato dietro di sé.
Sospeso sopra quello che resta, mi rendo conto di essere ancora io. Mi guardo le mani, la pancia e il pensiero. È tutto com’era, solo molto più piccolo.