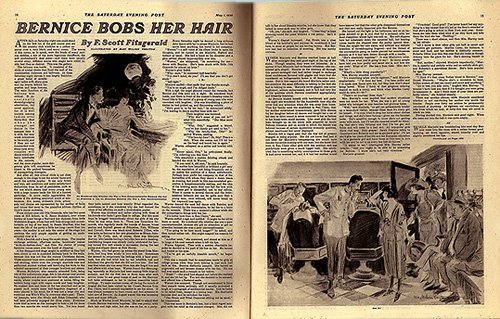
Avevo una ragazza, un lavoro, una busta paga di mille e tre netti al mese, e con gli straordinari, che di solito rifiutavo, potevo benissimo superare i mille e sei. Avevo un permesso di soggiorno, avevo amici quanti ne volevo, avevo un letto a una piazza e mezza. […] Avevo un buon rapporto con mio padre, l’unico albanese che non mi stava sul cazzo.
[Vorrei essere albanese, pp. 7-8]
Poche righe giuste permettono di afferrare la cifra stilistica e contenutistica di Elvis Malaj, giovane scrittore esordiente – classe ‘90 – albanese di nascita e poi anche italiano: lingua semplice e immediata, ricorso al gergo, uso di espedienti retorici (se è il caso), uso dell’albanese (quando – spesso – è il caso), finali controllati. Lui stesso, in un’intervista di Andrea Siviero nel lit-blog «Tre racconti», dice:
a me piacciono le soluzioni semplici, dinamiche e dal ritmo incalzante; probabilmente è dovuto anche a una mia sana fobia: la paura di annoiare. La mia scrittura è caratterizzata da continui cambiamenti di prospettiva ma non di colpi di scena, le storie quasi sempre finiscono in maniera pacata.
 Si potrebbe dire: classico approccio carveriano/cechoviano: “Non forbire, non limare troppo. Sii sgraziato e audace” (Čechov) e “Gli scrittori non hanno bisogno di ricorrere a trucchetti e trovatine né sta scritto che essi debbano sempre essere i più in gamba di tutti” (Carver), ad esempio.
Si potrebbe dire: classico approccio carveriano/cechoviano: “Non forbire, non limare troppo. Sii sgraziato e audace” (Čechov) e “Gli scrittori non hanno bisogno di ricorrere a trucchetti e trovatine né sta scritto che essi debbano sempre essere i più in gamba di tutti” (Carver), ad esempio.
Sono storie di due mondi in collisione, quello italiano in opposizione a quello albanese che reca, per l’italiano, lo stigma della miseria e del criminale. Ma sono anche storie d’amore, di rabbia e violenza represse, di solitudini, di povertà, tematiche classiche e sempre in uso. Unica storia di trucchi, di effetti speciali, è Il televisore, che è come la ballata nel concept album: afferra il lettore con facilità, ma non è il racconto più bello, è solo il più attraente. Su tutti, invece, ricordo la storia di Maria e Kastriot, una storia di amore e di differenza, di poesia; una frase può essere rappresentativa: “nei momenti di panico a Kastriot venivano in mente le poesie” [Morte di un personaggio, p. 132].
Tanti attendevano la prima pubblicazione italiana di Racconti edizioni, una casa editrice nata nel 2016 che si occupa esclusivamente di racconti. Letto Philip Ó Ceallaigh e gettato uno sguardo al catalogo, è chiara la qualità della ricerca portata avanti. Dopo dodici pubblicazioni “straniere”, ecco un italiano – e anche esordiente. Apprezzate le indubbie qualità di Malaj, condizionato dalla personale necessità (che si concretizza nel consiglio agli altri lettori: un servizio, se possibile, di divulgazione culturale) di fare le differenze, di distinguere più bravi e meno bravi pur nella difficoltà di stabilirlo una volta per tutte, e pur nella possibilità che l’opinione muti col tempo, mi sono chiesto – e uso un gergo calcistico: questo libro è un crack? È l’esordio di un fuoriclasse? Rispondo, al momento, di no: mi aspettavo di più, mi aspettavo la folgorazione e l’innamoramento come talvolta mi capita; ho avuto la sensazione di aver letto qualcosa di molto buono. Cosciente di operare una considerazione discutibile, dico che il contesto non aiuta: il “discorso sul racconto” con i suoi eccessi; le frasi a effetto di chi parla di racconti; la percezione di qualcosa, in giro, di insincero, quasi che da parte dei paladini della narrazione breve (non Malaj, né Racconti edizioni, chiaro) si tratti di occupare uno spazio e farsene principe e dominatore; la ghettizzazione forse interessata di una forma letteraria in contrapposizione (e non in accompagnamento) al romanzo, tutto questo non aiuta.  Tante e troppe aspettative fomentate negli ultimi tempi da tanto e troppo rumore intorno al racconto finiscono per condizionare la lettura imponendo il chiodo della domanda “in che stato è la forma racconto in Italia?”. Diventa un atto di responsabilità, dunque, non limitarsi al giudizio ma osare il confronto per stabilire se ha senso insistere, in Italia, con questo discorso che comprende nuovi luoghi comuni come quello di un’editoria che ignorerebbe volutamente e detestabilmente il racconto e cose così, laddove, in fondo, il racconto rispetto al passato ha molti più spazi in cui proporsi al lettore – penso alle riviste letterarie, che impongono un’alternativa definitiva e non negativa alle difficoltà di pubblicazione di questa forma narrativa. A meno che, certo, non ci si voglia arricchire col racconto, non si voglia illudere con la vision/mission di un’Italiamerica in cui i racconti vengano pagati e tanto, cosa che non accadrà mai: l’Italia, pur scimmiottandola, non è l’America; nessun Carver, nessun Salinger, niente di tutto questo può proporsi qui, ma così come nessun Gadda può darsi in America. Il punto – banale ma vero – è: c’è differenza, a ciascuno il suo.
Tante e troppe aspettative fomentate negli ultimi tempi da tanto e troppo rumore intorno al racconto finiscono per condizionare la lettura imponendo il chiodo della domanda “in che stato è la forma racconto in Italia?”. Diventa un atto di responsabilità, dunque, non limitarsi al giudizio ma osare il confronto per stabilire se ha senso insistere, in Italia, con questo discorso che comprende nuovi luoghi comuni come quello di un’editoria che ignorerebbe volutamente e detestabilmente il racconto e cose così, laddove, in fondo, il racconto rispetto al passato ha molti più spazi in cui proporsi al lettore – penso alle riviste letterarie, che impongono un’alternativa definitiva e non negativa alle difficoltà di pubblicazione di questa forma narrativa. A meno che, certo, non ci si voglia arricchire col racconto, non si voglia illudere con la vision/mission di un’Italiamerica in cui i racconti vengano pagati e tanto, cosa che non accadrà mai: l’Italia, pur scimmiottandola, non è l’America; nessun Carver, nessun Salinger, niente di tutto questo può proporsi qui, ma così come nessun Gadda può darsi in America. Il punto – banale ma vero – è: c’è differenza, a ciascuno il suo.
Elvis Malaj
Dal tuo terrazzo si vede casa mia
Roma, Racconti edizioni, 2017
pp. 164




Ciao Antonio. Ho letto il tuo parere sulla raccolta di Malaj e sono d’accordo nella impressione di base: non convince. A mio avviso c’è anche la mancanza di un editing coraggioso (soprattutto nell’ultimo), non so se condividi.
Ciao Alberto,
sull’editing il discorso è diverso: hanno lavorato al libro persone degne di massima stima.