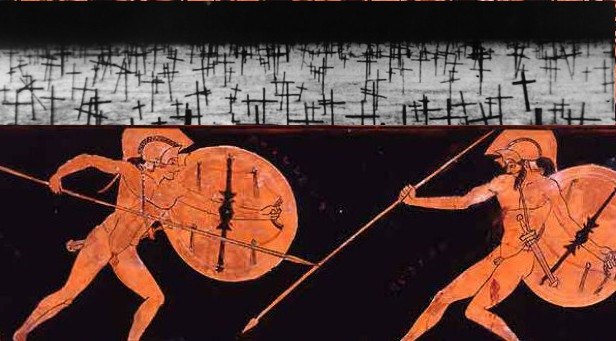Napoli, aprile 1656
Sono morta da poche ore.
Già mi sento i sorci addosso, famelici e assatanati, a rosicare le membra del corpo che ho avuto in dote per il breve arco della mia vita, appena e malamente interrotta.
Ho ancora nelle orecchie lo strazio di mia madre sul mio cadavere in putrefazione, dilaniato dalla pestilenza che mi è toccata in sorte. Un supplizio è stato il mio trapasso, un’agonia durata più di un mese. Altro che Cristo in croce.
Pure al dottore facevo pena. La sua smorfia di schifo traspirava fuori da quella maschera da corvo occhialuto, camice nero e becco lungo lungo. Un uccello del malaugurio pareva, brutto da fare paura. Tanta che, quando metteva piede in casa, era come se mi stesse venendo a pigliare la morte in persona.
E quella infatti veniva, ma poco per volta. Si era come impuntato, ‘sto corpo mio, per appestato che fosse fino al midollo. Non ne voleva sapere di farsi portare via e ha resistito fino all’ultimo spasmo, pur sapendo di prolungare solo febbre e patimento.
Finché, qualche ora fa, non ha ceduto. La malamorte è venuta a bussare per l’ultima volta.
Pure pregna ero, e di sette lune. Quelle passate da quando, in una notte di coprifuoco che me n’ero uscita dalla finestra mentre mamma dormiva, una guardia spagnola m’avvistò nel buio di un vicolo, mi acchiappò da dietro e mi premette veloce la mano sulla bocca. Sotto la gonna non tenevo niente e, come lui se ne accorse, me l’alzò in un lampo. Poi, con il lembo della vestaglia tra i denti, mi strinse forte i fianchi e mi venne dentro in meno di un minuto. Quando ebbi la forza di girarmi, quello era già sparito.
Mamma, saputa la cosa, disse di volermi portare subito dalla janara del rione, per farmi abortire e toglierci veloce il pensiero.
No, – mi misi a urlare sull’uscio prima di sbattermi la porta alle spalle, – io me lo voglio tenere a mio figlio!
Quando tornai, dopo un paio d’ore di gemiti e singhiozzi, vidi che pure lei se n’era convinta.
Fu così che me lo tenni. Ancora lo tengo in grembo, a ‘sto criaturo mio, morto pure lui prima di avere visto la luce. Non m’è riuscito di sgravarlo prima di trascinarlo con me nello scuro della morte.
È stato poco fa che il salmataro ha sollevato la mia carogna puzzolente. D’accordo col prete l’ha fatta portare qua dentro, nella fossa comune che da poco hanno aperto alle Fontanelle, un antro nel cuore di tufo della Sanità. Povera mamma se lo viene a sapere, ché in lacrime s’era raccomandata col becchino per farmi dare degna sepoltura.
Quel disgraziato di un prete, poi, non ne parliamo: i piccioli se li è intascati, in qualche sacca che gli pesa da sotto alla tonaca, ma manco di una benedizione mi ha degnato. Non dico un funerale in pompa magna, né una cerimonia d’estrema unzione. Ma almeno una preghiera veloce, che ne so, un eterno riposo recitato a mezza voce, un segno di croce con una mano sola. Sarebbe forse bastato a darmi una possibilità di salvezza, una, dalla malora perpetua.
Poi è inutile che se ne esce con la litania che tutto ‘sto flagello è per i nostri peccati, che presto Iddio scenderà in terra a proclamare la sua sentenza definitiva, il suo giudizio universale. Ai furbi come a lui, dico io, si dovrebbe pigliare il Padreterno! No ai poveri cristi come a noi, che tra tutte le disgrazie della vita solo la malamorte ci doveva ancora capitare.
Allora due sono le cose: o il Signore è un padre maniaco e violento, che si diverte a abusare del suo potere contro i suoi stessi figli, oppure ‘sta sciagura non è una punizione divina. Però, se non ce l’ha scagliata Iddio dall’alto, piaga biblica o sottospecie di manna velenosa che fosse, da dove viene allora ‘sta scomunica? Non sarà che è sgusciata via da sotto ed è arrivata qua risalendo su per i cunicoli dell’Inferno, magari sputata fuori da Satana in persona per una delle tante bocche che ha disseminate in questa terra?
Fatto è che una moria feroce e inarrestabile si è abbattuta alla cieca sulla città nostra. Già si è portata, dicono, più della metà dei napoletani. Più morti che vivi. Così che Napoli è diventata veramente un cimitero a cielo aperto, necropoli agonizzante e in via di decomposizione. Morti sopra e sotto la terra, morti accatastati negli spiazzi, morti gettati nelle caverne. Morti murati o tenuti nascosti nelle case, morti sui carri che chissà dove li portano. Morti che aspettano solo di morire, rassegnati a affrontare la dannazione eterna piuttosto che restare in vita un minuto di più.
I pochi vivi che in mezzo a ‘sto macello hanno il coraggio di uscire allo scoperto sono quelli che sulla morte ci fanno pure i soldi: preti, dottori, carrettieri e beccamorti, in giro con i loro becchi d’avvoltoio, nascosti dietro quei manti funebri che gli scendono dalle spalle. S’aggirano a ogni ora per le strade, col passo furtivo e travestiti di morte, pronti ad aggredire la preda di turno e a spolparsi i cadaveri ancora vivi, prima di festeggiare il loro macabro carnevale da strozzini. Senza che ne avessero il minimo scuorno.
Non è bastato un secolo di rivolte, carestie, eruzioni, terremoti e malesorti di ogni maniera. No, si doveva mettere pure ‘sta malattia incurabile, fetosa come la merda più putrida che scorre giù per le chiaviche della città, mortifera come la lava che vomita il Vesuvio ogni volta che si risceta, come quella che vidi quand’ero ancora criatura. La tengo ancora negli occhi. E ancora me la sento scendere giù per il collo, lenta e vischiosa, a consumarmi la pelle e le ossa. Quelle che soltanto rimarranno di noi morti.
Scheletri bucati, questo saremo, ammaccati sotto il peso dei cadaveri che ci continuano a buttare sopra, accatastati dentro a questo quarto d’inferno scavato di pressa nel tufo.
Le ossa di mio figlio, invece, troppo deboli per fare fronte allo sfacelo, quelle sono già ridotte in briciole. Polvere sparsa dentro al ventre mio, cenere spenta senza essere mai stata fuoco.
Napoli, novembre 1872
Il tempo dei morti è un battito di ciglia. È come risvegliarsi da un sonno profondo senza sapere quanto si è rimasti a dormire. Quaggiù, vicino alle viscere della terra, il tempo è lo scorrere di un presente fisso, immobile, che fa del passato ciò che forse non è mai stato davvero. È nostalgia che diventa ricordo lontano di se stessa, reminiscenza di un sogno mai fatto. Un secolo è un’ora, mille anni uno schiocco di dita, un minuto l’eternità. Nemmeno più il respiro per poterci contare i secondi.
Nessuno, ormai, saprà più il mio nome. Tanto più che l’ho scordato io stessa. Siamo tutti quanti uguali, qua sotto, con la bocca aperta e le orbite svuotate, tutti con la stessa identica espressione stampata in faccia: quella della morte che ti viene da dietro e in un colpo ti scerpa via la pelle, senza lasciarti il tempo di girarti a guardarla nelle palle degli occhi.
Ne siamo a migliaia. Ognuno con la storia sua passata, ma condannato a scontare la stessa immeritata pena: l’oblio infinito, l’anonimato eterno.
A interrompere la paralisi di questa notte informe arrivò tempo fa un’alluvione, un nubifragio potente da sfondare la diga naturale delle pareti di tufo e aprirsi un varco nella roccia. Quel giorno ci trovammo tutti a cavalcare la furia di quelle acque impazzite e, prima di rendercene conto, stavamo già navigando giù per i dossi di via Foria. Dalle pendici di Capodimonte alcuni di noi arrivarono fino a piazza Garibaldi.
Al primo colpo le mie ossa si sfaldarono, molte si fracassarono in mille pezzi, poche altre, le più resistenti, andarono disperse. Io rimasi dentro a questo teschio, come se la sede della voce che credevo di essere fosse sempre stata là dentro. Ma perché, mi venne da chiedermi, non in un femore? O in un avambraccio? Oppure, se è vero che l’anima risiede nel cuore, perché non nella gabbia toracica, tra costole e vertebre? Si può sapere io che cosa sono?
Mille domande si affollavano senza una risposta, ma altre ne imponeva la situazione: quanto tempo, – pensai una volta uscita allo scoperto, – quanto ne è passato dall’ultima volta che ho veduto queste strade?
I palazzi erano molto cambiati, quelli vecchi erano stati restaurati, quelli nuovi avevano un aspetto più robusto e sfarzoso di quelli di una volta. E poi, viali così larghi e lunghi non ne avevo mai visti in vita mia.
La gente però, quale che sia stato a quel tempo il dominatore di turno, continuava ad avere paura.
Tant’è che quella valanga di fango e ossa e detriti fu un trauma per loro prima che per noi. Lava dei Vergini, pare l’avessero ribattezzata. E infatti, quando noi morti invademmo le loro strade, per parecchio tempo non ebbero manco il coraggio di uscire di casa. Nemmeno alla finestra si affacciavano, forse per paura di doverci riconoscere. Io, al contrario, temevo che mia madre, fosse mai stata ancora viva, non avrebbe riconosciuto la capuzzella di sua figlia al passarmi di fianco.
Era come se, insieme a noi, fosse riemerso a galla qualcosa di inconfessabile, qualcosa che il popolo napoletano aveva tenuto nascosto a se stesso. Fu come il ritorno inatteso di un’inquietudine collettiva, che l’intera città aveva rimosso mettendoci una pietra sopra.
Un macigno, proprio, e non in senso figurato.
Oggi invece, che di tempo ne è passato da quella volta, quel macigno è stato tolto e la gente sembra avere imparato a non avere più paura di noi. Ogni giorno, squadre di popolane devote e volenterose vengono qua dentro a farci visita.
Su iniziativa del parroco di Materdei, armate di pale e spazzole e pazienza, ci ripuliscono e ci mettono in ordine, sistemandoci una accanto all’altra nel poco spazio che hanno a disposizione. Ci scrollano di dosso tutto il marciume accumulato negli anni di clausura e poi ci sistemano, assicurandosi che stessimo tutte quante allineate e coperte. Se avessimo i capelli ci pettinerebbero pure. E poco ci manca che non ci mettono la parrucca per poterlo fare. Potessero magari sgranchirci le giunture che perdemmo tempo fa, forse avremmo anche un’aria un poco più distesa.
E intanto piano piano, giorno dopo giorno, queste signore stanno tirando su un vero e proprio camposanto. Cimitero delle Fontanelle, gli hanno messo nome. Un camposanto insolito, certamente: senza tombe e senza bare, senza nomi e senza lapidi, dove un morto vale l’altro e ognuno si può scegliere il suo, mettergli il nomignolo che preferisce e adottarne l’anima purgante, di chiunque e ovunque essa sia; aiutarla, a suon di paternostri e avemaria, a uscire da quel posto misterioso che loro chiamano Purgatorio. In cambio ci chiedono solo, e scusate se è poco, di fare loro qualche grazia. Manco fossimo il sangue di San Gennaro.
Pure il posto che mi hanno scelto, devo dire, non è male: in compagnia di mille altre capuzzelle messe in fila una appresso all’altra, in un punto in cui arriva luce abbastanza, non troppo scuro e nemmeno troppo illuminato. Pure a umidità sto messa bene, tenuto conto che in certi punti della cava ce n’è talmente tanta che nelle notti più fredde si fa la condensa su alcuni teschi. Al punto che le popolane più mattiniere, quelle che arrivano coi primi bagliori dell’alba, al vedere le goccioline scivolare giù dalle capocce, gridano al miracolo. Si sono persuase che si tratta di sudore, segno del nostro sforzo di intercedere col mondo dei vivi per realizzare le grazie da loro richieste.
Come che fosse, è lodevole la dedizione che hanno per noi. D’altra parte, siamo i santi che loro stesse si sono scelte, non quelli che la Chiesa ha loro imposto di pregare. Siamo noi i veri santi del popolo, perché dal popolo pure noi veniamo. Siamo anime pezzentelle, come dicono loro. E questo un po’ ci fa onore.
Alcune di noi, quelle che secondo le popolane hanno avverato le rispettive grazie, hanno avuto pure un trattamento di favore, riposte dentro nicchie di vetro con tanto di candele e dedica: “Per grazia ricevuta”.
Una cosa, però, non mi riesce di capire: e cioè perché queste donne insistono a trattarci con maniere talmente buffe da diventare ossessive, a passarci ogni mattina la cera sulla testa per tenerci lucide e linde e pinte, manco fossimo le bambole predilette del loro guardaroba personale.
Di questo però sono certa: che più sto e più mi rendo conto che i vivi sono veramente, veramente strani.
Stamattina mi è successa una cosa: una donna anziana, quella che ogni giorno viene a lustrarmi di tutto punto, m’ha piazzato uno specchio di fronte per lasciare che mi guardassi. Un senso di angoscia mi ha pigliato di un colpo, alla sprovvista. È stato come svegliarmi di scatto e ritrovarmi dentro a un incubo terribile, peggio di quello che stavo facendo mentre ancora dormivo. Pensavo di esserne già cosciente, ma è stato solo in quel momento che ho dovuto rassegnarmi all’idea di essere anch’io una spaventosa e misera capuzzella, una in mezzo a centomila, identica e precisa a tutte quante le altre.
Quella espressione sterile, con le due orbite vuote e senza traccia di vita, affacciate come su un abisso senza fondo, mi ha turbata seriamente. Più ci penso e più mi va stretta, sento che non mi appartiene, che non mi è mai appartenuta.
Proprio non riesco a farmi capace.
Qualcuno mi aiuti, ho paura.
Napoli, febbraio 1949
Che ne sapete voi delle pene dei morti!
Siete convinte di fare del bene a noi, quando in realtà non fate che alleviare i vostri dolori quotidiani.
Più passa il tempo e più mi diventano antipatiche, ‘ste popolane.
Ma, dico, neanche da lontano vi sfiora il pensiero che forse, se proprio ci tenete a farci un favore, potreste pure provare a lasciarci in santa pace? E poi senza che ve lo andate a cercare in cielo o chissà dove, ‘sto Purgatorio di cui tanto vi riempite la bocca: è qua, in mezzo a voi, e ci siete dentro fino al collo. Siete voi, i vivi, le vere anime in pena, e quasi quasi siamo noi a dover pregare per voi.
Io, per me, vorrei tanto poter fuggire da questo limbo che è la città dei vivi, dove da morta sono rimasta intrappolata. Tutto quello che voglio è pigliare pace: una ventata di refrigerio, riposo eterno e niente altro. Ma qua, in mezzo ai vivi che ci assillano il cranio con le loro chiacchiere a vuoto, con le loro ipocrisie e le loro ansie represse, qua non è proprio possibile.
Certe volte vorrei proprio morire. Morire, sì, ma per davvero. Smetterla una volta per tutte di agitarmi come un fantasma impazzito nel rimbombo di questa cava. Sono stanca di farmi male a furia di sbattere contro il guscio di questo teschio vacante, rivolto sempre dalla stessa parte. Sarebbe bello farsi risucchiare nel nulla più totale, spegnere anche l’ultimo barlume di coscienza e scordarmi per sempre di me e di quello che sono stata. Dissolversi nel nulla infinito che giace al fondo di ogni cosa: quello sarebbe il mio Paradiso. Ma piuttosto che in questo Purgatorio, avrei preferito essere sbattuta all’Inferno!
Gira voce che la capuzzella di un soldato spagnolo ha fatto la grazia a una donna che gli aveva chiesto di farla maritare. Lo chiamano il Capitano. E chissà che non sia proprio lui il mio sposo mancato, il padre del figlio che non ho mai partorito. Dice pure che ‘sta donna se l’è visto comparire davanti, bell’e buono, proprio il giorno del suo matrimonio. Il Capitano le ha fatto l’occhiolino, e lo sposo, incazzato nero, gli ha menato un cazzotto dritto nell’occhio sinistro. Il giorno dopo la sposa è venuta qua per ringraziarlo e ha trovato l’orbita del cranio mezza ammaccata per la botta. E tutti, guarda caso, hanno gridato al miracolo.
Pure la signora che mi aveva adottato mi ha scongiurato di farle incontrare un nuovo marito. Quello di prima lo aveva perso qualche anno fa in guerra, una delle tante che i vivi continuano a farsi tra di loro. Dicevano che era la Seconda, a me pareva la centunesima. Tant’è che all’inizio, quella povera vedova, non potendo riavere indietro il cadavere del suo uomo, pigliò me come suo sostituto. Proprio me che in vita sono stata una femmina! Veniva a trovarmi in continuazione, e un giorno decise pure di spostarmi dal posto dove mi avevano lasciato secoli fa. Mi piagnucolava addosso dalla mattina alla sera, tra nenie lunghissime e lamenti funebri. Non mi dava tregua: Arturo mio! – mi diceva sospirando – ti prego, torna da me.
Poi, si sa, il tempo dei vivi allevia tutte le ferite. Allora la vedova cominciò a farmi visita non più per dare sfogo ai suoi tormenti, ma per chiedermi una grazia: farla risposare con un bell’uomo, possibilmente più giovane di lei. E, se proprio ci riuscivo, ma senza impegno, che avesse magari pure i soldi, ché quelli fanno sempre comodo.
Io le apparvi in sogno quella notte stessa. Mi feci riconoscere e le dissi che non tenevo i poteri per accontentarla. Sapevo bene che non mi avrebbe presa sul serio, ma cercai di farle capire che un favore lo poteva fare lei a me: ritrovare le altre mie ossa superstiti, ricompormi e poi distruggermi, sgretolarmi fino all’ultimo pezzettino e gettare via la polvere nel vento. È un’impresa impossibile, lo so bene, ma lei mi sa che non m’intese nemmeno. Nel sogno, anzi, diffidava di me per il semplice fatto che ero donna e non uomo, come lei invece si aspettava.
Sapevo che non mi avrebbe mai capita, e manco del resto ci speravo: tra i vivi e i morti non c’è mai stata la minima possibilità di comprensione. Fatto sta che quella, nel suo egoismo da viva, ha continuato fino a oggi a chiedermi di farla sposare con un bel giovane della Sanità.
Senonché, proprio ‘sto pomeriggio, questa storia si è finalmente conclusa: è andata a finire che lei, scocciata per non aver trovato nessuno disposto a maritarla, se l’è presa con la sottoscritta. Dopo avermene dette di cotte e di crude, mi ha tolto da dove m’aveva piazzata e m’ha rimesso al mio vecchio posto, sul mucchio in mezzo a tutte le altre. Manco ha avuto l’accortezza di sistemarmi per bene e m’ha lasciata qua impalata, col cranio leggermente scostato verso destra. Poi ha girato i tacchi e se n’è andata. Spero che non si faccia più rivedere.
Non è che la odio. È che mi fa pena, pena soltanto.
Napoli, oggi
Noi capuzzelle non siamo che soffi senza voce, aliti di sogno, urla di silenzio. Siamo il vuoto dentro e dietro le nostre orbite, sbadigli senza bocca, sguardi senza occhi.
Siamo morti pezzentelli senza nome e senza faccia, senza più un corpo e senza manco più un’anima, se mai l’avessimo, un giorno, avuta.
A voi che siete vivi: uscite per sempre da questa cava e lasciateci in pace nella nostra solitudine. E lasciate in pace pure i morti che avete seppellito là fuori nei vostri cimiteri, con tanto di foto e date e nominativo, dopo averne magari consacrato il trapasso con funerali tanto più tristi quanto più sfarzosi.
I morti, tutti, non hanno nome. Serbatene, se volete, il ricordo. Ma oltre quello scordateveli, non sono più nulla.
Perciò andate via da qua e non tornateci mai più. Spegneteci la luce e sbarrate quell’ingresso una volta per tutte. Avessimo potuto, l’avremmo fatto noi da soli fin da subito.
Poi, come per miracolo, è successo che la mia preghiera si è esaudita. Per lungo tempo, non saprei dire se per un anno, un mese o un millennio, nessuno più è venuto a pregare per noi. Dice che fu il Cardinale di Napoli a ordinare la chiusura di questo posto, perché i rituali che le popolane ci praticavano erano diventati una specie di eresia, un culto feticista che con la religione niente aveva a che fare.
È solo da poco che i vivi hanno cominciato di nuovo a farsi vedere da queste parti. Però non per pregare: la più parte sono curiosi, turisti che vengono, danno un’occhiata e se ne vanno, senza fare più ritorno. Solo che hanno preso la brutta abitudine di lasciarci una monetina sulla testa, manco fossimo soprammobili. Di pessimo gusto, peraltro. Dicono che porta fortuna.
Proprio oggi due giovani si sono fermati davanti a me. Uno dei due, manco a farlo apposta, ha creduto che io lo stessi guardando, forse per la posizione un po’ storta nella quale mi lasciò tempo fa quella vedova piagnucolona. Avrà pensato che, in mezzo alle mille altre capuzzelle, io stavo girata apposta per catturare il suo sguardo distratto. Allora ha scavalcato la balaustra, mi ha accarezzato il cranio e ci ha lasciato una monetina sopra.
Ora ti puoi voltare – mi ha pure detto prima di andarsene.
Un giorno, fra milioni di anni, quando avrò raccolto le forze per farlo, mi volterò per davvero e mi scrollerò di dosso questa stupida monetina.
Prova tu – avrei voluto dirgli prima che sparisse per sempre dietro l’angolo – ad avere un prurito eterno sulla fronte senza neanche le mani per poterti grattare.
Vorrà dire che una di queste notti andrò a trovarlo in sogno per dirglielo. E, se avrà voglia di ascoltarmi, gli racconterò la mia storia. Lui ha scelto me, io scelgo lui. Finché vita non ci separi.
© 2017 Agostino Arciuolo. Tutti i diritti riservati.
*****
Le foto sono di Paolo Visone.