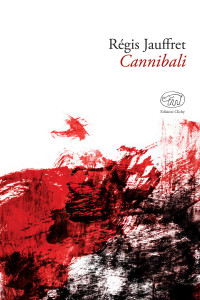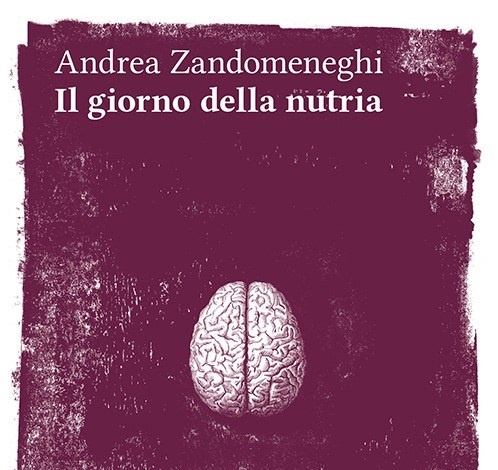Dai deliri declamatori[i] dei tre protagonisti di Cannibali si evince che quello di Régis Jauffret è un romanzo di ruminazione nel quale nessuno mangia niente (o quasi), ma tutti agognano il pasto. Il piatto principale, Geoffrey, ex fidanzato di Noémie e figlio di Jeanne, è pregustato, annusato, inseguito con l’acquolina in bocca dalle due sfrenate Erinni (o Baccanti?) che lo eleggono a capro espiatorio, a emblema del male, a nemico da divorare attraverso un omicidio che assume i contorni del cerimoniale stregonesco.
Ti amo quanto si può amare dopo aver smesso di amare. Ti amo come un arto amputato di cui si è convinti di muovere le dita e che uno sguardo dissolve.
I tre protagonisti, impantanati nell’ansia di far valere le loro ragioni e nel desiderio di cannibalizzarsi l’un l’altro, arrivano invece a sviscerarsi, tirando fuori tutto per esporsi con una crudezza disturbante, quasi oscena, in un gioco al massacro che vede ribaltamenti di forze in campo, di alleanze, di potere, nel tentativo di tirarsi fuori dal gioco (Geoffrey) o di annientare/inglobare tutto ciò che è a portata di sguardo (le due donne).
Viene il sospetto che alla fine tutto si nutra (letteralmente) di dinamiche di relazioni dal retrogusto fassbinderiano, prive però delle spezie melodrammatiche caratteristiche del regista: Jauffret è un narratore-montatore gelido e sadicamente divertito (e divertente), che porta avanti la storia tramite giustapposizioni dapprima meccaniche poi inquietanti e imprevedibili. Geoffrey, Noémie, Jeanne, sono istanze ferocissime e vendicative, distruttive e autodistruttive, irrefrenabili, ebbre di eccessi e di sangue, che non conoscono compromessi e che si rapportano tra loro solo attraverso il riconoscimento di un/una antagonista e l’intenzione di sbranarlo/a.
Per reggerci in piedi, l’odio ci è necessario proprio come lo scheletro. Se la bile si vendesse al supermercato, i clienti sarebbero più felici. Che gioia sentire in sé la speranza di riuscire forse a danneggiare qualcuno, a spingerlo verso la morte o almeno a rendergli amara la vita.
L’auto-svisceramento dei cannibali è uno spogliarsi delle sovrastrutture urbane per caricare e liberare la potenza ferina, essenziale eppur metaforica; perché al loro sventrarsi non corrisponde mai un’autentica apertura a se stessi o all’altro, ma solo un acuirsi del misterico, che a sua volta si esaurisce, senza rivelarsi del tutto, in uno spietato elogio funebre da parte di chi, per ruolo, dovrebbe dare e amare, e che invece si autoalimenta della propria brutalità e del proprio inevitabile trionfo, in un contesto assoluto e fuori dal tempo in cui il concetto di evoluzione non è tanto fallace, o limitato, ma addirittura ipocrita.
Régis Jauffret
Cannibali (2016)
Trad. it. Federica Di Lella
Firenze, Clichy, 2017
[i] Sembrerebbe che tra cannibalismo e tendenza alla declamazione ci sia un legame intimo e indissolubile: dal celeberrimo Hannibal Lecter, sia nella sua versione cinematografica che (soprattutto) in quella televisiva, al sublime macellaio di Delicatessen, a Sweeney Todd, chiunque si nutra o voglia nutrirsi di carne umana tende a usare un linguaggio forbito e un po’ âgée; i cannibali civilizzati si rigirano le parole in bocca come fanno con i loro piatti prediletti. Vogliono ribadire la loro distanza dal mangiato. Se nel cannibalismo rituale la persona mangiata viene introiettata anche spiritualmente dal cannibale, nel cannibalismo civilizzato si tratta, come per molte altre cose, di ridurre la persona a semplice mezzo di sostentamento, sottolineando la superiorità (economica? morale? evolutiva?) del cannibale. Sembra quasi che i cannibali evoluti abbiano preso alla lettera la Modesta proposta di Swift, portando alle estreme conseguenze un procedimento che, sebbene ineludibile, per i non-cannibali resta metaforico, quello del più forte che divora il più debole.