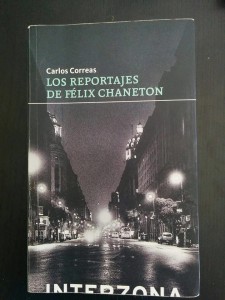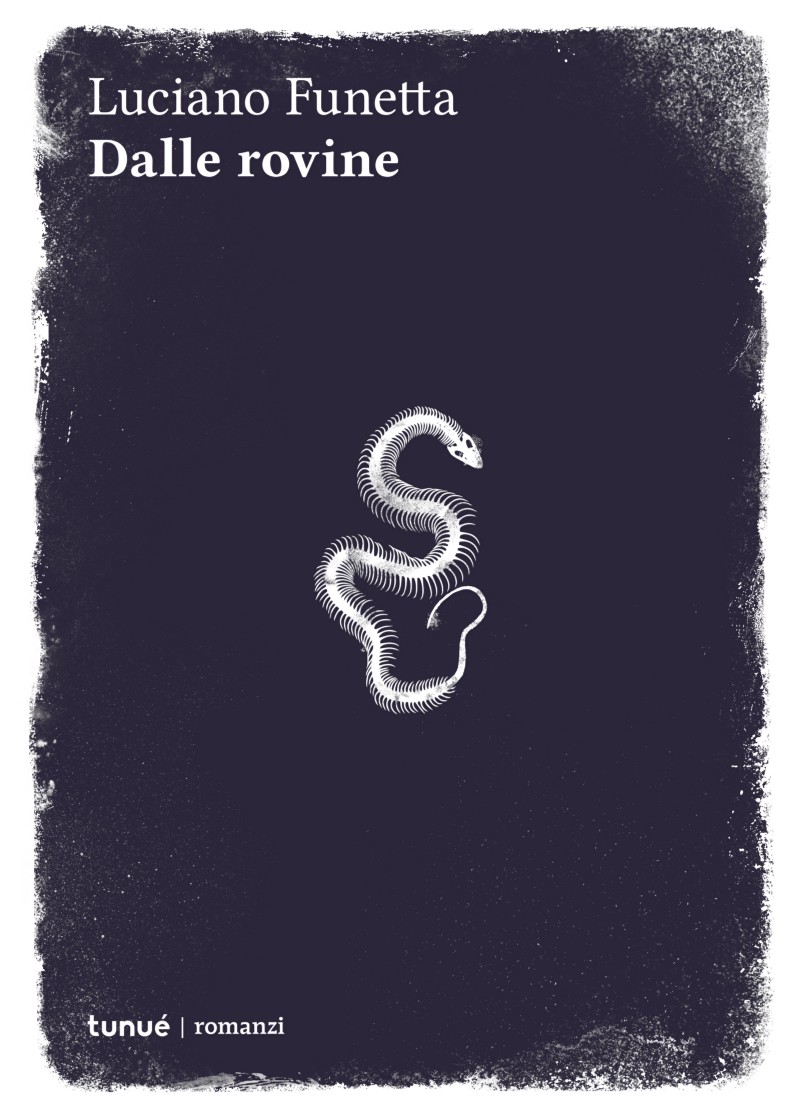A suggerirmi di comprare, o meglio a obbligarmi a comprare, Los reportajes de Felix Chaneton di Carlos Correas è stato Sandro Barrella, un pomeriggio di agosto, mentre mi aggiravo tra gli scaffali stracolmi della libreria Norte in cerca di una ragione come un’altra per spendere un po’ di pesos. Per rendergli la gratitudine che merita aggiungo che la Norte si trova in Avenida Las Heras ed è, a mio modesto e insignificante parere, tra quelle che ho potuto visitare, la migliore libreria della città di Buenos Aires.
«In un desolato sabato notte alla fine dell’anno Duemila, Carlos Correas si tagliò le vene e, poiché la morte non arrivava, si buttò dalla finestra di un lugubre appartamento di Plaza Once, il cui unico arredamento era costituito dalle foto di Sartre, Evita e Audrey Hepburn». Così scrive Juan José Sebreli, amico di gioventù di Correas, facendoci gelare il sangue.
Sono steso sul lato destro di un letto a due piazze al quinto piano del palazzo che fa angolo tra calle Estados Unidos e Perù. Dalle profondità del minuscolo cortile su cui si affaccia una delle finestre entra il chiasso mostruoso dei clienti del pub Gibraltar. La televisione della casa è accesa come sempre su Fútbol para todos, la rete che trasmette gratis tutte le partite del torneo nazionale. Sono sposato da un mese e mezzo. Mia moglie sta facendo una doccia. Abbiamo camminato tutto il giorno, siamo esausti e infreddoliti dalla pioggerella noiosa che è caduta per tutto il giorno sulla città. La stufetta elettrica dell’appartamento va a tutta forza. Dalla pila sul pavimento prendo uno dei libri argentini che ho comprato nell’ultima settimana. Per portarli in Italia ci vorrà una valigia supplementare. Scorro la quarta del volume che ho scelto. Un certo Edgardo Scott ha il coraggio di affermare che se Borges e Arlt si potessero confrontare per scegliere un erede comune, il prescelto sarebbe Carlos Correas. Non si può dare peso a una sciocchezza del genere, mi dico.
Dove è sepolto Correas? Non lo so. Ho letto Los reportajes quasi tre anni fa e solo oggi mi pongo il macabro quesito del cadavere. Apro l’homepage di www.findagrave.com, effettuo la ricerca, invano. Passo a Google, cerco «Carlos Correas tumba» e «Carlos Correas cementerio». Nessun risultato utile. Solo la stessa fotografia, ogni volta, di Correas negli anni Cinquanta. Pesante cappotto grigio lungo fino alle ginocchia; mani affondate nelle tasche; occhiali da vista modello Cludbround. Occhi miopi o solo molto affaticati. Una figura spettrale appollaiata su una ringhiera affacciata sulla notte.
Los reportajes de Félix Chaneton viene pubblicato per la prima volta nel 1984. Interrompendo venticinque anni di silenzio letterario, dopo la censura subita nel 1959 a causa di «La narracion de la historia», racconto pubblicato sulla rivista studentesca «Filosofia y Letras» che gli causa un processo per oscenità e sei mesi di prigione con la condizionale, Correas riemerge dal cunicolo del silenzio, proprio come l’Argentina ritorna, in forma di zombi, dalla fossa comune dell’ultima dittatura civico-militare. Molto è cambiato, e camminando tra i morti Correas è invecchiato. Il romanzo esce, ma nessuno se ne interessa.
Nel 2014, pochi mesi prima che arrivassi in Argentina, Los repotajes viene ripubblicato dalla casa editrice interZona di Buenos Aires. La curatela del volume è affidata a Edgardo Scott, giovane scrittore lanusino, che ne redige anche la prefazione. È una buona prefazione, in cui Scott tende a precisare che l’assurdità della faccenda «Borges/Arlt: un erede» non è fondata sul delirio o, ancora peggio, sull’abitudine a scomodare i due maestri, i due nemici, quando si deve scrivere una quarta di copertina. La questione è ben più precisa. È lo stesso Correas ad annotare, da qualche parte: «Visto che il mio romanzo Los reportajes de Félix Chaneton si proponeva di essere un campione qualsiasi di “cultura argentina”, ho dovuto ricorrere a Arlt, colui che ci ha insegnato che il segreto della cultura giace nella violenza». A questo punto Scott si inserisce: «Tuttavia il Chaneton rispecchia un debito meno dichiarato che è, d’altra parte, il debito di qualsiasi scrittore argentino del Ventesimo secolo: il debito con Borges. E così come non c’è scrittore che abbia recuperato meglio l’impudicizia, la scomodità e l’astuzia provocatrice di Arlt, è probabile che non esista qualcun altro che abbia dominato meglio l’innovazione borgesiana: il rigore del verso applicato alla frase».
Mi ricordo, a tre anni di distanza, delle condizioni in cui ho letto Los reportajes: Con fatica, sforzando il mio castigliano carente e modellandolo, di conseguenza, sulla forma di una lingua inesistente, che mai e poi mai mi sarebbe potuta tornare utile. Mai avrei potuto dire a qualcuno di aver ascoltato «zazuelas dal paradiso di un teatro della Avenida de Mayo». Eppure le avevo ascoltate, così come avevo ascoltato e visto e annusato molte altre cose. E ricordo di come il volume del Chaneton, l’elegante edizione nera e verde di interZona, un’edizione senza fronzoli, umile come dovrebbero essere tutte le edizioni di libri che valgono molto più del loro prezzo (345 pesos), fosse uscito dalla lettura quasi distrutto, rispecchiando le misere condizioni di colui che lo aveva letto in preda a una soprannaturale inquietudine e a un’esaltazione quasi dimenticata.
Los reportajes de Félix Chaneton
Prima parte – RODOLFO CARRERA: UN PROBLEMA MORAL: 1956, un uomo, un tale Carrera, scende nei bassifondi di Buenos Aires per cercare il figlio adolescente scomparso nel nulla. Per farsi aiutare si rivolge a un coetaneo del ragazzo, una marchetta che frequenta i teatri di Avenida Corrientes, i cinema notturni, le strade di Barracas e i postriboli nei pressi del Riachuelo, a Puente Alsina. I due vagano per la città assediata dal caldo estivo. Bevono birre ghiacciate e birre tiepide; prendono farmaci per non cadere dal sonno; si trasformano in passeggiatori angoscianti di un paesaggio palustre. Allo stesso modo, la città segue il rollio delle loro menti. Alla Buenos Aires dei vivi si sostituisce una Buenos Aires che sembra il retrobottega di se stessa. La lingua di Correas si fa liquida e dolciastra. Andiamo con i due protagonisti, fino in fondo a un incubo malinconico.
Seconda parte – EN LA VIDA DE UN PUEBLO: 1971, un uomo e sua moglie, sposati da tempo, trascorrono qualche giorno in un villaggio nella Pampa, a casa dei genitori di lei. Il microcosmo e le sue dinamiche finiscono per spalancare la voragine di vuoto che l’uomo porta con sé da quando, un giorno ben preciso, ha abbandonato la gioventù. Il villaggio è spazzato da un vento assassino e torrido che trasporta la sabbia del tempo. Ogni cosa, nel rombo dei televisori che esce dalle finestre delle casette basse lungo le strade, sembra consacrata alla fine più misera. Interni domestici. Esterni sussurranti. Un cielo pesante come terra sopra il coperchio di una bara. La morte è nell’aria, annunciata da una banda di ottoni in lontananza, una banda fantasma che suonerà alla festa municipale. L’uomo trascorre i giorni di villeggiatura in preda a un inspiegabile terrore. Mattine chiassose, pomeriggi di siesta nell’afa, notti di panico.
Terza parte – EL ÙLTIMO RECURSO: 1973, leggiamo il diario di un individuo caduto in una delle rughe della storia Argentina. In quella ruga c’è un albergo, il Mundial. È lì che l’individuo vive, riceve gli amici – scrittori falliti, professoresse drogate, vecchi omosessuali, idealisti politici. L’individuo ascolta le loro lagne e si lagna a sua volta con loro, o meglio finge di lagnarsi, perché questa è l’abitudine. Affronta i giorni come se fossero lavori forzati; le notti come ultime tracce fluorescenti di sperma su una coperta logora. In questa situazione patibolare, l’individuo si propone di inventare, in qualche modo, un nuovo tipo di uomo e di adattare quel modello a se stesso. Naturalmente – complice anche il fatto che l’individuo è, in qualche forma, uno scrittore – l’intento si dimostra irrealizzabile. Solo una certezza può balenare nella mente annebbiata dell’uomo, alla fine: Hay que vencer el miedo.
«Al centro della scena ci sono due sedie e un tavolo strapieno di carte e pile di libri sparpagliati o che fanno, addirittura, da gambe del tavolo stesso. Ci sono una macchina da scrivere Continental e tozzi di pane, formaggio, un coltello, due, o forse più, bottiglie di gin mezze vuote, vari pacchetti di sigarette e di fiammiferi. Sul tavolo, dal soffitto, pende un lampadario con un paralume che diffonde una luce fredda e compatta». [da Carlos Correas, la voluntad de vivir, pièce teatrale di Bernardo Carey , racconto degli ultimi giorni di vita di Correas (Palabras Amarillas ediciones, 2014)].
«Fra vecchie bottiglie d’acquaragia, la sua tavolozza, quella degli ultimi giorni: una pozza fangosa di grigi diversi». [ da «L’atelier di Alberto Giacometti», in Il funambolo, di Jean Genet, Adelphi 1997, traduzione di Giorgio Pinotti].
È il 27 agosto quando per puro caso scopriamo che quella sera stessa, alla libreria Gandhi di Palermo Viejo, Edgardo Scott e un pugno di altri critici e scrittori si ritroveranno per parlare di Los reportajes e della figura dimenticata di Correas. Arriviamo in anticipo. È una bella sera, un tramonto dorato di fine inverno. Per passare il tempo ci infiliamo in un posto qualsiasi e ordiniamo birra e un piatto di nachos. È uno degli ultimi giorni che passeremo a Buenos Aires, quindi oltre alla luce ocra e al profumo di alberi che rinascono nell’aria c’è una misteriosa forma di nostalgia. Qualche minuto prima dell’inizio dell’incontro guadagniamo la libreria. È un posto ordinato. Non c’è un centimetro di muro che non sia ricoperto di scaffali di legno, alcuni dei quali sono ricavati dall’impalcatura di una scala che porta al piano superiore, dove è già tutto pronto. Inclusi noi, il pubblico è composto da un vario assortimento di quindici-venti persone. Ci accomodiamo al margine. Il primo relatore prende la parola. Gli succede il secondo. Poi viene proiettata una vecchia intervista di Correas ritrovata in chissà quale archivio. Per ultimo parla Edgardo Scott. Legge qualcosa da un foglio pieno di correzioni, una riflessione sulla differenza tra letteratura e storia della letteratura. In questo iato, dice, la comparsa del Chaneton costituisce un fatto incontrovertibile e misterioso, senza precedenti né eredità significative. Correas e il suo unico romanzo, se di romanzo si può parlare, visto che neanche per i suoi saggi la definizione di saggio è del tutto corretta, sono l’esempio di come in letteratura ci sia sempre spazio per alcune sorprese in grado di riscrivere un canone sbaragliando il canone. La lettura di Scott sancisce la fine dell’incontro. Mi faccio coraggio e vado a dirgli qualcosa, che sono un lettore italiano, che ho letto Los reportajes per puro caso e che di sicuro lo rileggerò, perché l’esperienza mi ha quasi ucciso, e che proverò a farlo conoscere in Italia, dove l’attenzione verso il Sudamerica letterario negli ultimi anni ha subito un forte aumento. Scott è sorpreso. Mi dice che Correas è uno scrittore difficile anche per un argentino. Ci scambiamo gli indirizzi email, con la promessa (mai mantenuta) di scriverci. Prima di salutarmi, Scott mi lascia il foglio da cui ha letto poco prima. Lasciamo la libreria, per una volta senza comprare niente. Prendiamo un autobus e ce ne torniamo a San Telmo per la cena.
In misura variabile, per andare incontro a certe necessità, qui l’elenco di alcuni parenti di Correas: Sartre, Arlt, Jean Genet, Juan José Saer, Pierre Mac Orlan, Ramón Ribeyro, Jorge Barón Biza (Biza si suicidò buttandosi dal dodicesimo piano; Correas dal nono, ma con le vene dei polsi tagliate), Sarah Kane, Manuel Puig, Knut Hamsun, Hegel, Gottfried Benn, Osvaldo Lamborghini e (perché no?) Kafka, seduto in un bar di Flores, a due tavoli di distanza da Nestor Perlongher.
Perlongher e gli “Avatar dei ragazzi della notte”. Correas e gli Avatar degli uomini usciti dalla notte in cui erano entrati da ragazzi.
È nella prima parte del Chaneton che ho ritrovato, mentre radunavo il materiale informe e decomposto per questo articolo, un passo cruciale, accuratamente evidenziato con disegni di fil di ferro e piccole spirali: «Se il tempo mi atterrisce e mi lascio limitare dalla paura, non scriverò nient’altro che esigue meraviglie, paragrafi laboriosi e anodini. La paura del ridicolo è la paura della debolezza. Tuttavia so che la mia forza di scrittore dipende dalla mia sincerità e che la mia sincerità di scrittore dipende dalla mia forza. Se sono sincero non sarò doppio. La mia interiorità coinciderà con la mia esteriorità. Sarò vero e spontaneamente efficace, reale. Tuttavia, così come esiste quella che abbiamo chiamato “arte della sincerità” – che tende a stabilire su cosa e come si debba essere sinceri – sarà necessario che quella forza contenga la sagacia in grado di stabilire un legame con il lettore più cosciente e totale, non già con la violenza di un cross sulla mandibola, ma con quella di un proiettile perforante. (Voglio dire: “il lettore più cosciente e totale”: niente affatto il lettore più canonicamente colto o il più contemplativo o il più pratico, ma quello che ha sperimentato più a fondo la condizione umana. So in anticipo che questi individui esistono; li desidero e li voglio come miei lettori; desidero e voglio lavorare per essere degno di loro. Per loro il cross sulla mandibola, che a suo tempo è stato un concetto categorico, adesso, nel nuovo tempo, è insufficiente, ora c’è bisogno di una forza ancora più penetrante e precisa, per quanto quest’ultima non sia altro che l’eredità più squisita di quel cross».
Qui si chiude questo rapporto. La sua forma frammentaria e incompleta è dovuta alla personalità del suo oggetto e alla natura dei libri che scrisse. Uno in particolare, Los reportajes de Féix Chaneton, di cui abbiamo detto quello che era necessario dire, ovvero che si tratta di un libro pressoché consegnato all’oblio. È probabile che questo destino sia una conseguenza del fatto che Los reportajes sia un racconto dello stagno del tempo, passato, futuro o presente in maniera intercambiabile, in cui gli individui di un certo tipo languono vagando come lupi addomesticati, perduti, annusando l’idea di un suicidio o di una farsa imminente. Molti altri scritti di Correas sono stati scansionati e messi a disposizione su internet da qualche anonimo benefattore: alcuni racconti, i saggi iconoclasti di Ensayos de tolerancia, il famigerato «La narracion de la historia» (che Ricardo Piglia inserì, non senza un certo gusto provocatorio, nell’antologia Las fieras, dedicata al racconto poliziesco) e che i lettori argentini possono trovare nella raccolta di novelle Los jóvenes, e poco altro.
A oggi né il Chaneton né alcuno di questi testi sono tradotti in italiano o in nessun’altra lingua. O almeno così mi risulta. Le sorprese – lo si impara frequentando la letteratura o un qualsiasi altro postribolo – sono sempre dietro l’angolo.
Appendice: due frammenti dal Chaneton
«Nel caso delle checche i nomi “propri” costituivano la loro più irrinunciabile proprietà. Ciò che nel mondo normale era detto “nome proprio” nel mondo delle checche si spogliava della sua volgarità, la sua morbidezza e si trasformava in un blocco duro, un cristallo di esclusività, perché l’apparenza e l’essenza erano entrambe la medesima cosa. Le checche erano i loro nomi, e i loro nomi, qualità, manifestazioni, rivelazioni intorno al loro sé, finzioni, esseri mitologici, contraffazioni, sorti funeste o brillanti, titoli di nobiltà. Le checche erano la Pandora, la Nacha Regules (che portava sempre uno zainetto di cuoio contenente un asciugamani, sapone, spazzolino da denti eccetera, nel caso la fermasse la polizia e la rimandasse a Villa Devoto), l’Orchidea Nera, l’Orchidea Bianca (che secondo le altre era quella che tirava su più denaro portandosi a letto i papponi di Villa Devoto), la Rumba, la Embrollo (che morì assassinata da uno spasimante a La Boca), la Peccatrice di Shangai, la Mecha Iturbe (che teneva i soldi in banca, una casa al residence El Martínez e che procacciava donne al suo stallone – un biondo proprio carino – e allo stesso tempo lo difendeva con un pugnale dall’assedio della altre checche), la Margarita Gautier (che non poteva stare in “bar dove c’erano troppi uomini”, sarebbe a dire veri uomini, perché non la desideravano), la Cleopatra (che serviva ai tavoli in un bar chiamato On the Waterfront e faceva suonare sempre Moritat al giradischi), la Milanesa, La Carmen Miranda (il cui eloquio profondamente pornografico non mi azzardo a riprodurre), la Yuyo, la Riachuelo (chiamata così perché una volta, quando il suo stallone la lasciò, per la pena, si buttò nel Riachuelo), la Desiderata (che entrò in convento perché, secondo le checche, “si sentiva una fallita”), la Putesca, la Rebeca (chiamata così perché un tizio che una volta era andato con lei le aveva detto che era come “Rebeca, una donna indimenticabile”), la Principessina di Carapachay (che secondo le altre era molto amata e rispettata dagli abitanti della zona di Carapachay. Fatta eccezione per le notti di Carnevale non veniva mai nella Capitale Federale).
«Un ufficiale, per caso o per il vago ricordo di un qualche regolamento, stabilì che “l’invertito” non poteva restare nello stesso posto con gli altri uomini. (Adesso penso che a suo modo – un modo comune – l’ufficiale, dicendo “l’invertito”, usasse la parola più diretta e giusta: la checca era un mondo alla rovescia. Pazza, perduta, trucidata, insalvabile, niente e nessuno avrebbero potuto correggerla o raddrizzarla). Misero la checca in una cella separata».