
I
«Non sto scherzan….!»
«Voglio andare a casa! Lasciami!» m’interruppe Enrichetto.
Il suo collo era cosparso di piccolissime, scivolose goccioline di sudore che, oltre a rendere la presa difficile, provocavano in me una certa nausea, evocando un senso di disgusto e repulsione atavico per i fluidi corporei altrui.
«Ve lo ripeto signori: non sto scherz…!» continuavo a urlare, interrotta da: «Lasciami!»
La mia pazienza era al limite.
Cosa scriveva Baldassarre Castiglione?
Sprezzatura. Riuscivo a pensare solo a queste poche parole: “usar in ogni cosa una certa sprezzatura, che nasconda l’arte e dimostri ciò che si fa e dice venir fatto senza fatica e quasi senza pensarvi”. Le ballerine di danza classica sulle punte? Sprezzatura. Gli acrobati del circo? Sprezzatura. La disperata malvivente che prende in ostaggio un ragazzino di dieci anni minacciandolo con una carota da duecentomila euro sotto lo sguardo attonito e atterrito di operatori museali specializzati? Somma sprezzatura.
Non ho mai preso lezioni di danza né ho mai amato il circo, ma posso assicurare che minacciare un ragazzino zuppo di sudore è complicato. Nonostante il terrore, Enrichetto non si rassegnava al suo destino di ostaggio e continuava a dimenarsi con i suoi cinquanta chili di adipe e crostatine alla crema di cacao. I piccoli calci che assestavo ritmicamente ai suoi talloni non servivano a quietarlo: ne voleva conto e ragione, voglio andare dalla mamma, continuava a ripetere, lasciami andare.
Tutto ciò mi infastidiva non poco: ma chi si credeva di essere quel ragazzino che aveva addirittura l’ardire di interrompere chi lo teneva in ostaggio? E soprattutto: perché non avevo riflettuto prima di scegliere, afferrando così il bambino meno scivoloso, più basso e meno insolente?
Osservavo dall’alto l’attaccatura dei suoi capelli neri e unti, la punta delle scarpe appena visibile oltre la linea curva della pancia, il piccolo strappo in prossimità del colletto della polo azzurra. Sentivo quel corpo, piccolo ma possente, scalpitare sotto la presa disperata delle mie braccia, e la mia convinzione vacillava.
II
Ricordo l’istante in cui tutto ha avuto inizio perché fui perfettamente consapevole dell’importanza di ciò che stava accadendo, degli eventi che ne sarebbero scaturiti e che mi avrebbero investita, prima o poi, con la forza dell’ineluttabilità.
Ricordo di aver provato, per la seconda volta in tutta la mia vita, una sensazione di piccolezza e inadeguatezza.
La prima volta mi trovavo a Notre-Dame, a Parigi, e il senso d’inferiorità escatologico-esistenziale era dovuto alla superba abilità dell’architetto che, rispondendo ai canoni di quello che viene chiamato “stile gotico”, progettò un edificio altissimo, dalle pareti sottili ma robuste, trafitte da vetrate colorate che spezzano l’oscurità. “Dio è grande, infinito, noi non siamo che granelli di polvere”: ecco cosa urla una chiesa in gotico francese.
Piansi di commozione ascoltando la messa cantata da un coro polifonico e pensai che sì, siamo granelli di polvere, ma dovremmo essere grati per ogni singolo istante di questa turbolenza chimica chiamata vita.
La seconda volta fu il novembre 2008. Vivevo da appena un anno in una città grande dieci volte quella in cui sono nata, indossavo una vecchia tuta scolorita e pantofole scalcagnate. Stavo pasteggiando con lenticchie e pancarrè – un classico delle serate invernali, in cui la mancanza di perizia culinaria si unisce alla disperazione dell’appetito – quando Obama apparve sul televisore e disse: «Ragà, nun gliela famo». O meglio disse qualcosa di tecnicamente ineccepibile, utilizzò termini esatti e pertinenti ma il senso che io masticai, insieme alle lenticchie appena riscaldate, insieme a un’imprecazione e alla consapevolezza che la mia scommessa era persa in partenza, fu questo:
Amici europei,
mi sono distratto un attimo e Wall Street mi è sfuggita di mano.
Ci aspettano tempi duri ma, giusto per non lasciarvi dire che non vi abbiamo avvertiti, quest’ondata di nichilismo economico arriverà anche da voi, anzi, vi dirò di più: durerà più da voi che da noi.
Se avevate progetti di vita, sogni, ambizioni – sono mortificato – ma credo che dobbiate lasciar perdere.
Le vostre economie ne risentiranno per decenni e non so se avete mai sentito parlare di un certo Latouche che scrive della decrescita felice… Perfetto, comprate il suo libro mentre ancora avete qualche spicciolo in tasca, studiatelo bene e fraintendetelo completamente, come solo voi sapete fare, poi rimettete su le ‘comuni’, rispolverate i furgoncini Volkswagen, mettete dei fiori nei vostri sandali rotti.
Colgo l’occasione per mandarvi un caro saluto e ricordarvi che zio Tom ogni tanto dà e ogni tanto prende. La vostra generazione passerà il turno, se riuscirete a riprodurvi. Forse, ci saranno speranze.
Barack
Avevo diciannove anni ed ero iscritta al secondo anno di università. La scelta della facoltà aveva richiesto calcoli ponderati e aveva comportato una significativa dose di ansie e incertezze finché una notte, concedendomi l’unica azione da ribelle in un’adolescenza ligia al dovere, fumai una Winston blue e sollevai gli occhi al cielo d’estate. Pensai alle punzonature di Simone Martini, ai cieli stellati di Van Gogh, mi tornò in mente Notre-Dame, ricordai le lacrime. Non avevo mai provato nulla di più doloroso, straziante e consolante insieme. Spegnendo la sigaretta capii che nulla mi avrebbe resa più felice dello studio della storia dell’arte.
I miei genitori provarono in tutti i modi a farmi desistere e arrivammo ad un compromesso: se per il primo anno non mi fossi rivelata una studentessa eccellente avrei abdicato alla loro volontà di vedermi avvocato.
«Non ammetto obiezioni: devi superare tutti gli esami del primo anno con 30 e lode» disse mio padre.
«Trenta e lode mi sembra un po’ eccessivo, Roberto» replicò mia madre, donna pietosa e comprensiva, cuscinetto emotivo nelle circostanze ad alta tensione. «Concedile la possibilità di sbagliare: facciamoci bastare la media del trenta.»
Mio padre annuì, io preparai un paio di valigie e partii con il cuore leggero e le spalle gravate dal senso di responsabilità.
Ebbe ragione lei: su sette esami sostenuti il primo anno presi solo quattro lodi. Nonostante il muto sospiro di mia madre ce l’avevo fatta: potevo restare. Sarei diventata una storica dell’arte.
Immaginate, ora, il mio sgomento all’ascolto del celebre discorso di Obama.
Mi invase di colpo, come una scossa, l’agghiacciante consapevolezza che tutti i miei sforzi si sarebbero rivelati inutili.
III
Negli anni successivi mi impegnai parecchio. Continuavo a credere che ottenere ottimi risultati sarebbe bastato per conquistarmi un posto nel mondo del lavoro.
Satolla com’ero di retorica yuppie riciclata e confezionata ad hoc dalla parte romantico-titanica-reaganiana di me, mi laureai con il massimo dei voti. Avevo trascorso un semestre all’estero durante il quale avevo imparato il tedesco, perfezionato poi con lezioni private a (lauto) pagamento; frequentai tre corsi estivi in Irlanda e Inghilterra; sapevo usare tutti i programmi del pacchetto Office e un apposito attestato conseguito dietro (lauto) pagamento lo confermava; portai a termine stages semestrali in due tra i più importanti musei di arte contemporanea d’Italia, con ottime referenze finali. Chi mi conosceva sapeva quanto precisa, determinata e al tempo stesso infaticabile fossi. Un estratto della mia tesi di laurea specialistica fu pubblicato da un importante editore, la percentuale di vendite è stata irrilevante, il guadagno nullo, ma la soddisfazione alta; facendo una media tra i tre fattori non avevo motivo di reputarmi completamente infelice.
Dopo tutto questo ero agguerrita e determinata.
Poi, come molti, mi persi.
Gli enti pubblici non avevano abbastanza denaro per assumere né per proporre un contratto a progetto. Il loro organico era composto da una parte da impiegati statali inamovibili, ultracinquantenni, mediocremente preparati allo svolgimento dei loro doveri contrattuali, dall’altra da stagisti curriculari sui quali ricadevano tutti gli oneri, nessun onore e neanche l’ombra di un compenso.
Nelle strutture private c’era la possibilità di essere assunti per periodi brevi o brevissimi e pregevolmente insigniti di un lauto, a loro dire, rimborso spese di due o trecento euro mensili. Erano richiesti tempo pieno, massima reperibilità anche nei giorni festivi e non veniva concesso alcun permesso per malattia, né erano contemplati problemi di natura etica nel sostituirti con un collega dalle minori aspettative.
Per un paio di mesi navigai nel vuoto. Mandavo curricula che restavano senza risposta, sostenevo colloqui che non portavano a nulla. I miei genitori iniziarono a lamentarsi, fu un susseguirsi di «Io te l’avevo detto» e «Perché non torni a casa?», che oltre a spazientirmi ebbero l’effetto di alienarmi anche l’ultima briciola di fiducia: se avevano perso le speranze loro perché avrei dovuto nutrirne io?
Il concorso per il dottorato si sarebbe tenuto solo nove mesi dopo, ma io avevo bisogno di tenermi impegnata, di soffocare nella routine le mie giornate ormai irrimediabilmente compromesse dalla noia e dalla frustrazione. Iniziai a lavorare part-time presso un’impresa di pulizie il cui capo, sebbene ritenesse che il mio curriculum fosse sproporzionato per le mansioni che avrei dovuto rivestire, mi prese in simpatia e mi assunse in nero.
Lavorando quattro ore al giorno, cinque giorni a settimana, riuscivo a malapena a pagare l’affitto, i miei genitori continuavano a finanziare le mie incursioni al discount senza nascondere il malcontento per quella figlia promettente che si era persa per strada. Le loro voci al telefono erano sempre meno affettuose, finché le conversazioni non divennero brevi scambi informativi sui reciproci spostamenti.
Trascorsi l’estate pulendo i pavimenti di una grande filiale bancaria del centro e lavorando al progetto di ricerca da presentare al concorso per il dottorato. Dormii pochissimo, mangiai peggio del solito, alternai sessioni intensive di sgrassatore e disinfettante a Derrida e Foucault.
Quando consegnai il materiale richiesto dal concorso mi sentii leggera come non accadeva da mesi e quella notte sprofondai in un sonno senza sogni.
IV
Al concorso per il dottorato mi posizionai in decima e ultima posizione: ero rientrata tra i vincitori, certo, ma non avevo diritto alla borsa di studio. Significava lavorare gratis per tre anni: ecco la beffa.
I miei genitori mi consigliarono di accettare, ma io per conservare un barlume di dignità agli occhi del mio sconsolato super-io decisi di non lasciare il mio lavoro part-time.
Credo che fu quello il periodo in cui mi si inceppò qualcosa dentro, come un interruttore che resta bloccato su on più del dovuto; la mia capacità di dissimulazione e di contenimento, in una parola di sprezzatura, andò a farsi benedire.
Iniziai a non dire più “Grazie”, “Prego” o “È stato un piacere”. Qualche mese dopo fu la volta di “Scusa”: di cosa mi sarei dovuta scusare? Non dovevo nulla a nessuno e se anche avessi starnutito addosso al mio datore di lavoro – cosa realmente accaduta sotto il giogo di una virulenta influenza – non avrei ritenuto opportuno chiedere venia. Le mie domande, non più addolcite dall’uso del condizionale, divennero perentorie richieste; i miei modi, dapprima improntati ad una sobria e dissimulata eleganza, si fecero nervosi e rapaci; alle riunioni mensili tra dottorandi e docenti mi limitavo a poche e secche affermazioni circa lo sviluppo delle mie ricerche.
Ero arrabbiata, offesa con qualcosa che percepivo troppo più grande di me, incredibilmente delusa da me stessa e dalla stupidità dei miei buoni propositi. “Avrei dovuto saperlo”, continuavo a ripetermi, “avrei dovuto immaginarlo”.
Lo scorso marzo il destino mi giocò l’ennesimo tiro mancino. L’impresa di pulizie in cui lavoravo vinse un importante appalto presso alcune strutture del comune tra cui – e qui si vede la natura matrigna di cui parlava Leopardi – un museo presso il quale avevo lavorato (gratis) un anno e mezzo prima.
Feci di tutto per non prestare servizio lì, ma alla fine dovetti soccombere al diktat del boss: o sostituisci Graziella che è in maternità o te ne vai.
V
Di quel primo giorno ricordo molto poco.
Ricordo un turbinio di emozioni e un sommuoversi di viscere nell’osservare l’allestimento di una sala dedicata ad un artista concettuale, ricordo una collega che balbettò, in riferimento ad una macchia di caffè in prossimità dell’entrata: «Tu che ne capisci, ma sta roba qui, a terra, che è? La devo lavà?». La rassicurai: quella macchia non è arte, puoi toglierla con probo e lieto intendimento.
Da uno dei corridoi intercettai Bianca, una ragazza che aveva portato a termine lo stage con me. Indossava un tailleur nero, aveva i capelli più corti e, sulla giacca, uno scintillante badge. Quando mi riconobbe non nascose la sorpresa: «Sei proprio tu?» mi chiese sorridendo. Io annui. «È fantastico rivederti, vieni, ti offro un caffè». Mi prese sottobraccio e mi portò nella saletta riservata al personale.
Mi parlò per un tempo infinito di come avesse deciso di trasferirsi a Londra dopo la laurea, decisione fortunosamente vanificata dall’aver trovato immediatamente impiego.
«Proprio qui, ti rendi conto? Che fortuna!»
Non riuscivo ad essere felice per lei tanto era il senso di frustrazione che provavo.
«Come hai fatto?». Fu l’unica cosa che riuscii a sussurrare.
Bianca bevve un sorso di caffè e mi scortò fuori dal cancello. Si accese una sigaretta, me ne offrii una, che rifiutai.
«Mia sorella Stefania, te la ricordi?»
Ricordavo che Bianca avesse una sorella ma non ricordavo di averla mai vista.
«Stefania ha sposato Giorgio Tacchinelli.»
Un nome, una garanzia. Bianca aveva pronunciato una di quelle frasi per cui non è necessario chiedere altro: “Tacchinelli” significava già tutto – influenza politica, denaro, potere sulle dinamiche del territorio.
«Sai, Giorgio si sta battendo molto per noi giovani, crede che sia ingiusto avere una laurea ed essere costretti a lavare piatti a Londra.»
Da lì i miei ricordi si fanno più sfocati. Ricordo qualche altra frase circa i meriti del cognato, ricordo di averla salutata e di essere tornata al mio lavoro dall’altra parte dell’edificio, nell’area ristoro subito fuori la sala espositiva maggiore.
Il resto fu un susseguirsi di eventi rovinosi.
Due bambini, uno grassottello e uno magro, si rincorrevano nella sala gorgheggiando parole in libertà; quattro adulti, due uomini e due donne, li seguivano a distanza, indicando le installazioni e gesticolando con fare serioso; la guardasala biascicò un «Fermi!» quand’era già troppo tardi: spingendosi i due bambini erano caduti sull’installazione principale, una scacchiera di vetro poggiata sul pavimento. Il rumore del vetro infranto fu secco, ma nettamente percepibile.
Non so come ho afferrato la scultura dal titolo Fame nel mondo, non so come ho afferrato il ragazzino grasso per un braccio e ho iniziato a urlare. Non saprei ripetere cosa.
VI
Quel cambiamento di segno che era avvenuto in me pochi minuti prima – quel passaggio dalla teoria alla prassi, dall’indifferenza alla militanza – era lo svincolo obbligato di un percorso iniziato tempo addietro e disseminato di frustrazione e umiliazione.
«Enrichetto!», aveva urlato una delle due donne scagliandosi verso di me.
«Signora!», l’aveva bloccata la guardasala. «Quella scultura vale duecentomila euro!»
«La carota?», chiese la madre dopo un attimo di perplesso silenzio.
La guardia annuì e in quel momento il direttore entrò nella sala. Mi voltai per guardarlo in volto: aveva paura. Avanzava come un gatto alla ricerca di crocchette nascoste.
«La prego, si calmi» disse infine, fissandomi negli occhi. «Ne possiamo parlare.»
Cosa avrei dovuto dire? Avrei dovuto procedere ad un’approfondita disanima della mia condizione economica? Avrei dovuto accennare al tono rassegnato dei miei genitori, al paternalismo negli occhi dei professori, alle risate fuori luogo del mio unico datore di lavoro? Quei bambini avevano rotto un’opera d’arte sotto gli occhi distratti dei genitori, il mercato aveva distrutto la mia vita semplicemente esplodendo, il rumore secco del vetro infranto mi ricordò quello di una bolla che, per accidente, aveva perso l’uniformità dei legami chimici lungo la superficie.
Con chi avrei dovuto prendermela? Con lo Stato? Con i brokers di Wall Street? Con me stessa, per aver seguito un sogno a breve scadenza?
Entrarono due guardie della security grasse, flaccide e sudate per la breve corsa. Ne ebbi compassione. Poi provai pena anche per me, per quel direttore che sarebbe stato l’unico capro espiatorio, per la mia collega che mi fissava sconvolta, per il bambino che continuava ad interrompere ogni mio tentativo di espressione verbale.
Fu un attimo e mi ritrovai per terra. I guardiani avevano chiamato la polizia, un paio di giovanotti in divisa mi ammanettarono.
Pensai ai titoli del giorno dopo: “Giovane precaria minaccia un bambino con carota artistica”. L’ennesima presa in giro, sostituita in breve da un’altra notizia.
Quando mi hanno revocato la possibilità di concludere il dottorato mi sono sentita sollevata. Oggi che insegno storia dell’arte alle colleghe del carcere, mi pare di essere riuscita a invertire la marea.
Sono di nuovo su off. Qui non mi manca niente. Mi trattano bene, i pasti sono caldi. Mi pagano poco, ma sono tutti soldi guadagnati. Sono persino riuscita a ottenere un balsamo per capelli secchi.



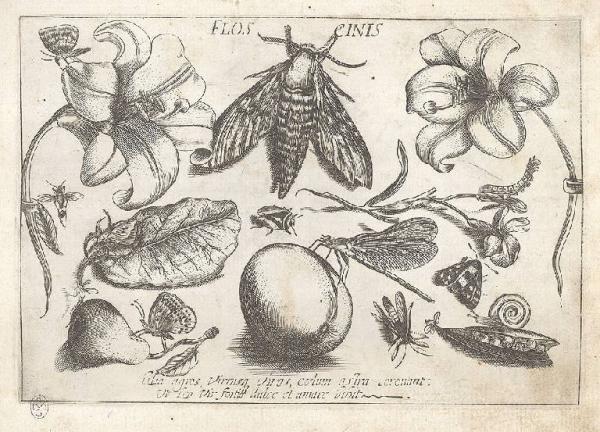
Complimenti!