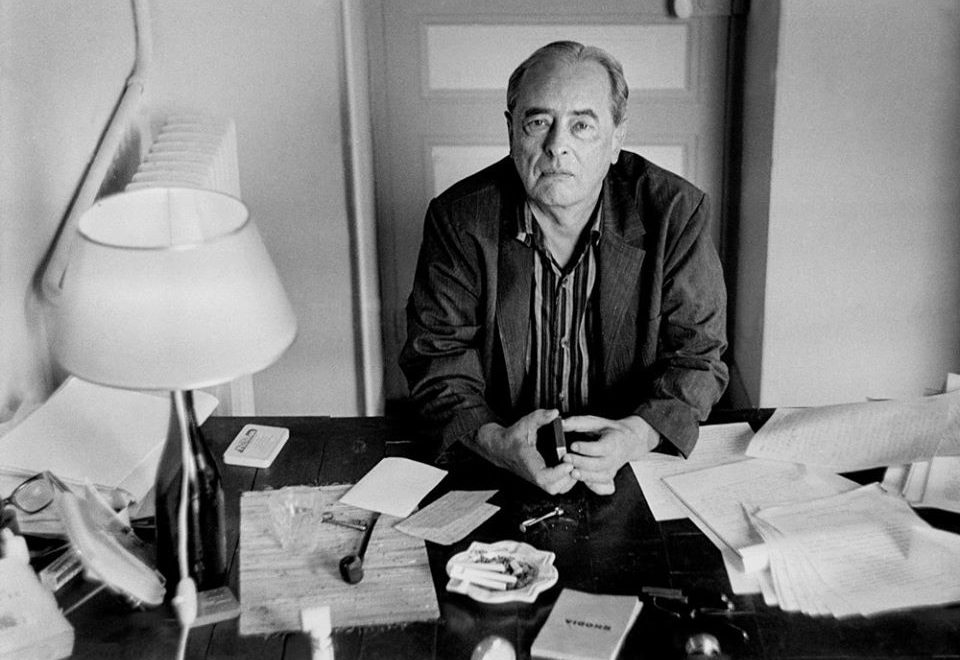Chi era Emily Brontë? E come è stato possibile per l’algida e schiva figliola di un pastore anglicano, che ha vissuto la sua breve vita quasi interamente confinata dentro una canonica in mezzo alla brughiera, concepire l’idea di una passione totale e totalizzante quale è al centro di Cime tempestose? Da simili interrogativi prende le mosse il romanzo di Sara Mazzini, uscito il 28 settembre per Jo March Literary Agency, frutto di una conferenza tenutasi alla Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia e di un anno di ricerche, e basato tanto sui romanzi della sorella Charlotte quanto sulle moderne biografie di Juliet Barker e Edward Chitham. Per gentile concessione dell’editore, di seguito pubblichiamo in anteprima un estratto dal romanzo.
Poco prima che Charlotte partisse per Roe Head, il gioco degli isolani giunse a un punto di rottura. Un pomeriggio, mentre stavamo inscenando una storia coi soldatini, il suo personaggio, per pura rappresaglia, si sedette sopra il mio; io persi la pazienza e presi a scagliare oggetti per tutta la stanza, rifiutandomi di proseguire. Charlotte intuì che la mia acredine non era dovuta soltanto all’offesa subita da Parry e mi lasciò il tempo necessario per sbollire, ma io non ero tipo su cui simili incidenti potessero passare senza lasciar segno. Qualcosa mi si era rotto dentro e mi impediva di avvicinarmi a lei con la spontaneità di un tempo.
Se da un lato avevo perso la complicità con Charlotte, dall’altro il mondo marziale che Branwell aveva creato continuava a rigettarmi, e il suo approccio dispotico alla conduzione delle storie mi impediva di inserirmi. Charlotte invece seguiva la guida di nostro fratello quasi senza discuterla. Aveva deciso di diventare una scrittrice e, poiché tutti gli autori dei libri di papà erano uomini, si era messa in competizione con loro, inventando e raffinando nuove voci maschili. Nel regno di “Angria”, che lei e Branwell svilupparono da soli, tutti gli uomini complottavano per la conquista del potere e tutte le donne si struggevano per un unico, fugace, istante di passione.
Per natura Charlotte aveva la vista corta e a forza di scrivere sui libri in miniatura finì col guastarsela del tutto. Per leggere un libro doveva chinarvi sopra la testa, e quando la zia le ordinava di raddrizzare la schiena lei obbediva tenendosi il libro davanti alla faccia, quasi appiccicato al naso. Prima di iscriverla a scuola mio padre dovette provvedere a fornirle un paio di occhiali dalle piccole lenti rotonde e la montatura di tartaruga. Lei li indossava solo quando vi era costretta, non sopportando il modo in cui mortificavano il suo aspetto, nascondendo l’unico particolare del suo volto che trovava interessante: i suoi occhi, gentili ed espressivi, così chiari da sembrare di diamante.
Quando uscivamo a passeggio piegava gli occhiali per nasconderseli in tasca, temendo di essere scorta da qualcuno. La miopia la rendeva vulnerabile all’ambiente circostante, di cui non riusciva a intuire i contorni, ed era costretta a fare passi molto brevi per saggiare il terreno prima di abbandonarvisi con il suo peso. Cominciò a odiare le lunghe passeggiate, soprattutto nei pomeriggi d’inverno, quando il sole calava troppo presto lasciando spazio a un riverberante crepuscolo. In quei momenti si sentiva smarrita, incapace di distinguere una pietra da una lastra di ghiaccio, ma piuttosto che rendersi brutta preferiva fermarsi e tentare di smuovere la nostra compassione, lamentando mani e piedi intirizziti per il freddo e sperando con questo di convincerci a tornare verso casa.
Solo quando la meta del viaggio era Ponden accantonava i suoi scrupoli e inforcava le lenti per camminare più in fretta, anche se questo la stancava così tanto da causarle il mal di testa. Benché la superiorità sociale degli Heaton costituisse di per sé un ragionevole motivo di disagio, non riusciva a fare a meno di sacrificare i crucci della vanità pur di riempirsi gli occhi della varietà di tinte che accendevano le colline attorno alla loro secolare dimora. Subiva il fascino del luogo pur senza condividere il significato che esso aveva per Branwell, per Anne e per me. Quando noi avevamo rischiato la vita a causa della Grande Eruzione, lei era già a Cowan Bridge. Non aveva assistito al disfacimento della brughiera, né era stata tratta in salvo giusto in tempo per avere una visione sulla vera natura del paradiso.
Adesso, a distanza di anni, le colline mostravano ancora i segni del prodigio. Anne lo ricordava a malapena e poteva solo turbarsi alla vista dei solchi profondi che attraversavano il terreno come ferite vive, intasate dai detriti. Io sentivo un simile spacco dividere in due la mia essenza, e più tardi avrei scoperto che anche mio fratello ne aveva uno dentro di sé.
In ragione di ciò, trovai del tutto naturale che sulla fronte del signor Heaton si fosse aperta una ruga rassomigliante a uno squarcio, quasi a rivelazione del suo legame simbiotico con quella terra dura e brulla in cui la sua stirpe aveva messo le radici fin dal tempo degli Enrichi. L’Eruzione aveva inondato i suoi campi di mais, distrutto i suoi magnifici vigneti, affogato molte delle api e demolito il suo mulino. Da quel terribile giorno i suoi possedimenti non erano stati più gli stessi, e lui insieme a loro. All’apparenza era rimasto il solito signore di campagna, semplice nei modi e rustico negli affetti, amante della vita ritirata, della caccia e del lavoro manuale, così come amava la sua grigia dimora dall’anima antica, coi numerosi comignoli e il giardino fitto di siepi di bosso striate di azzurro, e la brughiera purpurea che le sorgeva attorno, nei suoi tramonti cretacei e piovigginosi. E tuttavia, dal giorno in cui ci aveva tratti in salvo in mezzo alla tempesta, un cambiamento appena percettibile si era verificato in lui, come se un germe venefico si fosse fatto strada nel suo spirito, deciso a consumarlo a poco a poco.
Da vero gentiluomo, lui non vi dava peso e sfidava la sua malinconia con un eccesso di baldorie, aprendo la sua casa ad amici, conoscenti, viandanti e bisognosi, e ospitando per loro concerti di bande di ottoni. Sua moglie accettava di buon grado l’incessante chiasso della festa, perché era ancora giovane e fiorente e riteneva che la sua bellezza sarebbe andata sprecata nella troppa solitudine.
Al loro primo figlio se ne erano aggiunti altri due, William e John, di cinque e tre anni. Il maggiore ne aveva ormai nove e portava il nome Robert, come altre sette generazioni di Heaton prima di lui. Aveva gli occhi più azzurri che avessi mai visto, grandi e indagatori – si piantavano in faccia alla gente con una curiosità indolente. Mi sembrava che fossero dappertutto, perché ovunque mi girassi me li ritrovavo addosso.
Sebbene fosse più piccolo di me di quattro anni, Robert Heaton era molto più istruito. Aveva un tutore privato, e Ponden Hall vantava la migliore biblioteca del West Riding. Dall’intrico di travi che sorreggeva il soffitto scendevano giù fino a terra eleganti scaffali riempiti dalle coste istoriate dei volumi più disparati, acquistati dal signor Heaton in occasione dei suoi frequenti viaggi a Londra. C’erano libri di legge e di storia locale, romanzi gotici, racconti goliardici e perfino poesie erotiche, oltre a una preziosa prima edizione delle opere di Shakespeare.
Per noi Brontë era un luogo pieno di magia, e ben presto il motivo principale delle nostre visite divenne quello di prendere in prestito un libro o di restituirne un altro.
Sera dopo sera rientravo alla canonica con le scarpe incrostate di fango e le guance arrossate dall’eccitazione, il grembiule imbottito di libri e una sferzante ispirazione per le mie storie future. Attorno a me l’aria fresca aveva l’odore del ghiaccio che incrostava i ciuffi d’erba, e le colline annerite dall’ombra risuonavano degli ultimi canti delle allodole. La fatica fisica era l’unica cura efficace contro l’insonnia febbrile che da sempre mi affliggeva: se il giorno mi portava emozioni stimolanti non avevo che da stendermi e chiudere gli occhi per affondare in un sonno profondo – sicché la frequenza delle mie scampagnate si intensificò quando Charlotte partì per Roe Head, lasciandomi di nuovo abbandonata e infreddolita nel mio letto ad arrugginirmi il sangue col pensiero che, avendomi tradito, lei non meritava la mia nostalgia. Le sue lettere settimanali erano indirizzate a Branwell, perché era a lui che aveva più cose da dire.
Per vendicarmi mi appropriai di Gondal e scelsi di svilupparne le trame da sola. Di più: mi concessi l’atto sovversivo di affidare un ruolo di spicco a una donna, creata sul modello della principessa Alessandrina Vittoria, erede al trono d’Inghilterra.
Nello stesso momento mi accorsi che Anne, a undici anni di età, stava diventando una creatura interessante. Dietro i suoi grandi occhi blu guardava al mondo con la sua indole docile e malleabile, poiché era sempre stata abituata a vivere nell’ombra della zia – da qualche tempo, tuttavia, quella aveva cominciato ad allentare la sua morsa di rivendicazione sulla piccina di casa, giacché nella sua coscienza era in atto una controversia angosciosa tra il desiderio di mantenere l’atteggiamento affettuoso di sempre e l’incapacità di riconoscere la cara creaturina sotto le sue nuove forme di ragazza. In particolare, la signorina Branwell non sopportava la vista del bel viso affusolato e pensieroso che aveva preso il posto del faccino su cui era stata solita appiccicare i suoi baci. Non tollerava più gli abbracci, che la mettevano nella scomoda posizione di dover respingere un seno pronunciato quasi quanto il suo. Odiava, insomma, quella nuova Anne dal collo di cigno e la carnagione di perla, che le aveva rubato anche la sua ultima consolazione.
A volte, quando si ritrovava sola dentro la sua stanza, sentiva il cuore avvizzirsi e lo stomaco salirle nella gola.
“Dov’è la mia bambina?”, si chiedeva.
Lo squilibrio giocò a mio vantaggio, procurandomi la compagna di giochi ideale. Essendo più grande di Anne avevo il potere di farla divertire, e questo mi lusingava.
Nonostante lo spettro dell’asma che le incombeva addosso come una maledizione, Anne era in grado di seguirmi attraverso la brughiera senza affaticarsi, e quando venne giugno prendemmo l’abitudine di uscire ogni mattina, prima di essere chiamate a spazzolare o a ricamare, e poi ancora nel tardo pomeriggio. Ci facevamo strada tra le felci e intanto apportavamo un altro tocco al nostro mondo immaginario, e ci fermavamo a riposare presso le pietre miliari e i muri a secco che racchiudevano i campi.
Quando eravamo esauste ci lasciavamo cadere sull’erba trapunta di giunchiglie e restavamo così, a osservare le infinite mutazioni delle nuvole nel cielo, mentre i galli si chiamavano tra loro da un lato all’altro dell’altipiano. Ci riempivamo il capo di suoni e di visioni, e il mio cuore smaniava per abbandonarmi il petto. Mio padre ci aveva insegnato che Dio stava nella natura, ma io cominciavo a sentire che Dio era la natura.
«Emmii» diceva Anne, con gli occhi tremanti per l’aspettativa, «dove pensi che saremo tra quattro anni?».
«Spero proprio che saremo qui.»
«Ma come? Non vorresti andartene?»
«E dove?»
«Non lo so. In qualche luogo.»
«Cosa c’è che non va in questo luogo?»
«Niente, è solo che… non vorresti vedere com’è il resto del mondo?»
«E perché mai? Non può essere più bello della nostra Inghilterra.»
«Non pretendo di affermare che sarà più bello; solo diverso.»
«Ti sbagli, Annie. In qualsiasi altro luogo troveresti esattamente tutto quello che c’è qui.»
«Eppure, ricordo che un tempo desideravi esplorare l’Artico.»
«Lo desideravo, è vero, ma adesso non ne ho più bisogno.»
«Perché?»
«Perché l’ho visto.»
«Lo hai visto? E dove?»
«Come fai a non capirlo, Annie? È proprio sotto i nostri occhi.»
«Ma dove? Dimmelo, ti prego!»
«Ebbene, se proprio non ci arrivi. L’ho visto negli occhi degli uccelli che giungono all’inizio dell’inverno, sospinti dal vento polare. Li ho osservati attentamente e attraverso i loro sguardi allucinati ho visto le punte aguzze e monumentali degli iceberg schiantarsi tra loro nelle acque gelate, al largo degli strati colossali di ghiaccio e di neve risultanti da una successione di centinaia e centinaia di inverni. Se le portano addosso, quelle visioni, anche quando, tremanti e rinsecchiti, approdano qui in cerca di qualcosa da mangiare. Allo stesso modo, tu ti porteresti appresso ovunque la brughiera in cui sei nata. Non capisci, Annie? Non c’è modo di fuggire, dunque non desiderarlo.»
Anne non capiva, ma non metteva in dubbio la saggezza intrinseca alle mie parole, così ermetiche da apparirle ispirate da una voce superiore; e, benché questo non spegnesse la sua brama di scoprire il mondo, la attribuiva a un capriccio puerile che sotto la sferza del mio esempio cercava in ogni modo di respingere e ignorare; e, quanto più lo respingeva, tanto più quel desiderio si fortificava.
Così, nella totale ignoranza dei reciproci sentimenti, la nostra amicizia cresceva giorno dopo giorno. Insieme, leggevamo i libri che il signor Heaton ci aveva prestato, e sviluppammo una comune ammirazione per l’irlandese Tom Moore. Proprio in quel tempo fu data alle stampe la sua Vita di Byron, che il Blackwood definì come “la miglior biografia in lingua inglese” – benché molti critici la liquidassero come pornografia, ritenendo che certi dettagli della vita del poeta non dovessero essere resi di pubblico dominio. In forza dell’amicizia tra Byron e Shelley, Moore aveva incluso nel suo libro un celebre ritratto di quest’altro poeta, e qualcosa nel suo sguardo mi spinse a investigare su di lui.
Presi in prestito Epipsychidion e lo lessi con Anne. Era un poemetto indirizzato a Teresa Emilia Viviani, in cui Shelley individuava una sorta di gemella spirituale. “Emily”, diceva “io non sono tuo, sono parte di te“.
«Oh, Emmii», disse Anne. «Sembra scritto per te, non trovi?»
Lo trovavo – e quei versi mi trafissero i sensi come una vertigine, perché, per il loro tramite, Shelley sembrava parlare con me dalla terra dei morti.
Al tempo in cui scrisse il poema era già sposato con Mary, eppure non fece mistero della sua attrazione per Emily, così come di quella per Jane Williams. Quale meraviglioso prodigio del caso! Emily e Jane erano i miei nomi, e io mi ero abituata a considerarli come i due distinti aspetti della mia persona. Quando Charlotte era arrabbiata con me mi chiamava Jane. Lei amava solo Emily, mentre Shelley, ne ero certa, ci avrebbe amate entrambe, perché sapeva che all’amore non si possono imporre limitazioni.
Lessi e rilessi i suoi versi fino a consumare le pagine di libri che non mi appartenevano, dimenticando che non mi appartenevano, e riempiendone i margini con disegni partoriti dalla mia disattenzione – e la mia firma dappertutto, a fare da eco al nome impresso sull’intestazione. R Heaton, EJ Brontë. R Heaton, EJ Shelley.
Mi sentivo investita di un’energia nuova. Per anni ero stata abituata a ritenere che i miei sentimenti, le mie emozioni e i miei pensieri fossero il frutto di una mente squilibrata, ma adesso li ritrovavo nei versi di un’altra persona e capivo che non erano un errore, bensì l’espressione genuina di una natura peculiare.
Capii di avere una missione, e che dovevo scrivere. Che fosse un dovere e non un semplice capriccio lo capivo dal modo in cui gli spiriti comunicavano con me attraverso le parole, come se avessero lasciato i loro codici affinché io potessi scoprirli e decifrarli, per contribuire all’opera che ogni autore raccoglie dalla generazione precedente e che trasmette a quella successiva, fin dal tempo in cui la prima linea venne incisa sulla pietra.
Durante la notte visioni tumultuose si affollavano attorno al mio letto. L’ombra di Shelley prendeva forma al mio fianco, e io gli promisi che ne avrei avuto cura, perché grazie a lui la mia giovinezza era stata benedetta. In ogni momento della vita, aveva detto il poeta, si è sempre innamorati di qualcuno o di qualcosa. Io, a quattordici anni di età, mi innamorai di lui, che non esisteva più.
 Sara Mazzini
Sara Mazzini
Centinaia di inverni. La vita e le morti di Emily Brontë
Jo March, 2018
pp. 288
In copertina: Tim Green, “Top Withens” (2016)