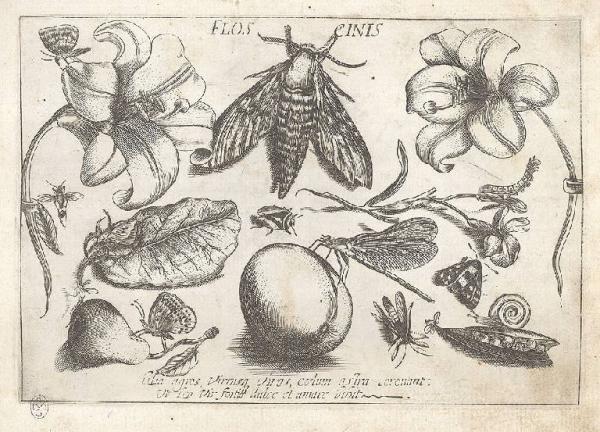Quando il direttore del mensile culturale, che corteggiavo da due anni, mi telefonò per domandarmi un pezzo su Goffredo Raineri, mi emozionai tanto da dimenticare di chiedergli quale fosse il compenso. Ma era il 1998, e noi addetti ai lavori non eravamo ancora ridotti a dar via nostra madre per un pezzo a tutta pagina ben retribuito.
Mi ripromisi di passare in redazione in settimana, l’unica cosa che m’importasse era che Palazzi avesse ripescato il mio curriculum e impegnato il suo prezioso dito per comporre il mio numero di telefono. Che lo avesse fatto perché avevo affiancato Raineri per la riduzione teatrale di alcuni lavori, o perché avesse apprezzato il mio primo e ultimo romanzo, un mediocre noir alla francese uscito tre anni prima, non era importante. Avevo il pezzo, il giornale aveva fiducia in me e nella mia penna, e io avevo il gancio con Raineri.
Sull’attore regista di origini moscovite negli anni erano circolate voci incredibili. Quella sulla dipendenza da cibo e sesso la più accreditata. Decine le giovani attrici che, prima che l’esame del DNA fosse reso accessibile a tutti, gli avevano attribuito paternità e responsabilità verso un gran numero di figli. Comunque, per dare loro il benservito, Raineri non aveva mai avuto la necessità di vendere il samovar di famiglia che la madre aveva ricevuto in dono dalla nipote dello zar Nicola II. Oltre a possedere un gran fascino, Goffredo era forse uno dei pochi artisti a non aver mai avuto bisogno di guadagnare, godendo di una rendita cospicua sin dalla morte prematura del padre armatore.
Nessuno, però, aveva mai percepito questa differenza di censo. Raineri aveva l’abitudine di lasciare agli amministratori di compagnia il compito di saldare i conti salati degli hotel e porre rimedio alla scia di pettegolezzi su orge e altre incredibili attività consumate in camera sua.
Mi feci coraggio e telefonai a Larissa, ex modella brasiliana che Goffredo aveva sposato otto anni prima riconoscendone anche i due figli dagli occhi a mandorla, e che viveva nell’appartamento che le aveva lasciato nel cuore del quartiere Coppedè, a Roma, in zona Trieste.
Riconobbe subito la mia voce, e nonostante fossi stato uno di quelli che aveva osteggiato quasi con livore la sua scalata al matrimonio, mi salutò con affetto.
Le tracce dell’attore regista mi condussero dunque a Nepi, in un’elegante casa di cura.
Lo riconobbi da lontano mentre sotto un salice, in posizione del loto, faceva la sua ora di meditazione quotidiana, come mi riferì la giovane infermiera che mi aveva accompagnato da lui.
Vedendomi arrivare, Goffredo rimase con le lunghe gambe incrociate, soltanto alzò il braccio e lo mosse verso di me con calma plateale.
Il naso aquilino mi parve ancora più invadente nella magrezza spaventosa della malattia, gli occhi colore del cielo della tundra, come li definiva sua madre, mi guardarono con una specie di gratitudine.
Senza neppure farmi parlare, definì i pochi colleghi che di tanto in tanto lo chiamavano o si spingevano fino al paesino del viterbese, parassiti, zecche di cani rabbiosi, afidi insidiosi. Aggiunse che se lo cercavano era soltanto per impossessarsi della sua agenda, eredità preziosissima per qualunque arrampicatore di cantinelle, come chiamava i neo registi appena usciti dall’Accademia.
Non misi in dubbio le sue ragioni, anzi mi pavoneggiai con me stesso per essere stato infilato da Raineri nella categoria dei propri pari e, sebbene a quarant’anni andassi ancora elemosinando un posto da redattore, la mia autostima avrebbe avuto di che nutrirsi per parecchie settimane.
Concluso il divertente racconto su come un paio di mesi prima avesse scacciato da lì il povero Venturi, suo ex assistente alla regia, Goffredo cambiò espressione.
«Dunque a cosa devo la tua visita?», domandò con malcelata ansia, come per paura che gli portassi notizie freschissime dall’aldilà, da quel mondo che da anni si rifiutava di guardare.
«Mi hanno chiesto un pezzo su di te per «Dietro le quinte», il mensile…»
M’interruppe dicendomi che aveva contribuito lui stesso alla fondazione del giornale, da signore qual era sorvolò sulla cifra del contributo offerto ma lodò l’iniziativa di quell’idiota di Palazzi, invitandomi però a non fidarmi mai di lui.
Infine guardò con sospetto la grossa borsa di cuoio che conteneva il registratore a bobine.
«Eri sicuro che ti avrei concesso l’intervista, eh?».
Esitai a rispondere, mentre lui penetrava la mia fronte con sguardo incuriosito.
Conoscevo fin troppo bene il suo carattere, il piacere sadico che lo spingeva a negare favori dopo averli concessi, a cambiare piani e interpreti dei suoi spettacoli all’ultimo minuto, rescindendo contratti e mandando sul lastrico i produttori. La sua crudeltà era più celebre della sua genialità.
Infine sorrise e m’invitò a “tirar fuori l’arnese”. Ridemmo per il facile doppio senso e andammo a sistemarci su una panchina sotto un castagno, distanti dai viottoli bianchi e curati che conducevano gli ospiti alle piscine riscaldate e ai roseti.
Non mi sorpresi non mi avesse domandato nulla di me.
L’ultima volta che lo vidi, uscivo, pieno di vigore mozartiano, da una prima alla Scala. A guardarlo, dubitai fortemente avesse visto l’Idomeneo, opera a lieto fine ma inadatta all’aura rosso fuoco che lo circondava. Mi salutò tirando la sua testa canuta fuori dal finestrino di una Ferrari. Io mi avvicinai per dargli la mano, alla guida, in minigonna, una giapponese bionda. Che fosse appena maggiorenne l’avevo saputo da Larissa, che, felice di imputare a un’altra l’improvviso aggravarsi dello stato di salute del consorte, al telefono, e senza che potessi oppormi, mi aveva fatto l’elenco delle altre possibili corresponsabili.
Raineri era di un egoismo irresistibile. Anche questo mi aveva confermato la moglie, lanciandomi a più riprese segnali inequivocabili: che io non lo conoscevo, e che la sua crudeltà manifesta era soltanto la punta di un iceberg di perversione.
A vederlo quel giorno, come scavato dentro, mi sembrò impossibile. Ma quando poco dopo m’intimò di cominciare, perché tra meno di un’ora avrebbe avuto il suo massaggio e non poteva perdere tempo, mi fece la solita paura.
Così, tutti i piani che mi ero prefisso, le domande scritte e ben pensate, svanirono nel dolce chiarore del primo pomeriggio autunnale. Un vuoto zen si era impadronito della mia mente.
«Raccontami un segreto», domandai inaspettatamente, come se a dire quelle tre parole fosse stato un altro. Perché che cosa si può chiedere un uomo a un passo dalla morte, se non di confessarsi?
«Bravo», disse alzando gli occhi su di me. «Qualcosa allora te l’ho insegnata, caprone, tipo che quando non sai che cosa vuoi, devi domandare l’impossibile».
Ecco il suo segreto, pensai.
«Vivevo a Parigi in quegli anni. Ero un bel quarantenne, ricco, geniale, stando a pubblico e critica, ma terribilmente depresso, messo all’angolo da un sentimento che non riuscivo a decifrare».
Mi guardò con serietà ben calibrata: «Non era depressione, nemmeno ansia. Semplicemente non riuscivo a saziarmi di ciò che avevo».
Capì che doveva essere più chiaro, «Non riuscivo più a godere della bellezza, che fosse un panorama o una donna».
Abbassò lo sguardo stupito e si guardò le mani. Ed entrò così bene in parte, che per un attimo temetti stesse dando di matto, come sempre Larissa mi aveva riferito, e si stesse inabissando in una sorta di straniamento che non era demenza senile e nemmeno alzheimer, ma un paradosso di sé, durante il quale si metteva a fare programmi per le future regie, a sognare di ricominciare da zero, d’integrarsi di più, di mettere in scena anche qualche Molière.
Invece alzò le mani, le contrasse con rabbia mascolina e mi guardò allargando gli occhi.
«Era come se non bastasse più, non bastasse mai. Avevo dato fondo alle esasperazioni del sesso in ogni forma, mi ero lanciato in performance che non confesserei nemmeno fosse in gioco la mia vita, o di chi mi è caro, sebbene ancora non sappia chi sia».
Quella conclusione la tenne un po’ per sé, mettendosi di tre quarti. Restò ancora così, alla ricerca di un volto fraterno cui tenesse più che a se stesso.
«Ero rassegnato, e più andavo a fondo, più le donne mi cercavano, presentandosi alla mia porta già in divisa da crocerossine, sollecite, in gonnellina e scopettone. E non parlo di giovani in cerca di una comparsata, a quei tempi ero nel giro grosso, tu lo sai, conosci la mia storia».
Annuii, lui aprì il suo fedele zainetto di cuoio, che sicuramente conteneva anche la sua preziosa agenda, e tirò fuori un pacchetto di sigarette all’eucalipto, ultima spiaggia per tabagisti malati di cancro.
«Erano donne di classe, intellettuali, attrici da tappeto rosso, dive e divine anche nel privato, giovani o più mature ma tutte ben armate di arroganza, della presunzione tipica delle grandi fighe».
Sospirò brevemente, mi guardò.
«Tu capisci di che genere di donna parlo. Intendo quella capricciosa, volubile, cervellotica. Il tipo che passa, in meno di dieci minuti, dalla sfrenata allegria alla malinconia che non si può spiegare. Mi sembrava di essere in una pellicola di Godard circondato da decine di Bardot. Donne problematiche, inclini al masochismo, in cura perenne dallo psicanalista, eppure così prodighe nell’aiutare il prossimo. Me, in particolare, quasi che per Parigi si fosse sparsa la voce del relitto da salvare».
Rise e guardò davanti a sé, poi si portò quella specie di sigaretta alle labbra e aspirò con devozione.
«Mi mancava sempre qualcosa per essere felice, andavo sempre più in là ma mi trovavo ogni volta davanti a un nuovo abisso dentro cui gettarmi. Non riuscivo più nemmeno a lavorare. In ogni Ofelia o Giulietta mi si presentasse sul palco, misuravo peso e mortalità, non levità e talento. Nessun attore sembrava in grado di saziarmi. Così per gli adattamenti dei testi e le scenografie».
Sì, ricordavo di aver letto che avesse ritirato la firma da una regia a una settimana dal debutto. Quella volta pagò di persona una cifra considerevole per l’epoca. Dopo aver dato il benservito alla compagnia, affittò una barca e una casa a Salina. In realtà, più che di quella mattanza di talenti e vecchie glorie, e del risarcimento astronomico, si parlò proprio di quella crociera, e delle orge.
«La conosci, no, la storia di Salina».
Preso in castagna annuii, cercando però di apparirgli poco convinto, perché non partisse con il suo piglio da poliziotto cattivo, per indurmi a raccontargli io per primo che idea mi fossi fatto di lui, o chi mi avesse riferito cosa.
«Andava avanti così da anni», disse ancora debolmente.
Pensai a Larissa.
Il veggente rispose: «Tutto questo successe molto prima di Larissa, lei arrivò quando già ero guarito, quando avevo trovato la soluzione a quel buco nero che era la mancanza di appagamento. Un’asma dello spirito, come la definivo. Una malattia asintomatica che mi lasciava sempre in credito di qualcosa.
Guardavo una donna, la possedevo, ma non mi bastava. Me ne facevo venti ed era lo stesso. Le guardavo, in un caffè, per strada, tra le mie lenzuola, e quando distoglievo gli occhi, di loro in me non era rimasto niente. Perdevano consistenza. Provai a fotografarle, ma quelle immagini sembravano prendermi in giro per quanto poco vicine alla sostanza».
Goffredo teneva tra le dita ossute il mozzicone di eucalipto e finalmente sorrise.
«Era una giornata piovosa. In realtà credo piovesse da settimane. Era una primavera stranamente umida. Dal mio buco in rue Gabrielle vedevo le giornate alternarsi tra brevi scoppi di luce e lunghe pause di buio, i tetti grigi mi restituivano baluginii d’argento come in un sogno e per pochi istanti mi sentivo felice.
Quel pomeriggio lasciai Babette a letto. Una di quelle che pagavo per farle fare la lasciva, cui offrivo cinquanta franchi al giorno per cucinare e trastullarsi mezza nuda per casa, così da illudermi di essere in compagnia».
Raineri ebbe un lieve moto di stizza, si percosse leggermente il labbro con la nocca violacea e mise a fuoco: in realtà nessuna di loro si chiamava Babette, disse, ma quello era l’accordo, lui le chiamava Babette e loro eseguivano.
Raineri stirò un sorriso per nulla pentito.
«Comunque sia, era una giornata cui mancava pochissimo per essere perfetta. Uscii in strada con una strana acquolina in bocca, come per una bella amatriciana in un mezzogiorno romano a un passo da Fontana di Trevi. Insomma mancava poco al compiersi della mia felicità, lo sentivo, era vicinissima, e camminava proprio davanti a me, in un poncho messicano, il guinzaglio in una mano e il sigaro spento nell’altra».
Si prese una pausa lunghissima, durante la quale mi guardò, poi distolse lo sguardo per sorridere tra sé e mi guardò di nuovo.
«Era Romain Gary», concluse.
«Caspita», dissi senza essere stato interrogato, «certo, sì, lo scrittore gollista morto suicida qualche anno dopo la morte di sua moglie, quell’attrice… sì, suicida a propria volta».
«Ma non per causa sua!», asserì venendomi sopra con forza mascolina.
«Lo scrisse chiaro e ben leggibile che non si suicidava per lei», indignato che l’avessi pensato e detto.
Ripresi a guardarlo con interesse. Lui invece non parlava. Il fruscio delle bobine si confuse per un attimo con il mormorio del vento che spogliava gli alberi.
«Di lui avevo letto qualcosa», continuò gettando la testa magra all’indietro, «ma ciò che sapevo era niente in confronto alla vitalità che quell’uomo si portava addosso, all’energia che nei gesti calmi tagliava l’aria. Parlava, un po’ con me un po’ con il suo cane bianco, della vastità del cielo, dell’aria che invece a Parigi era grigio piombo, come a Los Angeles, dove aveva vissuto, e che era la terza città industriale al mondo; mi disse del cielo d’Africa e degli elefanti, di come tra un po’ saremmo stati tutti così soli da non trovare più conforto neppure negli animali, dell’Europa, disegnata troppo in fretta, delle nostre tradizioni vendute per un po’ di barili di petrolio a basso costo. Ebbi l’impressione di trovarmi davanti a un profeta.
Sembrava non avesse fretta, che anzi gli piacesse misurare il tempo con i nostri passi, il ticchettio delle fedeli quattro zampe del suo amico, i clacson e le lamiere delle automobili che, come un banco di pesci d’argento, muovevano ansiose verso l’arco di Trionfo laggiù.
Così mi confessai. Gli raccontai l’orrore di quegli ultimi anni e il senso di fame perenne. Mentre parlavo, i suoi splendidi occhi trasparenti come zaffiri si muovevano con allegria, annuiva vigorosamente, sorrideva di certi pro e si rattristava per gli inevitabili contro della mia situazione.
Quando finii lui non disse nulla. Timidamente provai a spiegarmi meglio ma lui sembrava distante. Pensai di averlo disgustato, che, in quel silenzio, dimorasse la scoperta di quanto la stima che comuni amici avevano di me fosse del tutto immotivata.
Inaspettatamente Gary scoppiò a ridere, poi si voltò, mi mise una mano sulla spalla, mi fissò e con voce franco-russa mi confermò che si poteva uscirne, che c’era un modo per portarci via il ricordo del sublime. Io lo guardai. Basta mangiarlo, mi disse».
Mi voltai verso Raineri con la stessa espressione stupita che doveva avere lui vent’anni prima davanti a Gary.
«Glielo aveva raccontato un conterraneo, in Perù, davanti alle vette degli Illimani. A lui bastava mettersi nei pressi di un panorama come quello e mangiare il suo piatto preferito finché non era sazio».
Io capivo perfettamente il senso di quell’esperienza, ma non credevo potesse funzionare. Goffredo, invece, era felice di avermi raccontato quel segreto.
«Gary andava davanti alla Gioconda, con discrezione tirava fuori dalla tasca, o da sotto il poncho, la preziosa scatoletta di croccanti cetrioli alla russa e mangiava. Gliene bastavano due a saziarlo, a far sì che la mano di Leonardo gli si posasse sul cuore. Così, io iniziai a mangiare donne».
Rise di gusto, poi tossì.
«Non consumai più, non le toccavo nemmeno le donne, le pagavo per spogliarsi e stare nude davanti a me mentre io le guardavo, mangiando fino a sazietà la mia amatriciana».
Restammo in silenzio per un po’.
Pensavo a Larissa, a tutte le donne che gli avevano attribuito figli e crudeltà. Poi mi dissi che forse faceva parte del gioco, che quelle voci di camerino, le storie incredibili che si raccontavano su di lui, fossero parte di un’incredibile regia.
Mi lasciò con un lungo abbraccio.
Non pubblicai l’articolo. Non mi feci più sentire da Palazzi. Due mesi dopo misi assieme un po’ di soldi e partii per il Perù, dove ancora oggi vivo.
Una volta l’anno, in onore di Gary e di Goffredo, vado a mangiare cetrioli alla russa davanti all’Illimani “la cui vetta ti sovrasta da ancora più in alto”.