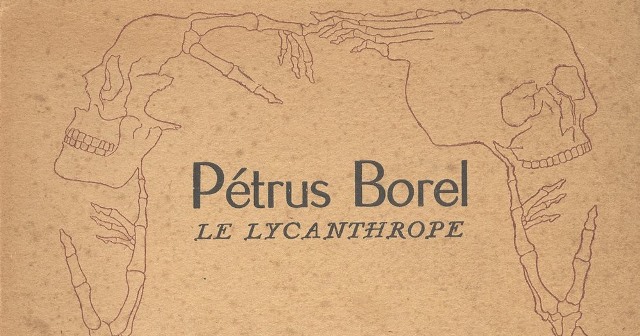
PARIGI
Perché la società non è che un brago fetente
Il cui fondo, certo, è uno e puro e lucente,
Ma ciò che si vede di più sporco, di più
Velenoso e pestifero, viene sempre da su!
Ed è una vergogna! È un guazzabuglio di erbe
Gialle, di aride canne sbocciate in gerbe,
Tronchi marci, funghi squarciati e inverditi,
Arbusti spinosi incrociati e impazziti,
Fango verde, schiumoso e brulicante di insetti,
Di rospi e di vermi, che in solchi infetti
Lo scavan, il tutto tempestato di animali
Annegati, e dei quali appaion neri e grossi ventrali
Gérard[1].
I
TESTAMENTO
Al lavoratore dei campi Jean-Louis
Morirò solo, mio caro Jean-Louis, morirò solo!… Nonostante avessi ricevuto e fatto una promessa; nonostante un uomo mi avesse confidato: «Sono stanco della vita, tu senz’altro la disprezzi, quando sarai pronto la fuggiremo insieme»; ormai ho deciso, Jean-Louis, sono pronto, ti dico, e tu lo sei altrettanto? Tu, pronto! Che ingenuità credere a un giuramento! Il pensiero dell’uomo è così incostante. D’altronde non puoi però averlo dimenticato così presto: più volte ti ho ricordato quella notte in cui, dopo aver vagolato a lungo nella foresta, ponderando il tutto, rimuginando, esaminando, analizzando la vita, le passioni, la società, le leggi, il passato e l’avvenire, infrangendo la lente ottica ingannatrice e la lampada artificiale che la rischiara, ci assalì un singulto di disgusto davanti a tante menzogne e miserie. Allora, se ben ricordi, noi piangemmo; sì! Tu piangesti!… La tua mano strinse la mia e facemmo un patto. Malgrado io ti rammenti tutto ciò non è mia intenzione indurti a fare il grande passo: ma è semplicemente per impedirti di biasimare una decisione che fu anche tua.
Ahimè, non ho dubbi che il tuo nuovo stato abbia mutato le tue idee; senz’altro per causa sua ti sei avvinghiato alla vita, come un’ostrica alla roccia. Hai abbandonato la stupida professione che ti aveva imposto tuo padre; impiegato, hai abbandonato il lavoro e rinunciato ai sorrisi e alle mance ministeriali; depravato di un bifolco! Tu hai avuto la rozzezza, come si vuol dire, spinto dall’istinto di un pregiato cane da caccia, hai avuto la volgarità di lasciare l’incantevole soggiorno cittadino ‒ come dicono gli impudenti adulatori, le volpi che assaporano il formaggio di una borghesia ignorante, orgogliosa, che si pavoneggia nel suo sterco come un tacchino ‒ per tornartene in campagna da dove il tuo avo era partito per impiegarsi in città come servitore. Tu hai avuto la volgarità e la follia di preferire la camicia di tela e la blusa ai pantaloni coi lacci e lo straccale, al panciotto coi morsi, alla soffocante redingote che ti strangola come se si fosse incappati in un argano, alla cravatta che ti mette alla gogna, agli stivaletti insaponati di talco, ai lucidi quanto effimeri guanti; un confortevole abito, dentro il quale si è comodamente imballati, purché non si utilizzino né le mani né i piedi, non si volti la testa, non ci si fletta in avanti o indietro, non ci si inginocchi né sieda. Tu hai abbandonato il “grande villaggio” per il villaggio, lo spettacolo della vaudeville per quello della natura, le vie affollate contorniate da negozi, brulicanti di carrozze e carri, per sentieri deserti, fiancheggiati da siepi vive e da alberi agresti; là, niente per sollazzarsi, né vetri stampati, né giocolieri ai lati della strada, né sirene esalanti acquavite, niente che ricordi la città! L’uomo, abbandonato a se stesso, solitario e silenzioso, è costretto a pensare.
Sei felice ora, felice, uno zappatore felice, che scandalo! La felicità può così prostituirsi! Un ragazzo di campagna felice!… Andate dunque a dirlo alla moglie del banchiere *** che cerca refrigerio là al suo balcone. «Vergogna!» dirà, disgustata e sprezzante; «Vergogna, un ragazzo di campagna felice! Un balordo!».
Un tempo ho forse sognato anch’io la vita che hai realizzato: allora credevo alla campagna delle Bucoliche, ai contadini degli Idilli, ai paesani di Favart[2], alle pastorelle delle imposte di Boucher[3]: mi dicevo che se la felicità non abita in città, sicuramente alberga in campagna. Credevo che quando si indossano zoccoli ai piedi, una lunga blusa, un cappello di paglia, quando ci si alza col giorno, quando si guida un aratro, si sarchia o si innaffia la terra, si segue un asino carico, si mangiano cavoli, fagioli e maiale, ci si appollaia come una gallina al calare del sole, credevo che si potesse essere felici, assai leggiadramente felici! Credevo… ma ora non lo credo più…
Tuttavia, se dovessi indugiare ancora a lungo fra gli uomini, quello che scegliesti, lo sceglierei; mi ridurrei rozzo come te, ma più selvatico ancora, più animalesco; mi inoltrerei sui monti del Vivarais a mangiare del pane di farina di castagne; caccerei orsi sui Pirenei, mi impiegherei come minatore sulle Ardenne o come taglialegna sulle Alpi. Ma oggi non è più sufficiente; perché sprecare il mio vigore in lavori stupidi, nel maneggiare l’ascia, la zappa o la mazza? A quale scopo incallire il cuore come le mani? Non è più l’abbrutimento che mi occorre, è il nulla! Ma tu non desideri più il nulla, tu vuoi vivere; allora vivi, io morrò solo!
Ebbene, questo per il giuramento proferito e da te tradito.
Ed ecco ora il mio, che come te violo.
La mia promessa è a una donna, a una donna forte, pronunciata un giorno mentre eravamo entrambi stretti uno all’altra sfiniti e turbati, con il mio viso nascosto sotto i suoi capelli biondi di cui amavo ricoprirmi e che la mia bocca mordicchiava; rivangando profondamente il passato, parlavamo della nostra infelicità e del nostro amore, chiedendoci perché è stato orribile, perché il mio amore è fatale, perché sono funesto come una forca! Povera ragazza, a chi ti sei data… Oh, quanto hai sofferto a causa mia!… Sono stato assai crudele!…
Vengano dunque gli impostori, che io possa strangolarli! I farabutti che cantano l’amore, lo inghirlandano e zufolano, lo pennellano come un paffuto fanciullo ricolmo di piacere, che vengano dunque queste canaglie affinché io possa strangolarle! Cantare l’amore!… Per me l’amore è odio, gemiti, grida, vergogna, lutto, arma, lacrime, sangue, cadaveri, ossa, rimorsi, non ho mai conosciuto altro!… Avanti rosei pastorelli, cantate dunque l’amore! Che ridicolaggine! Che amara pagliacciata!
La povera donna allora, punteggiando le sue frasi con baci strazianti, mi disse seria e pensosa, poiché Flava è una donna forte, lo ripeto, una donna che ci è superiore in tutto: «Champavert, giurami che mi concederai quello che sto per chiederti».
«Mia cara, non posso farti una tale promessa».
«Te ne prego, promettimelo».
«No, non posso».
«Hai paura, temi che ti sorprenda una volontà che potrebbe esserti fatale? Non sei generoso; vedi, io ti prometterei tutto ciecamente, io ti amo! Non c’è nulla al mondo che non farei per te se tu dicessi “lo voglio!”. Oh! Sei proprio un uomo…».
«Mia buona amica, non c’è alcuna cosa al mondo che anch’io non farei per te, lo sai bene; dimmi, cosa ti ho mai rifiutato?».
«Voglio che mi giuri, Champavert, che non ti ucciderai mai da solo, mai! Il giorno in cui sarai stanco della vita, corri da me e dimmi solamente: “Voglio finirla!” Mi alzerò subito, usciremo, e ci uccideremo abbracciati».
Lo giurai… Lei mi baciò mille volte sul cuore. Non le chiesi lo stesso voto, mi avrebbe risposto: «Al momento la misura del mio disgusto non è colma, uno spillo mi tiene ancora legato alla vita». Ma la sapevo comunque risoluta, accarezzava lo stesso mio progetto da molto tempo; immaginando di attuarlo da un momento all’altro, recava sempre con sé un testamento con le sue ultime volontà, affinché non si accusasse alcuno del suo assassinio. Indugiai a lungo, incerto se rivelarle la mia ultima volontà dichiarandole: «Flava, finalmente sono pronto, alzati, vieni e uccidiamoci».
Sarei felicissimo di morire con lei, ne è ben degna!… Ma, nonostante ciò, non lo voglio, non lo farò; le persone sono così stupide, direbbero che ci siamo… che mi sono ucciso per amore. No, no, non voglio; la gente è così imbecille, non può credere che la vita sia un fardello di cui il forte si libera; la folla non può credere alla sete di annientamento, né che ripugni esistere; essa deve materializzare tutto, causa ed effetto; per essa un’idea non ha niente di palpabile, deve valutare e misurare tutto, perfino il suo Dio! Alla notizia di una morte per suicidio, immediatamente o al più presto possibile, vuole trovarne delle cause rozze e ben evidenti: una donna, una passione, una perdita al gioco, un disonore domestico, un’alienazione mentale; no, no, non l’avvertirò, morrò solo, non voglio che si dica: “Flava e Champavert si sono uccisi, spinti dalla disperazione, per amore, per un infelice quanto contrastato intrigo”. Non è per disperazione, io non ho mai sperato. No, non lo voglio.
Ma sono folle a non volere che questo mondo sul quale sputo, che disprezzo, che allontano a calci, mi accusi di morire per amore; che fragilità! Potranno importarmi le volgari congetture degli uomini quando non sarò che nulla? Potranno forse turbarmi le loro chiacchiere quando sarò ormai concime? E nondimeno è più forte di me, non riesco a liberarmi da questa assurdità; sono un debole, ne soffrirò fino alla fine dei miei giorni… No, non l’avvertirò; no, mi ucciderò solo.
Jean-Louis, Jean-Louis, tu puoi vivere, tu riesci a vivere perché hai trovato la felicità!… Che il destino mi guardi dall’indurti a discendere con me le scale dell’abisso mortale. Le tue piume sono ancora invischiate in moribonde illusioni che insieme, una a una, avevamo pugnalato. Ti credevo un falco disingannato e pronto a prendere il volo verso il nulla, ma il mondo ti avvolge ancora. Aspetti forse una pace e un riposo dopo il lavoro? Quello che non hai in giovinezza, speri di ottenerlo nella vecchiaia? Non accetti che l’esistenza sia interamente così, sia solo quello che sinora hai conosciuto: se si riduce a questo, ti dici, se non ci saranno periodi di beatitudine e stagioni di pura gioia che vendichino tanta infamia, perché tanti uomini avrebbero trascinato la loro carcassa fino alla fine? Perché avrebbero consentito a vegetare perpetuamente e miseramente, a sguazzare fino all’estinzione nello stagno putrido della società? Perché?… Perché, come te, il volgo spera; come te, crede continuamente di essere sul punto di agguantare il suo sogno svanito, il suo folle desiderio; è come il gatto quando, tentando di afferrare ciò che riflette lo specchio, nell’istante in cui raggiante si getta sulla sua preda, sulla sua ombra, i suoi artigli non fanno che urtare e stridere sul vetro; sorpreso, ma non convinto, scruta, e vi si accanisce sedotto come prima. Ma tu che hai visto il retro dello specchio, che hai grattato via la stagnatura con le unghie scoprendo del semplice vetro con metallo a riflettere, cercherai ancora affascinato?
Il mondo è un teatro: manifesti dai titoli enfatici a grandi lettere prendono all’amo la folla che subito si alza, si lava, pettina i favoriti, indossa la camicia da festa e il vestito domenicale, si arriccia i capelli, indossa il suo costoso abito e, ombrello alla mano, parte: lesta, gioiosa, desiderosa; arriva e paga, perché la folla paga sempre; poi ciascuno si sistema nel vasto anfiteatro come più gli piace, o meglio, a seconda di quanto ha dato: l’aristocrazia si rinchiude in protetti padiglioni graticolati mentre la canaglia resta in balia di se stessa. Il sipario si alza e, con colli tesi e orecchie aperte, subito la folla ascolta, perché la folla ascolta sempre: l’illusione per lei è totale, è la stessa realtà; s’immedesima, ride, piange, odia, ama, urla, fischia, applaude; di quando in quando, ma invano, avvertendo quell’atmosfera di esasperata derisione si arma di binocolo; ma è miope: niente può annientare la sua speranza e la sua fede su cui così gentilmente speculano i commedianti.
Ma tu, Jean-Louis, tu che sei penetrato dietro le quinte, che hai scorto il retro del palazzo, il cielo piatto e toccato il fondo; tu che hai conosciuto da vicino e a nudo i re: ciarlatani ridicolmente rivestiti di lustrini; tu che hai intravisto la vecchia carcassa delle vecchie attraverso la cipria ocra e il colloso cosmetico di cui sono tinte; tu che hai aperto la strada alla giovane primadonna, così inesperta, così vergine alla scena, ma la cui bocca esala farmacia; tu che sai quanto le monete non siano che gettoni; tu per cui i re, gli sgherri, i nobili, le belle e i cicisbei non sono altro che pagliacci crapulosi, che soppesano l’onore, la gloria, la giustizia, secondo il ruolo a loro imposto; farisei che, lontano dagli occhi dell’anfiteatro, si trascinano nella dissolutezza e sguazzano nella turpitudine; Jean-Louis, ora che non sei più affascinato, ma affrancato dall’errore, ascolterai questa farsa fino alla fine?… Come un benevolo spettatore ammaliato da questa ignobile buffonata, resterai fino all’epilogo nella turba del teatro?… Oh, Jean-Louis, cadrai così in basso!
Non ti serbo rancore perché tieni veramente alla vita, e d’altronde il patibolo non ti reclama più, hai tutto il diritto di vivere; puoi portare con fierezza la testa sulle spalle, non è più ormai una testa sediziosa, la fornace non contiene più che scorie… ; la puoi portare spavaldamente, questa testa pacifica, col permesso del re e l’autorizzazione del signor sindaco. Inoltre, non abiti forse in campagna? E la campagna non stringe alla vita? In verità, cosa c’è di più attraente! Là, le mucche; là, un mucchio di fieno; là, uno stagno gracidante; là, dei battitori nel fienile; là, un’asina che raglia; là, una pozzanghera che sciaborda; là, un campo di barbabietole. Cosa c’è di più allettante? Un fascino irresistibile, lo sento!… Una sola cosa forse mi piacerebbe meno, la monotonia, la sempiterna fisionomia della natura: sempre la pioggia o il sole, il sole o la pioggia; sempre la primavera e l’autunno, il caldo e il freddo; sempre e eternamente. Niente è più noioso di una fissità, di un modo costante, di un perpetuo almanacco. Tutti gli anni gli alberi inverdiscono e senza sosta gli alberi rinverdiscono; Fontainebleu! Chi ci libererà dagli alberi verdi? Tutto questo mi inebetisce!… Perché non un po’ più di varietà? Perché le foglie non prendono di volta in volta i colori dell’arcobaleno? Fontainebleu! Tutta questa vegetazione è stupida!
Non te ne voglio, Jean-Louis, perché tu tieni alla vita, ma perché tu pretendi di non concepire le ragioni che mi spingono così improvvisamente al suicidio; sei proprio tu, Jean-Louis, che mi chiedi questo; che destino! Chi ti ha cambiato in tal modo? Chi può dunque averti raffreddato così il cuore, mentre il mio cedeva all’amarezza? Improvvisamente, puoi davvero affermarlo? Eppure non ignori quanto il pensiero della morte sia il decano dei miei pensieri; tu sai che, su tre desideri, due sono sempre per il nulla; e non puoi ignorarlo, tu stesso approvavi tutto ciò. È troppo tardi ormai, ne sono arrabbiato… ; tutto quello che potrai dirmi sarà vano, io lo porterò a termine. Ma tengo troppo a te per non temere il tuo biasimo; spero che almeno un amico non mi insulti; spero che almeno tu dica: «ha fatto bene, è stato coraggioso, si è ucciso».
II
EDURA
Portata a termine la memoria, Champavert la imbustò, mise l’indirizzo: “A Jean-Louis, contadino, presso La Chapelle-en-Vaudragon” e la sigillò; si alzò poi calmo e, come sollevato, bevve una tazza di tè, accese una Maryland e si sedette alla finestra fumando e guardando vagamente nell’aria; spenta la sigaretta, rientrò in camera e, rasentando il perimetro dei muri, baciò di volta in volta i ritratti degli amici, per poi infrangerli uno alla volta sul pavimento: poi, con un riso beffardo e alzando le spalle con disprezzo, strappò e gettò nel fuoco tutti i suoi libri; armandosi di un’ascia appesa come trofeo, fece poi a pezzi uno dopo l’altro i mobili che arredavano la sua abitazione. Il pavimento era coperto di frantumi mentre il fuoco del camino imperversava nella camera. Il suo cuore incattivito palpitava di gioia: non voleva lasciare niente di sé dopo di lui, niente; non voleva che dopo la sua morte ci si spartisse, col sorriso sulle labbra, quello che aveva posseduto; che un altro dopo di lui potesse amare un oggetto che anche lui aveva amato; che qualcuno indossasse per strada i suoi vestiti al sole. Se avesse avuto dell’oro l’avrebbe gettato nell’acqua o l’avrebbe nascosto, tanto profonda era la sua avversione per gli uomini, tanto aborriva il concetto di eredità. Non sarebbe certo stato lui a far piantare degli alberi sulla sua tomba per dare riparo al viaggiatore affaticato a mezzogiorno; avrebbe piuttosto fatto scavare una trappola sulla sua fossa atta a inghiottire il vetturino smarrito o il passante perdutosi nell’erba alta.
Soddisfatto della sua devastazione, si sedette sulle sue rovine, come l’architetto Fontaine fece sulle macerie di Saint Germain-l’Auxerrois[4], e, aprendo un cofanetto mezzo bruciacchiato, ne tirò fuori una scatoletta di tartaruga che portò alle labbra con trasporto per coprirla di baci.
«Edura! Edura! Mio primo e più terribile amore, Edura! Mia Warens[5]!…». Ripeteva con la fronte arrossata e le mani contratte, frantumando e facendo scricchiolare la scatola fra le dita bagnate di pesanti lacrime che scendevano dai suoi occhi.
O Edura! Mia bella Edura!… Donna, donna a me fatale!… Avresti fatto di me qualcosa di grande se solo l’avessi voluto; sento intensamente che vi ero predestinato, si trattava soltanto di una parola, una sola parola! Ma non l’hai mai pronunciata, donna malvagia! Tu mi hai fatto del male! Tu mi hai rovinato: potevi fare di me un leone; la bontà del mio cuore poteva ingigantire sotto le tue carezze; la tua voce, le tue dolci parole, i tuoi baci potevano immunizzarmi dal veleno che, ora, trabocca; la sofferenza ha fatto di me un lupo feroce. Ecco, infrango questo gioiello da te donatomi!…
E gettato a terra la scatola di tartaruga, la colpì dall’alto col tallone, polverizzandola.
«Muori, muori, intero ricordo di lei!… Di lei che ha fatto entrare l’odio nel mio cuore! Di lei che ha bagnato la mia giovinezza di fiele quando poteva farsi così bella, così sublime! Sei tu, Edura, che mi hai inasprito, che hai scacciato la bontà dalla mia mente, la sensibilità dal mio petto, che mi hai consumato e logorato con la sevizia e il desiderio. Sei tu la causa del mio odio per tutto, corrompendomi quando la mia vita si apriva così ricca di avvenire; tu l’hai avvelenata; e, se mi uccido, è ancora per causa tua; sei tu che hai seminato nel mio cuore il germe della morte, la miseria lo ha fecondato.
O inconcepibile passione! Amore, amore, chi saprà spiegarti?… Edura! O mia Edura! Non credere tuttavia che io ti odi. Ti amo ancora così follemente; fremo ancora al tuo nome come una volta. Ti amo, e tu mi hai ucciso: sei tu che mi hai fatto volgere verso il niente. Tu mi hai fatto tanto male ma io ti amo tanto! Eppure non sei più per me che un ricordo confuso; gli anni sono passati lesti trasformandomi in un giovane uomo; ma gli stessi ti hanno invecchiata, offuscata, sfiorita; non sei più quel ranuncolo dal fiore giallo, ma un vuoto salice piangente. I cavalieri non ti degnano più di uno sguardo; non hai più la corte di cui essere la regina. Se, allora, tu avessi voluto raccogliere il mio amore, esso, come un amaranto immortale che non avvizzisce mai, ti ornerebbe ancora. Saresti madre di un bimbo che con appassionata premura stringeresti nelle braccia; il mio sangue e i miei calorosi baci avrebbero potuto riafferrare la tua sfuggente vita; avresti avuto fino alla fine un compassionevole appoggio; la mia giovinezza avrebbe adombrato la tua vecchiaia e il mio braccio punito il derisore che avesse alzato il tuo velo.
Che ne è stato di tutti i tuoi bellimbusti, semplici amanti carnali?… A malapena ricordano il tuo nome. Da veri cosacchi a cavallo, ai quali ti sei arresa, ti hanno fatto oggetto della loro nomade passione; sei stata il bottino sul loro cammino. Povera donna dissennata! Ecco dunque gli amici di cui ti circondavi per il ritorno. Ora soffri, soffri; è assai giusto che io sia vendicato dopo che ho tanto sofferto! Ora, forse, le guance che nessun bacio ormai ravviva sono bagnate di lacrime, tu langui sola consumata da questa ignota solitudine; forse ti sei ridotta, che umiliazione!, a fare smancerie a giovani uomini che ti respingono e ti voltano le spalle. Quando vuoi parlare d’amore, si sogghigna intorno a te. Soffri, soffri a lungo affinché io sia ben vendicato! Assurda passione, io ti amo ancora, lo sento, non posso nascondermelo; ti amo e ti odio profondamente; e nonostante ciò, se tu venissi a cercare la mia mano, se tu venissi a sussurrarmi quella parola che mi hai sempre taciuto, se tu venissi a dirmi: “ti amo”, come una volta… Perché tu mi hai amato, ne sono sicuro!… Sicuro del fatto che tu hai soffocato il tuo amore per me, che hai respinto il mio, perché amare, essere amata da un ragazzino oscuro non era quello che voleva il tuo spirito orgoglioso; ma io ti amo ancora prepotentemente; eppure se tu venissi da me, io ti respingerei; perché ti amo oggi per quello che sei stata e non per quello che sei ora. Se tu ti gettassi ai miei piedi sarei senza pietà, ti colpirei; se ti prostrassi aggrappandoti ai miei piedi, freddamente, ti trascinerei… sarei così vendicato!».
Poi, appoggiato sui gomiti, silenzioso, il povero Champavert pianse amaramente.
«Sono i primi passi nella vita che ne decidono la direzione; versate dell’aceto nel più dolce dei vini, diventerà aceto» mormorò mentre raccoglieva i frammenti della scatola di tartaruga che baciava mettendoli in borsa.
Improvvisamente si alza, si piazza il cappello in testa, esce e chiude la porta.
«Ecco la mia chiave» disse al portinaio scendendo; «parto per un lungo viaggio; se qualcuno venisse a cercarmi, sareste così gentile da dirgli che ho lasciato la città per alquanto tempo?».
«Andrete nella vostra tanto amata Spagna?».
«Più lontano».
«Ad Algeri?».
«Più lontano».
E uscì.
III
FLAVA
Verso sera, un amico lo incontrò in rue Jean-Jacques Rousseau, mentre usciva dall’ufficio postale.
Per le otto, sulla collina di Montmartre, in rue des Rosiers, suonò a una porticina rossa.
Una giovane ragazza venne ad aprire: i capelli biondi piovevano sul vestito bianco; il pallore e lo sguardo tormentato, l’aspetto languido, benché disinvolto, il petto incavato e la testa inclinata, indicavano tristemente che la sofferenza, come una folgore, aveva devastato e devastava ancora questa bella creatura, ricurva e sfiorita.
Scorgendo Champavert, lanciò un grido di sorpresa.
«Voi, mio selvaggio, a quest’ora, quale destino…».
«Amica, se sono venuto, non è per destino, ma per voi».
«Chamapavert, permettetemi almeno di dubitarne».
«Crudele, volete ferirmi!… Sei sola?».
«Sì!».
«Completamente sola?».
«Sì!».
«Tuo padre?».
«È sceso in città».
«Finalmente, che fortuna! Posso vederti e parlarti con calma, senza occhi spalancati che spiino e grandi orecchie che origlino».
«Chi vi ha così trasformato, mio Champavert? Quale sole ha dunque sciolto il ghiaccio nel vostro cuore? In realtà vi si addice molto venire a giocare all’amore, dopo due mesi di assenza».
«Flava, io non gioco a niente; sono per te quello che sono sempre stato. Accetto i tuoi rimproveri, so che apparentemente posso meritarli; sono poco costante, è vero, ma tu regni sempre sul mio cuore; regni come la patria nel cuore di un esule; regni come la vita nel cuore di un condannato a morte. L’assenza non distrugge l’amore, lo sai. Sono irregolare, è vero, ma a che scopo venire qui più spesso? Per soffrire!… Sempre guardato a vista, come un criminale di stato, non posso neanche stringere la tua mano, sussurrarti una parola all’orecchio; a malapena possono intendersi i nostri sguardi; tutto ciò mi fa troppo male, non posso sopportarlo! Quante volte sono stato tentato di colpire tuo padre, i tuoi carcerieri, di prenderti il braccio e dirti “fuggiamo!”. Se tu fossi libera, o se almeno potessimo abbandonarci a dolci conversazioni, non ti lamenteresti dell’infrequenza delle mie visite».
«Ma che importa!… Quando la tua sola vista mi instilla tanto coraggio nel cuore! Tutto ciò è comunque crudele Champavert! Odiare così una donna, e poi uscire dalla terra come un demone, due o tre volte all’anno, per venire a mentirle, a dirle di amarla. Tutto questo è atroce, Champavert!».
«Flava, mi giudichi troppo duramente, mi torturi a tuo piacere! Sarà sempre quindi necessario, come un novizio, ribadire le mie confessioni d’amore? Darti sempre nuove conferme? Dovresti almeno conoscermi dopo sei anni di tale legame. Se non sono costante, non sono forse un fedele amante? So che hai il diritto di dubitare di me; che un tempo, quando non ero che un ragazzo, sono stato malvagio, ma la mia costanza non ha riscattato tutto ciò…? Io ti amo, Flava, ti amo profondamente e ti amerò per sempre! Brami ancora un giuramento? Ti amo, Flava, e lo giuro sul corpo…».
«Silenzio! Champavert, silenzio! Non invocare la sua ombra!».
«Non piangere, Flava! Non piangere, buona madre, le tue lacrime hanno già abbastanza scavato le tue guance, e le tue lacrime sono amare alle mie labbra; non piangere, buona madre! È più felice di noi, egli non è più».
«Più felice di noi, non è più… Champavert, tu dici il vero: come amo questo pensiero!… Dimmi, saresti pronto ora?».
«No, mia bella, attendiamo ancora, forse giorni migliori stanno per sorgere; ancora così giovani abbiamo un lungo avvenire! Aspettiamo ancora, forse abbiamo bevuto il velenoso assenzio prima del festaiolo banchetto; attendiamo, dopo l’afflizione della notte, il giorno con la sua rugiada».
«Champavert, quando un albero è stato colpito dal fulmine, nessuna primavera sa ravvivarlo; inaridisce dalla radice, finché un boscaiolo non lo abbatte con l’ascia; Champavert, attenderemo il colpo d’ascia della morte, tardiva boscaiola? Sarebbe una vigliaccheria!».
«È temerario supporre l’avvenire: mia bella, spogliamoci di questa malinconia, tentiamo di essere meno elegiaci, te ne prego!».
«Provate piacere nel burlarvi di me! Voi fate smorfie, Champavert, il vostro ridere non è un riso che parte dal cuore, è il ghigno di un torturato. Vi siete subito tradito».
Durante queste conversazioni, all’ombra degli alberi la luna era salita all’orizzonte e i suoi raggi, penetrando attraverso il fogliame vacillante dei castagni, seminavano la terra di madreperla e l’oscurità di falene d’argento. L’usignolo non eseguiva ancora il suo notturno e nell’immensità nulla si avvertiva, se non il suono amorevole delle loro voci che si levava come il sospiro di una fata.
IV
DANNAZIONE
«La pianura è oscura e solitaria, alzati, mia grande amica, e usciamo in giardino; andiamo a vagolare là in fondo, presso la cisterna; è molto tempo ormai che non mi inginocchio su questa terra; l’agrifoglio che ombreggia la sua culla mortale è stato forse brucato? Andiamo a vedere».
«Oh! No, l’agrifoglio è verde e folto, e l’erba alta e rigogliosa; le mie lacrime sono una pioggia feconda, e io li innaffio ogni notte».
«Ogni notte scendi alla sorgente?».
«Sì, ogni notte: quando la casa è addormentata, mi alzo e scendo a pregare sulla tomba; dopo aver pregato e pianto a lungo sotto al firmamento, mi sento più tranquilla. La natura sembra perdonare il mio crimine; credo di avvertire nel silenzio universale una voce proveniente dalle stelle che mi urla: “Il tuo crimine non è il tuo, fragile creatura terrestre, è degli uomini! Della società! Che il suo sangue possa ricadere su di loro e su di lei!…” Rientro prima dell’aurora e solo allora assaporo un sonno più sereno privo di incubi orribili».
«Misteriosa! Perché non mi hai mai parlato delle tue visite notturne? Sarebbero state anche le mie e avremmo pregato e pianto insieme!».
«Guardatene, Champavert, guardatene bene, mi perderesti! Molte volte mio padre, sospettando qualcosa, mi ha seguito; ne sono sicura perché l’ho visto, là, nascosto dietro il muro della cisterna mentre mi ascoltava: ci saremmo traditi. Perciò ho ben cura di pregare a bassa voce, per paura che lui comprenda il motivo del mio implorare. Mi ha chiesto molte volte, con un sorriso di comprensione, se non fossi sonnambula; ho finto di non capire, e, senza turbarmi, ho risposto che era possibile».
Erano quasi in fondo al ripido sentiero che conduceva alla sorgente; la luna era scomparsa, il cielo era nero, lampi balenavano come scintille fluorescenti all’orizzonte, Flava si appoggiava al braccio di Champavert che ciancicava nella mano un ramo di verbena.
«Non esiste aroma più soave di questa verbena delle Indie! Ti piacciono i fiori, Flava?».
«Molto».
«Tu amare i fiori, Flava, che vanità! E ti piacciono i profumi?».
«Molto».
«Io li amo follemente! Dicono che ciò non si addica a un uomo, ma che importa! Non sono certo più effeminato per questo. Se mi lasciassi andare colmerei la mia dimora di piante balsamiche, mi infradicerei di profumi come una sgualdrina. Un ramo di caprifoglio odoroso è per me una totale consolazione nei momenti di afflizione.
Molti cavalieri montano la guardia al balcone di una bella; io la monterei al cospetto di un fiore; molti cavalieri percorrono un lungo cammino per parlare d’amore, io mi recherei in Spagna per un bergamotto, in oriente per del benzoino; molti cavalieri vendono il loro mantello per giocarne il valore, io baratterei il mio per una boccetta di essenza di rose.
Ma per me sopra ogni cosa ci sei tu, Flava, sei proprio tu l’ampolla più profumata, la reseda più soave, l’arabo balsamo più prezioso! Così per te farei ben più che aspettare con impazienza sotto un balcone, farei ben più che un pellegrinaggio, farei ben più che spogliarmi del mio mantello, io vivrei, se tu lo pretendessi!…».
«Ti sei nuovamente tradito, Champavert, saresti pronto? Dimmelo, te ne prego, ricorda la tua promessa!».
«Oh! Non quella, voglio dire che se decidessi di votarmi al niente, e se tu mi chiedessi di vivere, io vivrei».
«Champavert, tu bestemmi parlando così del niente, mi fai dannatamente male!… Guarda questo cielo striato, questa pianura, questi monti, questa maestosa natura! E ora guardami! E dopo questo, puoi credere al niente?».
«Flava, Un tempo amavo anch’io le poesie e le parole».
«Ahimè! Sarebbe assai atroce se non dovessimo rinascere felici nell’eternità!… Una vita di sofferenze e di miserie e poi… il nulla».
«Il nulla».
«Oh! Tu non lo credi!».
«Sì, lo credo! È per vigliaccheria che gli uomini indietreggiano davanti all’annientamento: si forgiano una futura vita a loro guisa, si cullano e si ubriacano di questa menzogna da loro stessi creata; e, tutti contenti di questa trovata, quando agonizzano, come dei folli sul letto di ferro, con un riso sciocco sulle labbra, vi dicono: “Addio! Arrivederci, parto per un mondo migliore, ci ritroveremo lassù!”. E poi, con un sorriso ancora più stupido, gli eredi, gioendo nel cuore, rispondono: “Addio! Buon viaggio! Ci rincontreremo tra poco, serbateci i posti nel lussuoso albergo del paradiso”.
Ebbene! No! Razza di idioti! Voi finite dove termina ogni cosa, nel nulla!… E ora che guardo in faccia la morte, con il piede nella fossa, vigliacchi, vi dico che non voglio un’altra vita; ne ho abbastanza di vivere, è il nulla che invoco!».
«Tacete, tacete, Champavert, non bestemmiate così; se voi sapeste, il vostro sguardo è orrendo! Ma quale sarebbe quindi, mio amico, la ricompensa ai disgraziati torturati quaggiù?».
«Chi ricompenserà il cavallo per i suoi sudori, la foresta per l’ascia, la sega e il fuoco?… Esiste senza dubbio un’ulteriore vita anche per i cavalli e le querce?… Un paradiso!…».
«Siete perduto, Champavert, tacete, Dio vi ascolta; non temete la sua collera?».
«Se esistesse un Dio pronto a scagliarmi il suo fulmine, lo sfiderei! Che vomiti tutto il suo livore, questo Dio possente che intende tutto, io lo sfido!… Ecco, io sputo contro il cielo! Guarda là in basso, vedi quel povero tuono che si perde all’orizzonte? Si direbbe che mi tema. Ah! Francamente il tuo Dio non è suscettibile in fatto di onore: se fossi Dio, se avessi delle saette per le mani, non mi lascerei insultare e sfidare da un insetto, da un lombrico. Del resto, voi altri cristiani avete impiccato il vostro Dio, e ben avete fatto, perché, se ci fosse un Dio, bisognerebbe impiccarlo».
«Oh! Lasciatemi fuggire, la terra si socchiude sotto i vostri piedi! Satana, tu mi fai orrore!… Lasciatemi, Champavert, io, io non ho stretto nessun patto; ve ne prego, tacete, morirò se bestemmierete ancora! Occorre dunque che mi prostri baciandovi i piedi?…».
«Fino a ora ho mantenuto il mio sangue freddo, ma cotanta miseria mi esaspera!… Se stringessi l’umanità come ora stringo te, la strangolerei! Se pulsasse intera di una sola vita, la pugnalerei con questo coltello, l’annienterei! Se avessi tra le mani il tuo Dio, lo colpirei come colpisco questo albero! Se avessi fra le mani mia madre, mia madre che mi ha donato la vita, la sventrerei! È una cosa infame una madre!… Ah! Se almeno ella m’avesse soffocato nelle sue viscere, come noi abbiamo fatto con nostro figlio… Che orrore!… Sto divagando…
Mondo atroce! Occorre quindi che una ragazza uccida suo figlio per non perdere il suo onore!… Flava! Tu sei una ragazza d’onore allora, tu hai massacrato il tuo!… Sei una vergine, Flava! Orrore!… Allontanati da questa fossa in modo che possa scavare la terra con le unghie; voglio rivedere mio figlio, voglio vederlo nella mia ultima ora!».
«Non disturbate la sua sacra tomba…».
«Sacra!… Ti dico che voglio rivedere mio figlio prima di finirla! Lasciami rovistare questa fossa!».
La pioggia cadeva a fiumi, il tuono mugghiava, e quando i lampi gettavano le loro distese di fiamme sulla pianura, si distingueva Flava, stravolta: distesa sotto i ciuffi di agrifoglio, il suo vestito bianco pareva un sudario. Champavert, inginocchiato a terra, frugava la sabbia con le unghie e il pugnale. Tutto a un tratto si raddrizzò tenendo in pugno uno scheletro da cui pendevano ancora brandelli di carne.
«Flava! Flava!» gridava «Ecco, guarda dunque tuo figlio; ti presento l’eternità!… Guarda!».
«Voi mi tormentate, Champavert, uccidetemi!… Tutto questo per un crimine, uno solo! È troppo…»
«Legge! Virtù! Onore! Siete soddisfatti; tenete, riprendete la vostra preda!… Mondo barbaro, tu l’hai voluto, è solo opera tua, guarda! Sei soddisfatto della tua vittima? Sei appagato delle tue vittime?… Bastardo! Che sfrontatezza essere voluto nascere senza autorizzazione reale, senza proclamazioni pubbliche! E la legge? E l’onore?.
Non piangere, Flava, che cos’è stato in fondo? Nulla: un infanticidio. Molte timide vergini sono al loro terzo, molte ragazze virtuose contano le loro primavere con il numero dei loro omicidi… Legge barbara! Pregiudizio feroce! Uomini! Società! Prendete! Prendete la vostra preda… Ve la rendo!».
E urlando queste ultime parole, Champavert lanciò lontano il cadavere che, rotolando per il pendio scosceso, cadde per infrangersi sulle pietre del sentiero.
«Champavert! Champavert! Finiscimi!» Rantolava Flava, fredda e moribonda; «sei pronto, ora?…».
«Sì!…».
«Colpiscimi, che io muoia per prima!… Ecco, colpisci qui, questo è il mio cuore!… Addio!».
«Al nulla!».
A questa ultima parola, Champavert si inginocchiò, mise la punta del pugnale sul seno di Flava, e, appoggiando l’elsa sul petto, si lasciò cadere pesantemente su di lei, stringendola fra le braccia: il ferro entrò freddamente, e Flava gettò un grido di morte che riecheggiò per le cave.
Champavert ritirò il ferro dalla ferita, si alzò, e, a testa bassa, discese la collina per poi scomparire nella bruma e nella pioggia.
V
DE PROFUNDIS
L’indomani, all’alba, un carrettiere avvertì uno scricchiolio sotto la ruota del suo carro: era lo scheletro, mezzo scarnificato, di un bambino.
Una contadina trovò presso la sorgente il cadavere di una donna con una ferita al cuore.
E, sulle colline di Montfaucon, un macellatore, mentre si rimboccava le maniche fischiettando una canzonetta, scorse, fra una mandria di cavalli, un uomo coperto di sangue; la sua testa, riversa e immersa nella fanghiglia, lasciava intravedere solo una lunga barba nera, e dentro il suo petto un grosso coltello era infisso come un piolo.
***
[1] Car la société n’est qu’un marais fétide
Dont le fond, sans nul doute, est seul pur et limpide,
Mais où ce qui se voit de plus sale, de plus
Vénéneux et puant, vient toujours par-dessus!
Et c’est une pitié ! C’est un vrai fouillis d’herbes
Jaunes, de roseaux secs épanouis en gerbes,
Troncs pourris, champignons fendus et verdissants,
Arbustes épineux croisés dans tous les sens,
Fange verte, écumeuse et grouillante d’insectes
De crapauds et de vers, qui de rides infectes
Le sillonnent, le tout parsemé d’animaux
Noyés, et dont le ventre apparaît noir et gros.
Gérard de Nerval scrisse e donò nel 1832 tale poesia a Borel per essere collocata a esergo del racconto. Nerval, ovvero Gérard Labrunie (1808-1855), con la sue opere oniriche e allegoriche, sconfinanti volentieri nella cupa allucinazione psicotica, fece parte dei cosiddetti “frénétiques” o “petits romantiques”.
[2] Charles Simon Favart, compositore e poeta comico.
[3] Il pittore François Boucher.
[4] Victor Hugo nel suo Notre-Dame de Paris, in una nota introduttiva aggiunta solo nel 1832, inveisce contro l’architettura moderna impersonata da stupidi architetti, definiti spregiativamente «muratori», capaci più a distruggere e danneggiare che a creare e restaurare. Uno degli imputati fu proprio Pierre-François-Léonard Fontaine (1762-1853) citato come colui che «…nel momento in cui scriviamo… ha in mano le Tuileries» ma domani forse si occuperà, per abbatterla, dell’Église Saint-Germain-l’Auxerrois.
[5] Françoise-Louise de Warens (1699-1762) fu un personaggio enigmatico del settecento francese. “Frenetica” come il nostro autore, condusse, per taluni, una vita disordinata e immorale, dedita al raggiro e all’inganno, per altri invece, una coraggiosa esistenza all’insegna della più fervente filantropia. Deve la sua fama alla sua lunga relazione con Rousseau iniziata con l’opera di conversione del sedicenne filosofo al cristianesimo. Fu per lui una premurosa madre, una dolce amante, una ambiziosa “maîtresse” e forse una crudele “mistress”.

