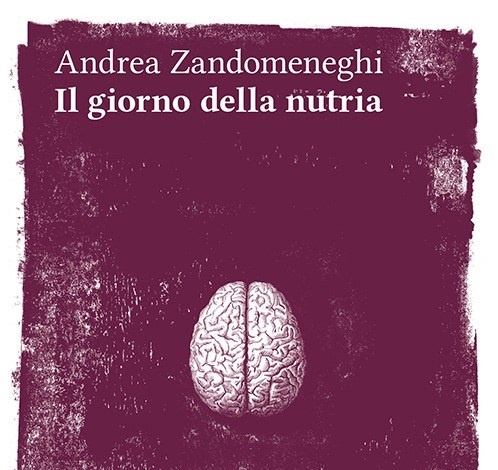Se per Voltaire lo stato di salute di un Paese si misura osservando la condizione delle sue carceri, per Meyer Levin lo stato di salute di un popolo si misura dall’efferatezza dei suoi crimini.
Levin in Compulsion racconta il caso di Nathan Leopold e Richard Loeb (che nel romanzo si chiamano Judd Steiner e Artie Strauss), due giovani ricchi e promettenti esponenti della comunità ebraica che negli anni Venti uccisero un ragazzino appartenente alla loro stessa comunità. Convinti di aver progettato (e compiuto) il delitto perfetto, in realtà commisero una serie di errori banali che hanno portato al loro arresto e alla creazione di un caso che fece scalpore.
Nella rovente aula di Chicago l’inadeguatezza della definizione giuridica emerse appieno; in quei giorni di dibattimento fu messa alla prova la legge stessa.
Compulsion è un romanzo sul concetto di limite e sul suo superamento, sull’impossibilità di ridurre a sistema (qualsiasi sistema) la complessità della vita e sulla meraviglia umana (benevola e malevola) davanti a tale complessità; allora un omicidio non è semplicemente un omicidio, ma diventa simbolo e manifestazione di un orrore ben più profondo e forse endemico, il male personale non può non riverberarsi nel sociale (e viceversa), e l’unico modo di sopravvivere al caos è l’onesta, sincera e appassionata volontà di conoscere questo male, capirlo, compenetrarlo.
Non è un caso che Levin dia particolare spazio a nuovi professionisti il cui lavoro si sarebbe poi rivelato cruciale nel corso degli anni: gli alienisti, per i quali il delitto in questione è molto di più di quello che sembra, non risolvibile semplicemente con la soppressione dei due assassini.
La compulsione che dà il titolo all’opera non è solo quella che muove i due assassini verso l’atto criminoso (compulsione, oltretutto, mascherata da dimostrazione di un teorema, e vissuta dai due assassini come manifestazione di potenza superomistica), ma anche quella che vorrebbe la risoluzione del problema nella cancellazione concreta del male, la stessa compulsione di chi non comprende ciò che è successo, di chi lo vuole comprendere, di chi racconta una storia che segnerà la sua vita da quel momento in poi, con lo sguardo sempre rivolto verso un abisso cercando di evitare lo sguardo dell’abisso verso di sé[i].
La verità che Levin indaga assume un carattere proteiforme, liquido, profondamente connesso con il male che le fa da specchio, che non ci si può esimere dall’affrontare, che non può essere eluso, e dal quale nessuno è estraneo.
L’esperienza umana dopo la morte si svolge in una qualche forma di consapevolezza?
Esiste l’onniscienza assoluta?
Le esperienze culturali terrene sono necessarie? Quale valore attribuire alla mente dei selvaggi?
La mancanza di un involucro fisico è un vantaggio?
Si conserva nella mente il ricordo delle esperienze fatte prima della morte?
È corretto il giudizio degli umani in terra o esiste un giudizio superiore?
Che cos’è la felicità?
La tentazione più facile, che Compulsion ci invita a evitare, è vedere il mostruoso come qualcosa di estraneo, un qualcosa che non ci riguarda e che mai potrà riguardarci, quando esempi tanto mostruosi ci ricordano che non è così. Levin si rivela un cronista compassionevole, preciso e puntuale, curioso delle domande non meno che delle risposte, capace di scrivere un libro di un’intimità sconvolgente.
Meyer Levin
Compulsion
Trad. it. Gianni Pannofino
Milano, Adelphi, 2017
pp. 580
[i] Cosa che non sarebbe riuscita a Truman Capote che, dopo A sangue freddo, avrebbe visto sconvolta la sua vita e la sua percezione di sé, tanto da giungere all’autodistruzione. Probabilmente questo è accaduto perché Capote, a differenza di Levin, accumula la sue verità per cercare una verità assoluta e incontrovertibile, un qualcosa che lo distanzi dall’assassino Perry Smith, con il quale lo scrittore trova affinità biografiche destabilizzanti e inquiete; Levin, al contrario, rinuncia fin da subito a ogni pretesa di assolutezza, e riconosce, seppur con turbamento, la possibilità del male all’interno del suo ambiente di riferimento, addirittura dentro se stesso.