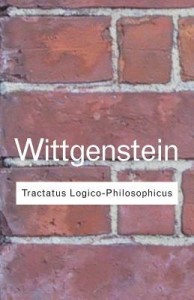Andrea Cafarella: Agnese Grieco è una pensatrice e un’artista poliedrica, un’intellettuale dalle spalle larghe, in grado di costruire la forza del proprio sapere attingendo dalle fonti più diverse e, legando tra loro i singoli anelli, formare una catena d’oro, brillante: un pensiero, un messaggio, che prima non era visibile e che riesce a portare a galla conducendoci attraverso indizi quasi invisibili. Senza regalarci una verità, ma la scintillante Verità, fatta di contraddizioni e misteri inesplicabili e perturbanti, a volte stravolgenti, tanto da poter cambiare il modo stesso che abbiamo di percepirci. Tra le sue esperienze – pubbliche – con quello che chiamo «mondo immateriale», vi è un lungo lavoro sull’Alcesti, dove gli inferi e, in generale, il sovrannaturale – è risaputo – hanno un ruolo cardine. Si è poi occupata della curatela di Sogni (il Saggiatore) il diario notturno di Arthur Schnitzler, il cui legame con l’intangibile mondo onirico si distende coprendo di ombre la sua intera opera, a partire dal celeberrimo «Doppio sogno». E infine, nel 2017, ha dato alle stampe Atlante delle sirene (il Saggiatore) un «viaggio sentimentale tra le creature che ci incantano da millenni» (come indicato in copertina). Che, a mio parere, oltre a essere lo studio di una figura simbolica, un essere proveniente da questo mondo altro, è anche la ricerca di una «chiave», a caccia di una creatura in grado di condurre l’uomo, attraverso l’ossessione (che si pone forse, simbolicamente, come l’ossessione artistica, intellettuale, estetica), fino al mondo sotterraneo e intangibile di cui sopra.
Ti chiedo quindi, per iniziare, qual è la tua idea del mondo immateriale e come si configura nel tuo percorso di studio e di vita. Se, oltre alle esperienze già menzionate, ci sono stati altri momenti di contatto, più o meno profondi. E se riesci a darmene una definizione, seppur contraddittoria o parziale, senza preoccuparti della correttezza accademica ma soltanto della tua intima percezione.
Agnese Grieco: L’unico mio testo filosofico, scritto e pubblicato solo in tedesco, è dedicato a Wittgenstein e Socrate. Si intitola Die ethische Übung – L’esercizio etico – Wittgenstein und Sokrates (Lukas Verlag, Berlin, 1996). L’uscita del libro, che è l’elaborazione della mia tesi di dottorato alla Freie Universität di Berlino, se ci ripenso, ha coinciso di fatto con l’abbandono della carriera accademica. Per alcuni anni ho condotto attività di ricerca e insegnato presso la Cattedra di Filosofia della Scienza presso l’Università Statale di Milano.
La decisione di vivere in un altro paese – quindi anche in un’altra lingua, non mia, non materna –, e quella di mettermi alla prova in altre forme di scrittura e nella regia teatrale sono maturate proprio in quegli anni di apprendistato berlinese. Che è poi diventato la mia quotidianità. Mi sembra che sia, questo, un segnale. O un segno, anche un caso. Il frammento di una storia. A volte le storie, se ben raccontate, sono migliori di un saggio.
Allieva ideale di Ludwig Wittgenstein, cosa che spero di essere comunque al fondo rimasta, leggendo quello che mi domandi, inevitabilmente sono riportata alla dimensione del silenzio «riguardo ad alcune cose», posizione intellettuale perlomeno decente. Ossia la domanda mi riporta al Tractatus wittgensteiniano e alla frase, ormai ampiamente abusata, ma non per questo meno fondamentale: «su ciò di cui non si può parlare si deve tacere». Una frase che credo ci debba sempre accompagnare e che apre orizzonti, non solo li chiude.
Il divieto di parlare. Lo sbarramento. L’ostacolo, è quello di cui abbiamo bisogno e che ci forma. Singolarmente. Ostacolo che contiene comunque, a mio sentire, già la figura dell’ esercizio da compiere per superarlo. Ostacolo etico ed estetico. O forse, meglio, ostacolo etico che porta ad un’autentica dimensione estetica. A un salto. E all’abbandono deciso di qualcosa – una lingua, forse – di inadeguato.
Il silenzio in questo senso è momento di sospensione assoluta. Di puro ascolto. Di ricerca felice. È l’attesa da cui partire. Un silenzio abitato da voci e immagini potenti perché ad esse, nel silenzio, nell’ascolto, viene dato finalmente spazio. Non c’è “mondo immateriale” senza “materia”, storia, parole, testi, interpretazione, incontri, immagini, corpi, suoni ad indicarlo. Bisogna cominciare da quelli, tenendo sempre presente l’ostacolo. Essere quindi malinconicamente fedeli alla “materia”, alle parole, ai testi, ai corpi, alle immagini, agli incontri.
E poi c’è la libertà. A suo modo sì profondamente immateriale. Una Fedra euripidea come filosofa platonica, paladina della libera morte, e non matura signora, divorata dal colpevole desiderio della carne. Una Alcesti sadica e simbiotica, onnisciente dark lady, e non icona dell’amore sublime, quasi in luce di culto mariano. È nello spazio d’ascolto che tu ti sei, comunque, passo dopo passo, costruito che possono poi comparire figure come queste, pronte, in un dato momento, a comunicare con te. A portarti altrove. Così mi sono, di fatto, comparse davanti Fedra e Alcesti. In un dato momento: mentre lavoravo tra testo e regia sulle figure euripidee. Prima a Stoccarda, per il Theater Die Rampe, poi a Milano, per il Teatro dell’Elfo. In seguito sono finite in un libro: Per amore (Il Saggiatore). Così come altri personaggi.
Lo spazio mentale, metafisico e concreto, del teatro, del palcoscenico, anche la temporalità e l’alchimia bizzarra di quello che sta prima delle rappresentazione, le cosiddette prove teatrali, svolgono un ruolo centrale nella mia ricerca e nella mia scrittura. Rendono un’idea del lavoro che amo fare. Durante le prove succede di tutto. È bene che sia così. E che si svolgano a porte chiuse. Non si può procedere dividendo soggetto ed oggetto, piuttosto si deve stare nella tensione tra i due poli. Mescolare i piani, rimanendo il più possibile lucidi, ironici anche.
Sì, forse per me il teatro è la metafora più adeguata, per eccesso, a sciogliere quel divieto di parlare che citavo all’inizio. Il teatro non corrisponde mai ad un atto apodittico. La scena teatrale è sempre agonica, dialogica, aperta. D’altro canto il teatro, come spazio dell’evocazione, ti libera dai vincoli della realtà, della Storia, ma mai da quelli delle parole, del testo, dei gesti, della coerenza, qualunque essa sia, dei ritmi e delle azioni. Il teatro è per natura incompiuto, senza chi guarda. Gli attori sono fantasmi in carne ed ossa. E le pagine scritte assomigliano agli attori.
AC: Parlando di teatro, come spazio concreto e tangibile di un immateriale fantasmagorico, mi sono venute in mente diverse esperienze importanti in questo senso: dai fantasmi pirandelliani alle anfore funerarie di Beckett. Potremmo dire, però, che la storia del teatro è da sempre intrecciata con l’esercizio della percezione del sé attraverso la rappresentazione di un altro «inesistente». Basta pensare a quanto il concetto di catarsi abbia sempre avuto a che fare con la rappresentazione teatrale, da Aristotele – e prima della sua Poetica – ai giorni nostri. In questo senso risulta essenziale la lezione di Grotowski per ciò che concerne le prove teatrali come atto quasi «rituale» che muove gli attori e il regista verso questo spazio, che tu definisci «mentale, metafisico e concreto», in cui «succede di tutto» e – aggiungo io – può succedere di tutto.
Come sappiamo esistono diverse tecniche, infiniti modi, per raggiungere la cosiddetta «catarsi» (che qui intenderemo come momento di estasi, ebrezza in grado di farci intuire qualcosa di più su di noi e su tutto). Mi viene da chiederti: assieme al momento delle prove teatrali – di cui vorrei mi parlassi più approfonditamente, dal punto di vista che ho appena illustrato – quali sono, e sono stati, per te, i momenti catartici nella tua vita e, soprattutto, nel tuo lavoro? Sia che si trattino di atti rituali, come quello delle prove o della scrittura, o di momenti singoli, come un sogno o un’esperienza particolarmente intensa e perturbante. Contestualmente: cosa pensi di questo spazio-tempo anagogico e delle tecniche che l’uomo ha sviluppato per raggiungerlo.
AG: Partendo dalle prove a teatro. Nella cornice del «teatro di parola» – l’ambito che mi appartiene – il mio lavoro con gli attori prende spesso un aspetto essenzialmente musicale. La ricerca di pause, sottolineature, pesi e misure interne. Ho iniziato la mia carriera di regista in Germania, in una lingua che, anche se la conosco al punto tale da osare scrivere per la scena, non è la mia lingua materna e all’interno di una tradizione altra rispetto alla mia di origine. Un ostacolo interessante. Questo è stato per me fondamentale. La mia percezione del tedesco e della lingua del corpo degli attori (che comprende convenzioni, automatismi, tensioni) è in teatro idiosincratica. Mi innamoro di parole/suoni e di ritmi o gesti per complesse ragioni che a volte non sono facili da districare. La pratica registica mi ha portato a lavorare sia con giovani attori sia con figure decisamente affermate in palcoscenico: ogni volta è (è stato) un incontro che, nel profondo, avviene in un livello altro, ineffabile, direi. L’altro da me che io sono diviene alla fine in scena tangibile, riconoscibile/metamorfico, decisamente straniero e familiare.
L’esperienza più perturbante e catartica che abbia finora vissuto è legata al lutto: la morte di mia madre. Una fine, iniziata in un ospedale pugliese e conclusasi a Berlino, annunciata da una dolorosa percezione della fine imminente, o meglio, dall’ammissione da parte mia, profetica e automatica nell’episodio di un dialogo quotidiano prima di una partenza, dell’impossibilità di aiutarla, nel momento in cui ce ne sarebbe stato bisogno.
Si è trattato, se vogliamo, della comune morte di un anziano in seguito a rottura del femore, legata a episodi di mala sanità meridionale. In un ospedale in cui lei non avrebbe dovuto trovarsi.
Al tempo stesso davanti ai miei occhi è avvenuto lo «squarcio del velo di Maya». Di questa vicenda vorrei prima o poi scrivere. In che forma non so. La sto cercando. È una esperienza che mi ha profondamente cambiata, aprendo uno spazio dentro e fuori di me dai confini, paradossalmente, mistici e politici, al tempo stesso. Mia madre, docente di lingua russa, aveva un’anima aorgica e slava, che a un primo livello pareva non incontrarsi con la mia. Abbiamo fatto un percorso insieme, nel buio, ci siamo scambiate i ruoli. Ad un certo punto ci siamo perse entrambe. Continuo a cercarla.
Forse che King Lear
alla fine
soffriva
di squilibrio
elettrolitico?
Dategli dell’acqua,
nel bicchiere.
Che una vecchia muoia di sete
in una corsia d’ospedale
per vecchi
di un paese civile
non è uno scandalo,
ma un fatto
come altri.
Che accadono.
Caso.
Ignoranza.
Fastidio.
Anche i bambini neri muoiono di sete.
AC: Desidero ringraziarti dal profondo per le tue preziose parole di grande sincerità. Credo che i momenti nei quali si apre un varco verso la comprensione ulteriore del mondo e di sé, nella nostra vita, costituiscano spesso un dolore, o si formino a partire da una sofferenza, in quanto: il processo della metamorfosi, del cambiamento – come per una crisalide che dal suo stadio ninfale diviene bruco – consiste in un atto di dolore necessario ma in ogni caso straziante, che fa del male. E per noi, spesso e volentieri, l’istante in cui inizia il processo metamorfico di consapevolezza, coincide o nasce da quello della catarsi, dell’abbandono all’irreale. Il momento in cui intuiamo profondamente chi siamo. Anche se non lo sapremo mai.
In questo senso «catarsi» e «metamorfosi» sono due concetti e due stadi strettamente legati, e indispensabili l’uno all’altro, di modo che l’uno dia senso all’altro e viceversa.
Vorrei terminare l’intervista chiedendoti – perché è una delle prime domande che mi sono fatto io stesso – di farmi qualche esempio, sempre da un punto di vista molto personale, di libri, spettacoli, dipinti, dischi, performances, o semplicemente persone, personaggi che con la loro presenza-assenza sono riusciti a darti quella stessa sensazione d’immedesimazione nel dolore altrui, tanto da farti vivere o rivivere i tuoi momenti di schiusa verso l’intangibile universo che custodiamo dentro di noi.
AG: Sempre e di nuovo accade.
Risalendo nel tempo, a quando le cose hanno un peso immenso, una messa in scena del Flauto magico vista alla Scala da ragazzina. Avevo la febbre piuttosto alta, tuttavia mio padre decise che potevo andare lo stesso a teatro con lui. Il tragitto in taxi nella nebbia, la musica, l’orchestra, le voci, la febbre. Tutto era magicamente perfetto.
Poi una messa in scena shakespeariana di Peter Brook, Sogno di una notte di mezza estate. Sempre da ragazzina. Ricordo il palcoscenico del Teatro Lirico a Milano. Vuoto. Solo le luci. Vedo ancora l’attore che interpreta Puck scendere, a testa in giù mi verrebbe da dire, lungo una corda che penzola dall’alto. Recita i versi in inglese. Dondola e parla nel vuoto.
Anton Čechov, per tutto quello che ha scritto è il mio modello di «uomo buono». Ho inseguito tutte le foto che lo ritraggono, per fortuna non poche, i suoi luoghi, i suoi occhiali. La lettura dell’Isola di Sachalin (il resoconto che fece del viaggio nella katorga, la colonia penale) è stata qualcosa di fondamentale.
Persone?
Titina e Giovannella, le mie due zie zitelle napoletane, pazze, angeli custodi di tanti segreti.
Incontri?
Comicamente surreali.
In una pizzeria di Courmayeur ho incontrato – per caso? – Samuel Beckett, non molti anni prima che morisse. Nessuno lo aveva riconosciuto in quel locale, solo noi «ginnasiali». Aspettavo con due amici di ritirare la nostra pizza da asporto. Beckett aspettava anche lui. Ovvio. Seduto davanti a noi su un divano, insieme alla compagna della sua vita.
Il viso di Samuel Beckett.
«Ma è proprio Lui?»
«Sì, è Lui».
«E noi adesso cosa facciamo?»
Noi tre ci siamo alzati.
Io ho domandato a sua moglie, se lui era Beckett. Non posso nascondere la cosa.
Lei ha annuito.
L’ho ringraziato per i suoi libri. Mi ha stretto la mano.
Anche gli altri due amici gli hanno detto qualche cosa, prima di scappare tutti fuori dal locale.
Abbiamo dimenticato di ritirare la pizza.
Nella notte gelida ci siamo messi a correre.
***