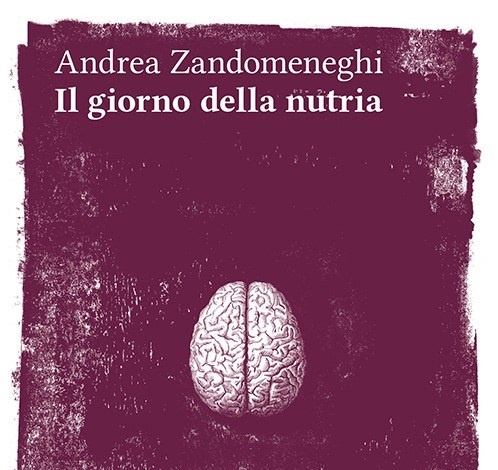Ti viene un cancro e tutti ti santificano – indifferente che tu guarisca o meno ai fini della canonizzazione. Ti scopri sieropositivo e sei dannato. Il mondo delle patologie è abitato da un severo discrimine che provvede ad assegnare colpe e meriti, condanne e privilegi – ad esempio per le malattie mentali non c’è pietà. Neppure le eziologie sono sempre determinanti: il cancro ai polmoni del tabagista (origine viziosa) o quello al collo dell’utero da papilloma virus (origine venerea) hanno la stessa benevola accettazione nella percezione sociale di quello al pancreas o all’ipofisi (origine, invece, neutra). È da un po’ che rifletto sulle contorte e imperscrutabili vie della maldicenza, del costume e dell’etichettamento. D’altra parte ho molto tempo per pensarci.
La biblioteca interna, qui al carcere, è indegna. Ecco perché penso: perché l’unico testo decente che ci ho trovato è una vecchia edizione Sansoni dei Karamazov orbata del finale, e perché quella testa di cazzo del medico mi dà sempre meno gocce di Rivotril, manco fosse lui a pagarle, quando a me ne servirebbero invece infinite di più. Imbottito di Rivotril te ne sbatti distaccato degli olezzi nauseabondi di piscio sudore sperma et similia, delle scemenze disarticolate e ripetitive grugnite o singhiozzate dai compagni ogni giorno più disumanizzati ed ebetificati dalla deprivazione sensoriale della noia concentrazionaria. Ma il nuovo medico niente, non accetta alcun tipo di mercanteggiamento, a differenza del suo rimpianto predecessore, un vecchio ciccione compiacente e perennemente arrapato. Potrei tentare con la simulazione di sintomi, ma il sospetto regna sovrano: qui tutti simulano. Simulano e si fanno le seghe. Si fanno le seghe e simulano. Nient’altro. Gli stupri e l’eroina sono leggende metropolitane, almeno da queste parti. I magrebini se lo fanno succhiare volentieri, è vero, soltanto che poi non ricambiano manco morti e insomma un po’ di reciprocità sarebbe anche gradita: hanno scarso spirito di adattamento, oltre al puntiglio di venirti in bocca che – anche tralasciando igiene e infettivologia – è cosa abbastanza sgradevole e pretesa quantomeno iniqua.
Comunque, qui penso. E più rifletto sulle leggi che governano la dinamica delle dannazioni e delle santificazioni da patologia e meno ne capisco la ratio.
«E poi trentacinque euro al giorno, gli danno».
«No, babbo».
«Maiala puttana, ti dico di sì».
«Li danno all’associazione per il vitto, l’alloggio e i corsi».
Da quando era filtrata l’informazione che trenta richiedenti asilo si sarebbero stabiliti in paese era dilagata una psicosi collettiva antimigranti con tanto di partecipatissima petizione popolare. I miei attenti e preparati concittadini non capivano che si trattava di una gara d’appalto indetta dalla prefettura e vinta da un’associazione che a sua volta aveva preso in affitto dei locali sfitti. Pensavano fosse una questione politica in senso lato e reagivano di conseguenza su istigazione di gente come mio padre, usando argomenti di tipo strategico-militare (“abbiamo solo due vigili urbani e tre carabinieri, non bastano per contrastarli“, come fosse ovvio che i rifugiati non aspettassero altro che assaltare i bastioni scalcinati di quella che una volta era stata la nostra inutile cinta muraria, assediarci, prendere il potere e deportarci a Mordor), di tipo economico-turistico (“con tutti questi siriani a giro nessuno verrà più in vacanza e ristoranti, alberghi e stabilimenti balneari saranno fottuti”: perché poi proprio siriani? di difficile lettura il passaggio che portava i siriani a risultare più minacciosi, che so, dei somali, dei pakistani o degli eritrei), di tipo securitario (“in inverno qui ci rimangono quattro gatti, la gente non potrà più uscire di casa, quelli non hanno nulla da fare e vanno a zonzo”, “sono solo maschi: te ne trovi una decina per strada e che fai?”).
«I corsi di che?» faceva mio padre «Di stocazzo! Ma poi a te che ti frega? Non sono mica soldi tuoi».
Rispondeva masticando a bocca aperta lo spezzatino di cinghiale in umido portato a casa per pranzo: avanzi del ristorante, del suo ristorante, quello gravemente minacciato dai richiedenti asilo.
Inevitabile di conseguenza fargli notare che non erano neppure suoi, quei soldi, considerando che era un evasore pressoché totale. Pensavo ne sarebbe seguita la solita litigata, invece mio padre mi dette un ceffone diretto, facendo sussultare mia madre che avevo messo a sedere accanto a me al tavolo e provavo a imboccare ottenendo perlopiù umilianti sbrodolamenti. Lei chiudeva gli occhi, quelli di chi ha una distrofia muscolare galoppante e riesce a fare giusto quello, poi iniziava a lacrimare in silenzio.
Mio padre mi odiava soprattutto perché sono un cefalgico cronico, condizione abbastanza inabilitante ma invisibile: la esperisce solo chi ce l’ha, ogni possibile riscontro obiettivo è vano. Il mal di testa, inoltre, è la scusa per antonomasia. Lui non lo sopportava, gli faceva ribollire il sangue, si vergognava della mia cefalea con la gente del paese e siccome non uscivo praticamente più di casa a volte diceva alla gente che ero al lavoro a Milano o all’estero e poi me lo rinfacciava. Anch’io mi vergognavo, perché ero riuscito a laurearmi, anche se nel modo più penoso, ma poi con l’aggravarsi della malattia non avevo trovato lavoro, anzi non l’avevo neanche cercato, e mi terrorizzava l’idea di fare un concorso pubblico. M’incistavo sempre più, avevo troncato i ponti, andavo a dormire vestito, non mi lavavo, guardavo porno e bevevo a scopo analgesico e amnesico dalla mattina alla sera. In sostanza bevevo per sopravvivere. Altri più ardimentosi di me magari avrebbero trovato soluzioni alternative e migliori. Io no. Io me ne stavo lì.
Sono certo che mi dette il ceffone perché qualcuno in mattinata gli aveva chiesto di me, mandandolo in bestia. Avrei dovuto reagire piantandogli il coltello nell’avambraccio o la forchetta nel dorso della mano appoggiata sul tavolo. La soluzione della forchetta mi era venuta in mente solo successivamente, rimuginando sull’accaduto in carcere, lì per lì invece la pulsione netta e univoca fu quella più tradizionale: trafiggergli la carne col coltello, sentirglielo affondare in corpo. Non era la prima volta che succedeva, sempre più spesso provavo il desiderio di colpirlo, a volte di pestarlo a morte o di scuoiarlo vivo (questo probabilmente perché in quel periodo leggevo molto George Martin). Certo, stavo attento, sono sempre stato bravo a controllarmi, ma la questione era troppo delicata e non mi fidavo di me stesso soprattutto perché non ero quasi mai sobrio. A guardarlo in faccia, sul muso, quelle guance flosce, quel gozzo immondo, quei baffi da idiota mi scatenavano le più sadiche e truculente fantasie.
«Sei un maiale schifoso» invece gli dissi «vi siete divorati tutto, facendo il vostro più porco comodo. Avete esaurito, lordato e dissipato tutte le risorse sociali, ideali e naturali. Vi siete abbuffati tracannando il mondo come se non ci fosse un domani. Non c’è rimasto nulla. Avete sfigurato la terra. E avete anche il coraggio di lamentarvi dei migranti e dei trentacinque euro?»
Urlavo, le vene del collo gonfie, ma non stavo improvvisando – quante volte m’ero prodotto in quell’invettiva soltanto in parte paracula nel buio della mia cameretta.
Lui fece per colpirmi, di nuovo. Gli bloccai il braccio e gli sputai in faccia fissandolo dritto negli occhi.
«La vostra generazione di cavallette ingorde ha saccheggiato ogni cosa, ogni spazio, ogni possibilità, ogni margine di manovra e di emancipazione. Ha trafugato e corrotto lo stato sociale e ora ve ne state lì, stupide zecche piene del sangue che avete rubato al futuro, seccandolo, facendone uno spettro agonizzante e disperato. E continuate a starvene lì, con la pancia piena, coi soldi e le case e le macchine e le crociere e i giardini e i climatizzatori e i vestiti e le pensioni, ve ne state lì, a pontificare su come dovrebbero andare le cose. Siete responsabili della rovina del mondo e di questo essere umano disgustoso di oggi».
Brandii il coltello e lo conficcai nel tavolo di cucina. Me ne andai piangendo. E mi chiusi a chiave in bagno. Per due giorni.
Fu così, chiuso in bagno, in preda a una modesta crisi d’astinenza da alcol, che compresi il senso della poena cullei, il supplizio che i romani comminavano al parricida: il figlio reo veniva cucito in un sacco con un cane, un gallo, una vipera e una scimmia. Trascinato solennemente lungo la via, poi buttato nel Tevere vicino alla foce cosicché, se casomai un giorno le carogne putrescenti fossero state riportate a riva dalle correnti e dalla risacca, in qualche luogo lungo la costa, chi le avesse rinvenute, anche volendo, non avrebbe potuto seppellire o rendere onori funebri al cadavere perché si sarebbe trovato dinnanzi un ossario promiscuo teriomorfo e teratomorfo. Una pena inaudita nella propria sofisticatezza e un apparato simbolico così potente, ancestrale e terribile che non trova riscontro nella repressione di nessun altro delitto e non ha corrispondenti in nessun’altra cultura antica. Questo era dovuto a una viscerale ossessione prodotta dall’assetto economico: all’angoscia dei padri, all’orribile incubo che li tormentava, al terrore di essere ammazzati dai figli. La società – come oggi, ecco perché ho capito tutto: io non ero che uno sgradevole animaletto domestico assoggettato al suo potere e in tutto e per tutto da lui dipendente – era patrimonialmente bloccata: i patrimoni statici si tramandavano di padre in figlio, ma finché il padre era in vita il figlio non poteva disporre di nulla, e così si dava il caso paradossale del giovane che terminando il cursus honorum, quarantenne diveniva console, la massima autorità pubblica, senza possedere la minima autonomia economica privata, perché ancora il padre non era morto. E i padri non dormivano sonni tranquilli, e i figli covavano sogni turpi e nefasti, sogni di liberazione. Gli stessi sogni nei quali mi cullavo io.
Passarono due mesi, e mio padre cambiò idea: i migranti andavano accolti, era un nostro preciso dovere morale e civile. Volendo godere dell’asilo avrebbero certo dovuto fare qualcosa in cambio, se non altro per gratitudine, per meritarsi il rispetto dei paesani diffidenti, e poi ovviamente per l’integrazione. Avrebbero potuto svolgere qualche lavoretto socialmente utile, magari potare le siepi dei giardini comunali o raccogliere gli aghi di pino. Così tutto sarebbe stato armonico, si sarebbero impegnati per il bene comune, non sarebbero stati a zonzo (che si sa, l’ozio è il padre di tutti i vizi), si sarebbero fatti volere bene, sarebbero stati accettati.
Mio padre coi soldi del ristorante, quelle entrate che il fisco ignorava o fingeva d’ignorare, nel corso del tempo aveva acquistato vigneti e uliveti, molti vigneti e molti uliveti: vendemmia e raccolta delle olive, braccia forti e giovani che lavoravano gratis. Ecco i lavoretti socialmente utili. Si buttò nel progetto anima e corpo, fondò un comitato d’accoglienza assieme ad altri benefattori umanitari, si mise a fare pressioni presso la prefettura perché la procedura amministrativa si velocizzasse. Raccolse fondi per riparare l’impianto di riscaldamento degli edifici destinati all’ospitalità che s’era scoperto usurato e l’associazione che aveva vinto l’appalto tentennava a volere riaggiustare paventando una rescissione del contratto con il proprietario. Con me non parlava più dal giorno dello sputo in faccia, di mia madre se ne sbatteva completamente. Voleva stoccarla in una casa di cura a lunga degenza in Piemonte. Io la lavavo, la cambiavo, l’accarezzavo, guardavo la televisione con lei e le leggevo i libri di fiabe che lei mi aveva letto da piccolo.
Poi la muscolomembrana dell’esofago le si sclerotizzò completamente e fu necessario metterle il sondino gastrico. Lei non lo voleva, io so che non lo voleva. Ma così andava fatto, avevano stabilito il medico e mio padre, che si prese un giorno libero per accompagnarla dallo specialista, benché in quei giorni sovraintendesse con entusiasmo totalizzante ai lavori di ristrutturazione e ampliamento della cucina del ristorante, che i migranti stavano per arrivare e lui si era aggiudicato il servizio mensa.
Saresti vissuta ancora per anni in quelle condizioni, mamma. E non lo volevi, te lo leggevo negli occhi, lo sentivo nei tuoi tremiti involontari quando ti cambiavo posizione per evitarti le piaghe da decubito. Io ero lì con te, lo sapevo, volevi solo che finisse quell’inferno di dolore che non potevi neppure urlare. Il mio non fu solo l’unico vero gesto d’amore della mia vita, quanto il gesto che alla mia vita ha dato un senso. E lui prese due piccioni con una fava, liberandosi di entrambi.
* * * * *
[Immagine di copertina: OZ, HBO, 1997-2003]
[La presente finzione è comparsa nell’antologia ODI. Quindici declinazioni di un sentimento a cura di Gabriele Merlini, effequ, 2017]