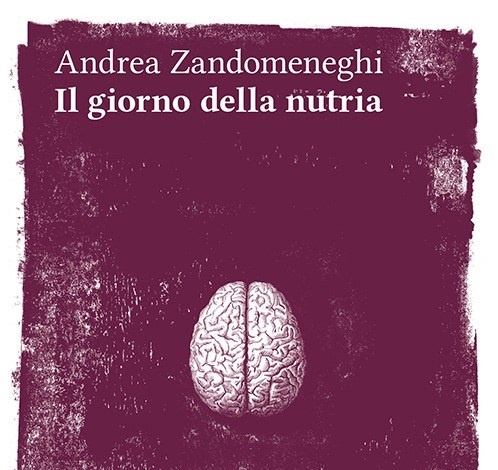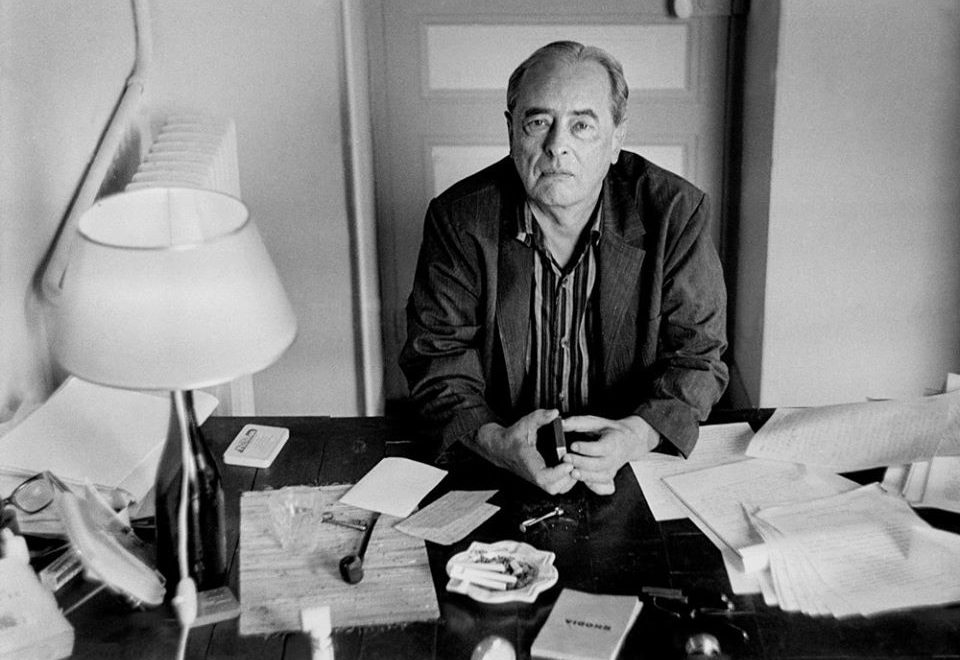Tagliaferro, un giornalista fallito tanto nel lavoro [«la mia carriera aveva avuto un picco negativo. Mi ero occupato solo di spazzatura. Articoli assurdi in fondo ai quali nessun giornalista serio avrebbe voluto mettere la sua firma. Avevo scritto della finale del Campionato mondiale di sauna (uno dei due finalisti era morto, ok, ma era poca roba), del ritrovamento di un preistorico ratto gigante, di due panda che si erano accoppiati grazie a un panda-porno e poco altro»] quanto negli affetti [la moglie l’ha lasciato per un docente universitario francese «che le spiega le teorie di Gadamer, Hamilton o Berkeley (non fa differenza). Lei non capisce ma è affascinata da quel parlare maestoso»], si ritrova – inviato dal proprio caporedattore – in una clinica psichiatrica per intervistarne il direttore. Attendendo l’arrivo del medico in una saletta d’aspetto, viene avvicinato da uno dei pazienti lì ricoverati: è così che Io (Tagliaferro) incontra Henry; il quale significativamente come prima cosa gli racconta la storiellina dell’Uomo Pesce .
La vita che Tagliaferro conduce è più che altro una sorta di lento e amorfo colare viscoso su un piano inclinato ormai privo di senso; un grigio, svilente e inesorabile disfacimento esistenziale, psicologico, emotivo e sociale: è uomo abulico, malamente imbalsamato nell’inerzia, prossimo alla putredine: «Io, forse per poca ambizione, forse per pigrizia, me n’ero stato lì, ad aspettare. “qualcosa comunque succederà” mi dicevo. Ne erano successe poche, di cose. […] Era quella la mia fine? Inabissarmi lentamente. Sprofondare nelle sabbie mobili senza nemmeno provare a lottare, consapevole che ogni mio gesto avrebbe solo accelerato il processo? Era un male inarrestabile, quello che mi stava divorando? Di cosa si trattava dopotutto?». Qualcosa però succede: a quel primo incontro con Henry ne seguiranno altri. Henry è un affabulatore instancabile, un cultore dell’aneddoto ameno, un narratore funambolico ed esplosivo dal passato quanto mai bizzarro e scarsamente verosimile: «era difficile seguirlo. Spesso saltava da un discorso all’alto. O Partiva per la tangente: rimbalzava tra le sue ramificazioni e ripiombava, in picchiata, sull’argomento dal quale era partito. A volte seguiva una logica incalzante, lucida, stringente; altre volte i suoi collegamenti passavano per strade alternative: un colore, una sensazione, una fantasia. Spesso i suoi monologhi erano pura recitazione, improvvisati sofismi privi di fondamento».
Questo libro divertente e spassoso tratta proprio delle assurde e fantasiose avventure in cui Tagliaferro sarà coinvolto – a capofitto! – da Henry.
Ho molto apprezzato il rifiuto da parte di Pesce dello sperimentalismo stilistico esasperato (morbo epidemico che miete implacabile fitte schiere di nostri connazionali); il suo optare deciso per la freschezza della linearità compositiva. In un giovanissimo – e dotato (non solo a livello di talento, ma anche proprio sotto il profilo dell’armamentario culturale) – autore questo è sintomo di maturità. Almeno a mio immodesto parere. Le continue impennate linguistiche e i frequenti cambi di registro e ritmo della sua prosa non vanno mai a discapito della leggibilità: la pagina – magari carica di stratificazioni semantiche, di citazioni, di cripto-riferimenti (c’è un fortissimo lavoro da questo punto di visita) – rimane sempre pulita, la sintassi nitida, classica (nel senso più elegante del termine). Anche grazie a una poderosa padronanza della punteggiatura.
Il taglio ironico del romanzo poggia soprattutto sulle peculiarità di un io narrante irrequieto, impressionabile, nevrotico, ipersensibile; talmente stralunato e dispersivo – piccole digressioni preziose ed esotiche costellano il testo – da sembrare affetto da disturbo da deficit di attenzione. Il suo tratto distintivo è l’iperbole alla Stefano Benni, ma sviluppata con maggior perizia, cesellata in maniera più sofisticata e raffinata (senza mai cadere nel retorico e nell’erudito fine a se stesso), lavorata con più ampio respiro e senza indulgere nel demenziale gratuito; tanto che a volte pare che in Pesce ci siano due voci, l’una che racconta le vicende e l’altra che fa parodia. Dello stesso Benni, dei primi pezzi di Paolo Villaggio, delle varie sfaccettature della dietrologia, dei rotocalchi scandalistici, dei luoghi comuni, delle specifiche ossessioni della narrazione contemporanea. La pennellata rapida, sicura e fluida riesce a costruire – una costruzione che è però scavo e ricostruzione storica fittizia – e restituire in poche righe scenari grotteschi e complessi. Curioso e ben fatto – perché bilanciato – l’uso satirico dei linguaggi specialistici incomprensibili (ad esempio quello finanziario). Macchinosa e inopportuna è invece nelle mani di Pesce l’allegoria, che per fortuna comparare raramente.
Il deliquio iperbolico acuto è tremendamente difficile come tono unico da mantenere per duecento pagine e inevitabilmente si riscontrano sbavature: non sempre il ricorso – molto frequente e spesso brillante: il libro è tutto uno spezzettare, centrifugare, cucinare e riproporre segmenti e frammenti di cultura classica, pop, cinematografica, musicale, filosofica, letteraria (una tendenza all’accumulo e alla riqualificazione di materiali che ricorda Palahniuk) – agli elementi dell’immaginario collettivo è ben calibrato, in alcuni casi è anzi disfunzionale e fastidioso perché banale [mi verrebbe da dire imperdonabile] e superfluo, ad esempio: «mi sentivo impotente come Gandhi di fronte a Terminator».
Un testo agile, certamente imperfetto, ma lodevole. Un testo scritto tutto di testa: col fioretto del mero intelletto – e per questo bidimensionale e un po’ leggerino. Mi piacerebbe molto vedere in futuro l’autore alle prese con la tridimensionalità dello spessore drammatico.
Giuliano Pesce
Io e Henry
Milano, 2016, Marcos y Marcos
pp. 233