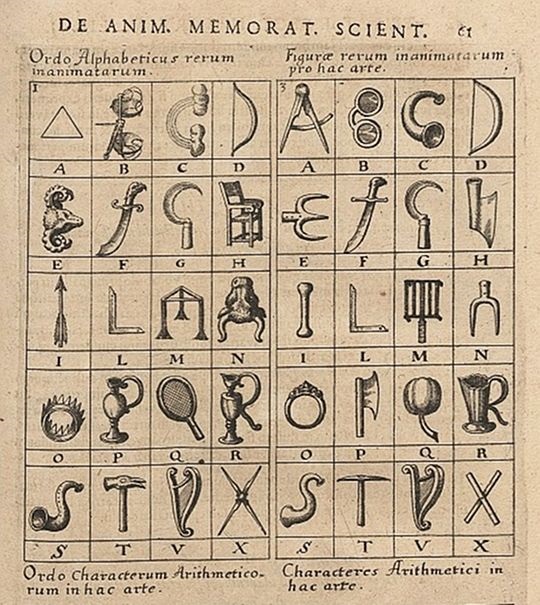È bene parlare solo quando si deve dire qualcosa che valga più del silenzio.
Abate Dinouart, L’arte di tacere
Il refolo di aria gelida che soffia poi smuore.
L’attimo di quiete prima del nuovo buffare del freddo.
Sul versante settentrionale del monte Sōngshān, a qualche giorno di cammino dalla capitale.
Una parete bianca. Neve finissima. Il rituale dell’inverno.
L’edificio centrale dello Shàolín-sì è un corpo di carne e sangue. Il viso indigeno, immobile. Una struttura ferma nell’eternità, un’ossatura senza tempo. Rossa. Tutto attorno sempreverdi, coperti di nevischio, splendenti di luce bianca. Le altre costruzioni subalterne sono prolungamenti dell’unica casa, del loro centro. Della corata del tempio.
Incedono, dentro il gigante, anime d’argento: i monaci.
Qui risiede il Bodhidharma. Qui si sta recando Huìkě.
Huìkě non è né giovane né vecchio. Tutta la sua vita è stata votata all’ascesi, lenta e paziente, verso una conoscenza superiore, un agire perfetto, da raggiungere attraverso la disciplina e la pratica.
Lo studio lo appassiona più di ogni altra cosa. Ma un monaco non separa lo spirito dal corpo o il sapere dal sentire.
In lui sopravvivono le antiche pāramitā, le virtù trascendenti; nel suo cuore muore l’esitazione e il dubbio. Quando i suoi passi si sono mossi per raggiungere il Bodhidharma non ha sentito il bisogno di chiedersi se fosse giusto. Sapeva esattamente che quello era il momento. Ha raccolto i suoi averi, pochi, essenziali, e si è messo in cammino. Con nessuna spavalderia o impazienza. Con una calma umile.
Dāna: generosità, disponibilità.
Si è preoccupato, innanzi tutto, dei suoi cari, degli allievi del tempio, dei testi sacri, delle ultime faccende e della sistemazione della sua cella. Ha regalato metà di tutte le sue rinunce al suo prediletto e l’altra metà ai monaci più giovani, perché potessero servirsene in futuro.
Śīla: virtù, moralità, condotta appropriata.
Dopo aver salutato ogni amico e compagno si è messo a pregare e meditare. Ha compiuto tutti i riti che precedono il viaggio, come si confà a un monaco prima di ogni partenza.
Ksanti: pazienza, tolleranza, sopportazione, accettazione.
Ha rispettato i suoi tempi interiori. Ha compiuto ogni azione come sentiva di dover fare. Ha conservato il sonno e pensato ai viveri e si è concesso anche un momento di riflessione. Su sé stesso e sulla sua vita. Senza dubbi o incertezze. Ha letto i testi sacri. Solo alcuni, quelli di cui sapeva di aver bisogno.
Vīrya: energia, diligenza, vigore, sforzo.
In ciascun istante della preparazione ha eseguito l’esercizio del sentire, intimamente, in profondità, fino a che non hanno vibrato le sue viscere. Ha vissuto. Non ha detto addio come se fosse in fuga. Ha assorbito la potenza del suo respiro nel qui e ora.
Dhyāna: concentrazione, contemplazione.
Non un chicco del suo essere si è volto altrove. La sua meditazione è stata costantemente impregnata dalla contemplazione. Il tutt’uno – formato dalle sue membra e da quanto è invisibile dentro di lui, il vuoto – ha lavorato all’unisono, suonando un’unica canzone.
Prajñā: saggezza.
Infine, si è messo a camminare verso il tempio Shaolin Shorinji per diventare allievo del Bodhidharma, solo perché sapeva che così era. Solo perché sentiva che così sarebbe stato.
L’incertezza non è concessa al monaco.
Huìkě segue, né rapidamente né lentamente, il cammino. Non esita mai sulla strada, men che meno nulla tenta di fermarlo, poiché sarebbe inutile. Il suo passo sicuro sul sentiero è un flusso inarrestabile e, d’altronde, non si fa spazio nemmeno dentro di lui nulla di simile a un inciampo delle intenzioni, a uno zoppeggiare della volontà. L’universo intero cammina con lui.
Dalla fessura dei suoi occhi il monaco scocca lo sguardo fino al primo avvistamento dello Shàolín-sì. L’apparizione del tempio è commovente, eccezionale. Potrebbe far nascere dall’epicanto di Huìkě una goccia di mare salato, ma le sensazioni del monaco sono sempre controllate ed egli non piange. In cuor suo vorrebbe ma non lo fa. In fondo ha passato l’esistenza a preparare tutto sé stesso a questo incontro. Si tratta di una questione di vita o di morte. Il monaco lo sa e questo lascia sorgere dentro di lui un’emozione sincera, un tremolio passeggero che incita le lacrime. Il monaco però non ha paura. Non ha dubbi. Si muove sulla neve deciso come una volpe bianca. Ha avuto un attimo di smarrimento alla vista del rossore delle pareti del tempio. Lo conosceva solo per sentito dire ed essere lì adesso lo scuote. Osserva i tetti verdognoli degli edifici che lo attorniano, di cui non sa nulla; di cui, tuttavia, aveva già immaginato tutto, aveva già visto ogni cosa. In fondo, vi è già entrato, nel tempio.
S’immobilizza solo per un istante. Quindi il passo inarrestabile del monaco si fa spazio, sgonfiando, sotto il suo peso, il cuscinetto d’aria, chiamato paura, che stava per crearsi nella sua consapevolezza infinita. Non un alito di freddo o incertezza ha spirato in quella cavità maledetta. Il monaco non ha permesso alle sue emozioni di dominarlo passando dentro a quello spiffero di commozione, perché una tale ingenuità potrebbe costare tutto a Huìkě. La vita o la morte.
Il refolo di aria gelida che soffia poi smuore.
L’attimo di quiete prima del nuovo buffare del freddo.
Sul versante settentrionale del monte Sōngshān, a qualche giorno di cammino dalla capitale.
Una parete bianca. Neve finissima. Il rituale dell’inverno.
L’edificio centrale dello Shàolín-sì è un corpo di carne e sangue. Il viso indigeno, immobile. Una struttura ferma nell’eternità, un’ossatura senza tempo. Rossa. Tutto attorno sempreverdi, coperti di nevischio, splendenti di luce bianca. Le altre costruzioni subalterne sono prolungamenti dell’unica casa, del loro centro. Della corata del tempio.
Incedono, dentro il gigante, anime d’argento: i monaci.
Qui risiede il Bodhidharma. Qui si è recato Huìkě.
L’ultimo passo, dei suoi passi da pellegrino, si poggia a qualche metro bianco dall’edificio centrale. Nevica. Il monaco sa quello che deve fare e come deve farlo: aspettare, in silenzio.
Huìkě accantona tutti i suoi averi sotto la grande tettoia del tempio, lavorata divinamente. Per un istante i suoi sensi di studioso lo inducono all’osservazione di quelle decorazioni uniche. Poi Huìkě si concentra, siede e serra lo sguardo.
Prajñā: saggezza.
Il monaco è una scodella perennemente vuota. Pronta per essere riempita. La sua sete di conoscenza non ha fine. Eppure, non la brama, sa rispettarne i tempi. Quando il Bodhidharma alza il primo passo fuori dal tempio, il suo allievo è già in ascolto. In attesa e in ascolto. Già apprende. Tutto rivolto alla fonte del sapere, ascolta i passi del maestro, ne intuisce il respiro, non gli si fa incontro perché è certo che lui sappia già del suo arrivo e della sua richiesta. Riconoscere il sapere altrui è già un ulteriore sapere.
Dhyāna: concentrazione, contemplazione.
Il primo giorno ciò che Huìkě riesce a percepire è solo uno scorcio sull’esistenza del maestro. Il monaco sa che ancora non è arrivato, per lui, il momento di fare o dire alcunché. Tace e medita. Il silenzio è esso stesso un luogo in cui aspirare alla completezza assoluta. Tace e medita. Il suo corpo è un’entità che già vaga all’interno del gigante rosso, erto davanti al suo capo nudo. Tace e medita. La sua anima è una sentenza di quiete. Il turbamento sibila, lamentoso, allontanandosi.
Vīrya: energia, diligenza, vigore, sforzo.
La vista del Bodhidharma è un bagliore, come di neve che riflette altra neve che riflette la luce del sole. I movimenti del maestro paiono quelli dei grandi uccelli. L’energia delle sue gambe riflette quella delle ali del condor. Il suo corpo è minuto e imponente al contempo. La chioma, un fiume di ghiaccio e neve, ricopre la testa e il volto, fino al petto spoglio. La veste bianca è ingrigita dal tempo ma conserva la limpidezza spirituale di chi la indossa. Al centro di questa candida nuvola, due diamanti celesti, celestiali, come stelle, sono fissati sul colore niveo, incastonati in un gioiello. Immobili e senza fine.
Ksanti: pazienza, tolleranza, sopportazione, accettazione.
Per altri quattro lunghi giorni Huìkě aspetta. Non sa quanti ne dovrà attendere. Le forze gli vengono a mancare. Il monaco tuttavia è concentrato, è paziente. È abituato a non parlare per settimane e mesi. Il silenzio è il suo spazio. Dialoga con i fantasmi, con i suoi mostri, e sconfigge ogni debolezza, accogliendola. Huìkě non ha paura del freddo. Huìkě non ha paura della fame. Non teme financo la morte. Conosce sé stesso e sente la pace del vuoto scorrere nelle sue arterie, in profondità. Solo il quinto giorno avverte che le sue energie di uomo lo stanno lasciando, ma il suo spirito è duro. Un marmo bianco. Un unico pezzo di marmo bianco. Anche se la sua carne s’indurisce e la cancrena inizia ad annerirla. Anche se il suo respiro è ormai un ricordo passato di mano in mano tra il suo inspirare e il suo espirare. Anche se i muscoli tremano e la sensazione di avere un corpo si affievolisce, appropinquandosi, la sua carne, verso la morte fisica.
Śīla: virtù, moralità, condotta appropriata.
Il monaco prega e medita. Non ha mai smesso, nessuno di questi lunghissimi giorni. Apprende, il monaco. Il suo maestro legge ogni giorno il Laṅkāvatārasūtra. Il sutra della discesa a Lanka. Il Bodhidharma lo recita e Huìkě ascolta. Il maestro insegna e l’allievo impara. Non c’è un momento in cui tutto l’essere del monaco non sia predisposto al nuovo sapere e alla sua profondità. Non c’è differenza, per il monaco, tra il sapere orizzontale e quello verticale. Il monaco cerca sempre di scoprire nuove idee e nuovi percorsi per l’ascesi e aspira anche a dispiegarne i segreti più oscuri, nascosti nel profondo, dove bisogna scavare con pazienza, per immergersi nelle acque nere dell’ignoto. Per arrivare al cielo.
Dāna: generosità, disponibilità.
Il sesto giorno Huìkě sente la morte vicina. La avverte nel sangue. Il freddo ha corroso lentamente le sue difese e ora intuisce che un altro giorno passato all’aperto, preda del freddo, potrebbe spezzare il filo, ormai finissimo, della sua esistenza terrena.
Per la prima volta il monaco ha paura. Ma la paura in lui è consapevolezza. Huìkě si concentra con maggiore intensità mentre siede a qualche passo dal Bodhidharma. Davanti al muro bianco. La sua mente ascolta il vuoto riempirsi. Sincronizza il respiro, che sembrava un ricordo, a quello del maestro. Sente il tempo. Sa il tempo.
Solleva il suo corpo stanco e morente da terra. Sfodera il suo dao, in un gesto unico che si muove coevo al respiro dello Shàolín-sì e dei monaci che lo abitano, come stelle incastonate su una nuvola, come gli stessi occhi del Bodhidharma, adesso serrati. La spada nella sua mano è uno scintillare di luce fulgida e il suono che genera nel silenzio è la prima nota di un mantra vedico, cristallino, poderoso. Squarcia la quiete.
Un secondo gesto accompagna la lama verso il gomito del suo stesso braccio sinistro. Il monaco sa cosa deve fare e come deve farlo: recide il suo avambraccio sinistro con un colpo secco e, con l’energia cosmica che gli vortica dentro, finalmente parla.
«La mia mente non è pacificata. Per favore pacifica la mia mente».
Magma incandescente zampilla dal braccio monco di Huìkě. Il dolore supera il freddo. Il gelo lenisce il dolore. La stanchezza affiochisce tutto. Perché la vita se ne sta andando.
Il dao adesso è una spada di luce scarlatta, lasciata cadere sul manto nevoso che si macchia di rosso. Sembra come se lo Shàolín-sì stia sgorgando sangue sul monte Sōngshān.
Huìkě afferra l’arto inerme stretto nella sua mano destra, l’altra, quella ancora viva. E vede che è morto. Quella parte di sé che non fa più parte del suo corpo, quel dono avverte Huìkě che la morte è lì, che lo ha seguito per strada e si è nascosta in una piccola piega di quel suo animo, comunque umano, comunque fallibile, comunque imperfetto.
Il Bodhidharma, d’altronde, non ha mosso nemmeno un piccolo lembo della sua carne. Non ha fatto alcun gesto che lasciasse intuire un qualche interesse. Anche se, a questo punto, parla. Risponde a Huìkě con una voce lieve, un petalo di prunus mume che naviga le spire del vento.
«Portami la tua mente e io la pacificherò».
Huìkě cade in ginocchio. Non sa più cosa rispondere al maestro. Per la prima volta in vita sua il monaco si sente sconfitto. Finito. Morto. Per la prima volta da quando è nato sente davvero la morte arrivargli al collo e stringerlo come un serpente. Sente la vita fuggire via, e con lei, la sua presenza consapevole. Si arrende, il monaco. Muore, il monaco. Si lascia andare all’abbraccio delle nuvole.
«Ho cercato la mia mente e non l’ho trovata».
Le sei pāramitā risiedono dentro di lui e fremono all’unisono, nel momento ultimo. Per prima, e per ultima, Dāna: il dono, la generosità, il vero. L’essere a discapito di tutto. Per ultima, e per prima, Prajñā: la consapevolezza, il sapere. Ovvero, sapere di non sapere: principio e fine di ogni cosa, cielo e abisso.
Nel momento in cui Huìkě pronuncia le ultime parole il Bodhidharma si volta lentamente verso quel ricordo di un uomo, quel monaco, in procinto di diventare spirito, di trascendere in forma spettrale.
I diamanti blu sul volto bianco del maestro illuminano quello che resta di Huìkě.
La linea invisibile della sua bocca vibra.
«Ho pacificato la tua mente».
E Huìkě entra nel tempio.