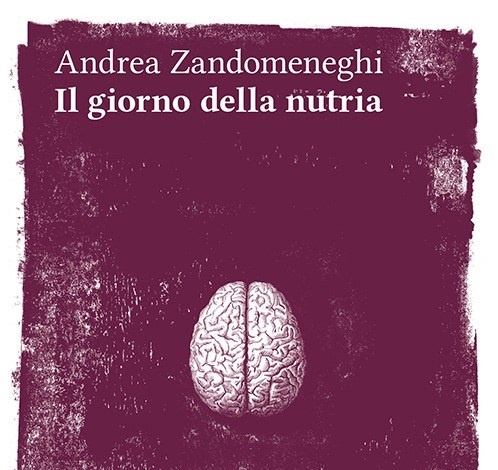MAPPA NORD-OVEST CONTINENTE FANOANO

ZONE INTERESSATE DAI REPERTI IN QUESTIONE
V – PAMONA
Da Dell’ordinamento imperiale, del Logofante Eufemiostomo da Aghisoro
Una celebre sentenza del Sarcopontefice Basileo Storone Maggiore è da tempo entrata a far parte dei modi di dire d’uso comune: «I Magistrati governano Pamona, il Principe l’Impero, il Senato la Repubblica». Per quanto l’asserzione di Sua Sacertà Basilea non manchi di una certa brillante efficacia, riteniamo si tratti più di un’arguzia che di uno strumento ermeneutico di teoria politica utile per una classificazione scientifica del controverso ordinamento della Repubblica di Pamona.
Taluni ritengono che la Repubblica sia in verità una monarchia, benché il Principato non sia ereditario, e anzi interdetto non solo ai discendenti naturali, ma anche a parenti e affini del Principe fino al quinto grado. Talaltri parlano di aristocrazia, sopravvalutando il ruolo delle magistrature e delle prefetture. C’è chi, più accorto, guardando al Senato, la definisce oligarchia; chi plutocrazia, per via dell’inarrestabile ascesa della Corporazione mercantile e delle torbide prassi che regolano lo svolgimento delle elezioni magistraturiali; chi democrazia, sottolineando come siano i cittadini la fonte di ogni legittimazione politica. Chi sofocrazia, esaltando l’influenza cruciale dell’Accademia nella formazione dei governanti e il suo dominio incontrastato nei tribunali. Infine, coloro che enfatizzano le prerogative dei Tribuni ocloici, facendo notare come il loro potere di veto – jus intercessionis scaturente dalla Potestà tribunizia sacrosanta – sia assoluto, sono soliti far riferimento all’idea di oclocrazia, il che è quantomeno fantasioso.
Cercando di mettere ordine nella congerie di concezioni contrastanti, tutte parziali, che abbiamo tratteggiato di sfuggita, diremo che, da parte nostra, crediamo che nessuna istituzione prevalga radicalmente sulle altre; ma che due di queste, Principato e Senato, si staglino nitidamente nel panorama pubblico e godano di una sostanziale supremazia, per quanto bilanciata da consistenti contrappesi. Preferiamo per tanto, quantomeno ai fini di questa trattazione, considerare diarchico il governo di Pamona.
VI – BRASSO
Da Storia e leggenda delle città fanoane, del Logofante Eufemiostomo da Aghisoro
Molti sembrano ritenere Brasso la meno prospera e possente tra le città fondate dai fanoani. Per comprendere quanto quest’impressione diffusa sia lontana dal vero basterà ricordare ciò che la misera memoria degli uomini della nostra epoca s’accinge ormai a seppellire nell’oblio; ciò che accadde esattamente sei secoli prima dell’ascensione al Principato di Aureliano Spanno, che ad oggi – mentre scriviamo, nella Biblioteca del Tempio di Aritme Catascopeio ad Aghisoro, questo agile compendio storico ad uso di ogni persona colta – continua a sedere sullo scranno più alto della Repubblica.
Correva l’anno 922 C.E. e Pamona viveva gli orgogliosi giorni del suo supremo splendore, avendo da tempo sottomesso i popoli abitanti le regioni lambite dalle acque delle Lingue del Mare. Il Magno Impero si estendeva dall’Isola di Fenn all’Eliotolia: le prime a cadere erano state Aghisoro e Prossa, trascinandosi appresso le altre città della Lega; si erano poi arrese Lisco, Potraco e Iscoto; infine anche la Vulonia s’era inginocchiata e Cratazio era stata di nuovo aggiogata. Solo Brasso resisteva ostinata. […]
Da Falino salparono sessanta dromoni diretti nella Lingua di Brasso, trasportavano quindici Legioni imperiali: mai dispositivo bellico tanto muscolare aveva solcato le Lingue del Mare. […] Sbarcarono a Ibi, il porto era deserto. Risalirono l’altopiano fino a Brasso non incontrando anima viva. […] Si narra che ad aspettarli alla Porta lignea di Brasso vi fosse un uomo piegato in due dalle risate, quando però si avvicinarono e questi si raddrizzò in posizione eretta senza smettere di sghignazzare, si accorsero con sommo, sgomento stupore che si trattava di Devapan: cornuto e caprino dall’ombelico agli zoccoli, eccetto che per il suo antropomorfo e torreggiante membro virile, che si massaggiava oscenamente. Non proferì parola, scomparve eiaculando mentre le orecchie dei soldati rombavano e i cavalli imbizzarrivano in preda a una pazzia senza nome. […]
Gli Oieforoi avevano deciso l’inaudito: i vecchi più decrepiti e i neonati, affidati alle cure dei sette Saptarsi, si erano rifugiati tra i boschi dell’Alagave, chiunque invece potesse cavalcare – compresi bambini, donne, sacerdotesse e schiavi, ai quali era stata promessa manumissione – era partito in armi alla volta di Pamona, via terra.
Mentre l’Esercito imperiale frugava le montagne all’affannosa ricerca del nemico, questi aveva già sbaragliato in sordina le deboli piazzeforti del Passo Aga e puntava di gran carriera al cuore dell’Impero. Simile tracotante azione non era stata mai né prevista, né creduta possibile, apparteneva al regno dell’impensabile: prima che la Repubblica riorganizzasse le difese la cavalleria brassiana, con la Ierofanta di Sacta in testa, era penetrata nella Piana pamoniana come arpione arroventato in medusa spiaggiata, liberando decine di migliaia di schiavi delle piantagioni e delle manifatture e invitando frettolosamente all’arruolamento, senza imporlo. […]
Non fu un esercito quello che travolse il presidio di Campo Pratese, che massacrò le quattro Legioni della guarnigione di Pamona e che oltrepassò – fatto unico: perfino Jacu secondo la leggenda vi s’era arrestato d’innanzi – le Mura Vecchie; fu un’intera popolazione in armi spalleggiata da un’orda scomposta di schiavi tanto macilenti quanto rabbiosi.[…]
Le donne ocloiche, seguendo Silvia Mugghia, strisciarono in ginocchio e baciarono supplicanti i piedi nudi dell’invasore in Piazza del Fieno. […]Il prezzo stabilito dalla Ierofanta di Sacta per evitare la strage completa e l’incendio della città fu ogni grammo d’oro presente in Pamona – inclusi anelli, denti, stoviglie e le decorazioni delle statue del Tempio di Pognata e del Senato – e mille fanciulli delle famiglie più cospicue come ostaggi.[…]
Quando Brasso si ritirò il crollo e lo smembramento del Magno Impero erano già in atto: insorsero da prima Aghisoro, Farusa, Molone, Carione e Cratazio, quindi l’Eliotolia. I giorni dei sogni di conquista per Pamona erano terminati, la attendevano gli incubi della guerra civile: Secceno il Reprobo e la Rivolta degli schiavi.[…]
Brasso è una potenza, ieri come oggi; una potenza che non vuole essere disturbata, che si cela.
VII – SACTA
GIULIA MARCELLA VARIA: Io e Francesco, dopo una colazione leggera, scendemmo a nuotare – una nostra tradizione infantile, di cui andavamo gelosi – al laghetto che delimitava a sud-est il giardino principale di Villa Varia, la tenuta di campagna della nostra famiglia, il ramo più illustre dei Vari.
«Devi capire che la loro Sacta è diversa dalla nostra, a Brasso pensano… Ehi! Stronzetta, basta col solletico! Ehi! Allora? Se me lo rifai non ti dico più una parola!» mi minacciò Francesco, fingendosi arrabbiato. «Dico sul serio!»
«Smetto, smetto subito. Lo giuro! Per nulla al mondo mi perderei la storia di come il mio amato gemellino è “diventato un uomo”» mi affrettai a rispondere, molto divertita. «Dai, racconta»
Era una piacevole mattinata autunnale, faceva abbastanza caldo, ma durante la notte s’era alzato il Pomento e l’ennesimo temporale si profilava già ai margini del cielo, verso nord. Fino al giorno precedente – dopo due settimane asciutte – avevamo sperato che il tempo volesse farsi perdonare per il rigore e le piogge interminabili degli ultimi due anni. I raccolti erano stati rovinosi, «il sole c’ha abbandonato» s’erano lagnati all’inizio i coltivatori, disperati. «Come può germogliare il grano se i pochi semi che non sono morti congelati annegano?» Quando poi era arrivata la carestia («un simile disastro non s’è mai visto, una tale crudeltà! Una perfidia della natura che non ha precedenti a memoria d’uomo, non ce n’è traccia nemmeno negli Annali! Cagna bastarda!») s’erano disperati anche tutti gli altri.
Il popolo di Pamona era affamato e arrabbiato; i suoi figli, indeboliti e malaticci, tossivano. Non smettevano mai di tossire. I suoi vecchi – mi aveva detto Varra, ma forse era una delle sue solite esagerazioni – si lasciavano morire, «rifiutano il poco cibo che si riesce a racimolare, si vergognano di essere una bocca inutile che pesa sulle spalle di altri e poi vedono i bimbi con la polmonite e gli si graffia il cuore. I poveri come pensi che si procurino da mangiare in città? Rubano! Come a chi? A chi vuoi che rubino? Agli altri poveri e a chiunque non abbia la forza di prenderli a bastonate in testa e calci nel culo». Se anche, finalmente, ci fossero state – e non c’erano – le condizioni per ottenere un raccolto normale, come tutti pregavamo, chi lo avrebbe avuto? Solo chi non s’era ipotecato il futuro per sopravvivere nel presente: chi non aveva dato fondo alle sementi da semina per nutrirsi. Ma chi non l’aveva fatto?
Asciugati e rivestiti, chiacchieravamo vicino alla riva dello stagno, sotto il salice piangente piantato dal nostro trisavolo, Ercole Vario, nel giorno in cui ascese al Principato e impugnò lo Scettro imperiale, come si leggeva nell’iscrizione d’oro sul piedistallo del suo busto, accanto a noi. Secondo Varra – che viveva di simili aneddoti – la scultura era stata ricavata dallo stesso blocco di marmo della panchina su cui sedevamo, trasportato a Pamona dalle cave di Iscoto: un risarcimento simbolico dell’Eliotolia per aver, più o meno inavvertitamente, speronato un dromone imperiale a largo del Porto di Lisco, durante la Quarta guerra di successione vulona. Il volto dell’antenato era piuttosto anonimo, generico, mentre i bassorilievi sulle gambe che sorreggevano la seduta avevano carattere. Da piccola potevo trascorrere pomeriggi interi a studiare i particolari di quelle raffigurazioni dei trionfi di Pognata Scioglitrice di ginocchia. Ero attratta soprattutto dalla più aggrovigliata e truculenta: la Dea degli eserciti, lorda delle viscere degli avversari, che stupra Pirito, prima di costringerlo a sposarla. Sullo sfondo Progni, con i suoi occhi abnormi senza ciglia né sopracciglia, assiste alla scena, attenta e imperturbabile; sapeva che sarebbe successo. Lo sapeva da sempre. Ofido le sta di fianco, tace e cova la collera montante. Progetta vendetta. La mutilazione di Niccheo.
Mio fratello era sdraiato supino, mi appoggiava la testa in grembo. Io osservavo gli anatroccoli avvicinarsi sospettosi alle tartarughe d’acqua tra i ranuncoli e giocavo distrattamente con i suoi boccoli castani, arrotolandomeli tra le dita. Gli sfioravo il viso di tanto in tanto, mi soffermavo tra il labbro superiore e il naso o sotto il mento, c’era una leggera barbetta: una novità, non l’aveva quando era partito per Brasso.
Francesco mi assomigliava. Da piccoli eravamo più simili, anche se non avevo mai creduto a chi non perdeva l’occasione per scambiarci l’uno con l’altra o per mostrarsi sbalordito dall’impossibilità di distinguerci, fingendo: una stupida moina, una commediola trita e ritrita. Come se si dovesse, per convenzione, in qualche modo sottolineare – a beneficio di chi? dei genitori? dei due bambini? e perché? – che i gemelli sono gemelli e rendere un ridicolo tributo di stupore alla cosa. Francesco sosteneva che «le persone non capisco la gemellarità»; che «per quanto riguarda la parentela, la complicità e le relazioni affettive, quasi sempre, si dà senso alle cose, purtroppo, solo rapportandole a se stessi e al proprio vissuto personale». Poi aggiungeva indifferente: «In questo si è più chiusi e più egoisti che in ogni altro campo». Dall’esterno i gemelli non sono solo indecifrabili («non si hanno chiavi di lettura, dammi retta Giulia!») in modo neutro, ma anche irritanti e problematici «per l’incomprensibilità fastidiosa ed impenetrabile della loro intimità, dei loro rapporti reciproci, della loro identità individuale, che risulta quasi duale a chi guarda da fuori. Ovviamente è una cazzata, ma immagina come rabbrividiscono, immagina che abominio: un’identità duale. Io e te siamo un maschio e una femmina, quindi peggio: un’identità promiscua». Ciò che non si capisce nell’ambito familiare ed emotivo tende a essere inquietante o peggio equivoco («vagamente inaccettabile, te lo assicuro sorellina») ed è normale reagire «addomesticandolo in frasi e approcci prestabiliti, fissi e rassicuranti; sostanzialmente quindi schivandolo: quello che ci angoscia lo si ritualizza».
Così lui giustificava tutto e tutti. Io gli dicevo: «Guarda che semplicemente le persone – nella maggior parte dei casi – sono stupide, non vale minimamente la pena provare a ricostruire le loro dinamiche interiori. E se anche ci provassimo non ci riusciremmo. La stupidità – propria e altrui – va tollerata, non giustificata. Le tue ricostruzioni sono proprio l’antecedente necessario della giustificazione e tu credi che la capacità di poter giustificare tutto sia un enorme traguardo morale. Ma non capisci che si tratta solo di una forma raffinata di cinismo totale?». «I fatti sono muti» mi rispondeva con aria di sufficienza, «vanno interpretati. Anche te quando valuti i fatti, dicendo ad esempio che sono stupidi, li interpreti. Continui a dire che io “ricostruisco”, in realtà vuoi dire che le mie interpretazioni sono arbitrarie, campate per aria, che a costruirle sono io. Ma se una cosa è muta, come i fatti, non ti racconta mica cosa significa e perché avviene, sta zitta: nell’interpretazione c’è per forza una componente decisionale oltre a quella conoscitiva. Vale tanto per le mie “ricostruzioni” quando per tue valutazioni».
Se insistevo però mi dava ragione, non gli piaceva stare a discutere. Da qualche tempo aveva questa fissazione per «la fattualità muta» e «l’interpretazione» e non faceva altro che pontificare in merito. Una volta se n’era venuto fuori addirittura – ladro di parole altrui! ghiandaia parlante! – affermando che «la fattualità è polisemica»: la storia e il diritto non gli interessavano minimamente, così faceva finta di studiarli ma di nascosto leggeva Massime e dialoghi di Marco Marciano il Pulcro, un librettino di brevi sentenze e conversazioni trascritte, alcune anche spiritose. «Che significa polisemica?» gli avevo chiesto. «Lo sai? Sai andato a cercarlo sul glossario?» Lui: «Significa che non ha un solo significato, ma molti; e di certo non ho bisogno del glossario, strulletta», e mi aveva dato un bacino sulla nuca. L’avevo incalzato: «Il Pulcro in che contesto la usa? L’hai trovata lì, no? Per sedurre quale delle sue vittime? La figlia del Principe o la moglie del Priore di Aghisoro? O forse la Regina madre di Vulonia? No, aspetta, la Regina no. Stavo dimenticando che l’hanno ammazzato per quella. Non può aver scritto nulla in proposito. Allora, quale è la frase completa?» S’era offeso, offeso veramente. Molto insolito. Non l’avevo punzecchiato, l’avevo aggredito. Dopo dieci minuti gli era passata e io m’ero pentita. – Ma i fatti sono veramente «muti»? Pensavo di frequente.
Francesco era un sedicenne atletico, impazziva per la caccia, i cavalli, il tiro con l’arco, la spada e ogni altro attrezzo usato per gareggiare nei tornei e soprattutto nei Giochi del maggio; esclusa però la balestra, che – in sintonia coi suoi compagni arcieri dell’Accademia – disprezzava («lo strumento degli incapaci! Tanto varrebbe essere caricatori di catapulte! Sbrodolatori di pece bollente!»). Proprio vista la sua spontanea abilità con le armi e considerato il suo interesse per i duelli agonistici, nostro padre – Marcello Vario – la primavera dell’anno precedente l’aveva mandato in Vulonia, a Cratazio. «Là potrà esercitarsi nell’uso della spada lunga, pratica che per i vuloni è una vera e propria arte» aveva chiarito il capofamiglia a nostra madre, che non era convinta; «ne apprenderà i segreti direttamente dall’insegnate del secondogenito della Casa regnate, che mi ha scritto di essere lieta di ospitare nostro figlio, la qual cosa è un onore. Ma voglio che parta anche per altri due motivi: anzitutto è tempo che conosca il mondo fuori da Pamona e in secondo luogo va allontanato per un po’ da Giulia. Capisco che siano gemelli e che si vogliano bene, ma è insano quel loro stare sempre così appiccicati!» Credeva che nessuno lo ascoltasse, invece io – con la complicità di Varra – origliavo da dietro una colonna del porticato interno.
Quell’anno era stata invece la volta del viaggio a Brasso, presso il fratello della mamma Oieforo della città. Francesco era tornato da pochi giorni ed era ansioso di condividere con me scoperte e avventure.
«Ti stavo dicendo che hanno una Sacta diversa dalla nostra, totalmente differente» riprese. «Loro dicono che Sacta è la vita. Ma non solo la vita che scorre negli uomini, negli animali e nelle piante. Anche la vita delle rocce, del mare, dei vulcani, del vento, insomma di ogni cosa. Dicono che ad esempio un sasso esiste, ed è duro, pesante e tutto il resto, perché è “pervaso da Sacta”, altrimenti non esisterebbe.»
«Cioè? In che senso?» chiesi.
«Non è che l’ho afferrato del tutto. Poi sai, loro non amano molto dilungarsi nelle spiegazioni. Per niente anzi. Lo zio Nuro ha farfugliato che in sostanza Sacta è la forza che fa esistere le cose, ma non nel senso che le crea… cioè, come se le cose per esistere avessero bisogno di possedere una potenza. Testualmente, dai Frammenti dello Spinossio: “Lo sforzo con cui ciascuna cosa si sforza di perseverare se stessa nell’esistenza, quello è Sacta.”» Imitava bene la calata brassiana. Era sempre stato bravo con le imitazioni, quelle di nostro padre e di Varra erano irresistibili.
«Eh? Boh… via, lasciamo perdere. Penso di aver capito, ma sinceramente mi sembra un’assurdità. Dimmi delle sacerdotesse. Ce ne sono molte?»
«Nel Tempio della voluttà, a Brasso, credo ce ne siano una decina, io però n’ho viste tre, altrove non lo so. Provengono da famiglie antiche e importanti, sono rispettatissime.» Si bloccò, sorridendo ebete e rimanendo in silenzio, come improvvisamente rapito da un ricordo – o un’idea? – prevalente.
«E insomma? Forza, racconta. Raccontami di come sei “diventato un uomo”» dissi ridacchiando, non riuscivo proprio a trattenermi quando usavo quest’espressione, per di più riferita a lui.
«Ma questi discorsi non sono adatti alle orecchie di una nobile fanciulla, come la mia sorellina adorata.» Si voleva far pregare.
«Allora?» troncai secca, era meglio non dargli spago.
«Tornavamo dalla caccia al cinghiale. Io ne avevo ferito uno nel costato con la lancia, abbattendolo poi con l’ascia». Si sedette, si tolse il sorrisetto dalle labbra e sospirò profondamente. « A Brasso usa che quando si uccide per la prima volta un cinghiale con la lancia s’è pronti a “diventare uomini”. Così, di ritorno dal bosco, i ragazzetti che hanno avuto la fortuna e la bravura – perché non ti credere che sia una cosa facile! – di ammazzare il cinghiale vengono portati in corteo, da tutti i partecipanti alla cacciata, al Tempio della voluttà di Sacta, senza passare nemmeno da casa per lavarsi. Quel giorno io ero il più grande. Loro solitamente “diventano uomini” prima dei quattordici anni, infatti i due che furono portati al Tempio con me erano più piccoli. Ma la spetti di sghignazzare? Dicono “diventare uomini” per una ragione: credono che non si nasca uomini. Lo si diventa solo quando ci si congiunge con Sacta. Le sacerdotesse, mentre officiano il rito, sono Sacta stessa.»
«Certo, ora è tutto chiaro» confermai spalancando gli occhi, assentendo con la testa e inscenando una seriosità volutamente demente. «Quindi t’hanno portato al Tempio, e poi?»
«Poi lo zio, a voce molto alta, s’è rivolo alle statue della divinità che sorvegliano l’ingresso del tempio: “Sacta, Madre degli uomini e di ciò che è, tu che instillasti nell’uomo il seme affinché potesse perpetuo filare il filo delle generazioni, questo fanciullo ha bagnato la terra, là dove s’abbeverano gli alberi tuoi figli, con il sangue della fiera che erra nelle selve. Io c’ero e te lo riferisco, testimonio di fronte a te. Sacta, Madre degli uomini e di ciò che è, abbraccia questo fanciullo e versa in lui l’uomo, come un tempo lo versasti in me e come lui ha versato per te il sangue”.
«Già, a proposito di statue: loro non raffigurano Sacta con il pancione e non la chiamano mai la Sempre gravida, né l’Onnipregna. La rappresentano invece senza occhi, con sei dita per mano e intorno al collo un serpente che inghiotte la sua stessa coda, lo chiamano Uroboras il Primogenito. Molte donne ne portano uno di rame come bracciale.
«Tornando a noi: dopo Nuro anche i parenti – immagino i padri – degli altri due ragazzetti recitano la stessa invocazione. A quel punto si aprono lentamente le porte di legno dorato del Tempio e esce la Ierofanta, una vecchia con la tunica verde e i capelli bianchi. Ci squadra e urla: “Entrate fanciulli nella Casa di Sacta, che la Madre degli uomini e di ciò che è versi in voi l’uomo”. I tre testimoni mettono dentro a una scodella smaltata che lei tiene in mano i cuori dei cinghiali che avevamo ucciso e che erano stati sventrati già nel bosco. Lei si volta, rientra e noi la seguiamo lungo un corridoio, fino a una stanza circolare dove al centro arde un fuoco, delimitato da un muretto a secco di mattoni. Ci fa sedere in cerchio, sul pavimento, con le gambe incrociate e arrivano le sacerdotesse, nude. Bellissime!»
«Come si può sedere in cerchio se si è in tre?»
«Non essere cretina! Avranno avuto al massimo venticinque anni. Dei corpi incredibili, seni sodi, snelle, fianchi perfetti e lunghi capelli sciolti. A me è venuto subito duro, da spaccarci i pinoli.»
«Non stento a crederlo! Sei un maniaco, un vero porco! L’ho visto prima, quando stavamo entrando in acqua. Ho visto che ti s’è risvegliato, anche se cercavi di nasconderlo.»
«Che devo sentire! Benedetto Orane! Pazienza divina!» esclamò, ridendo di gusto e scompigliandomi la frangetta. «Comunque: fanno il loro ingresso queste stupende femmine e iniziano a spogliarci, io provo a parlare alla mia, ma lei mi fa cenno di tacere, mi sfila le vesti e le butta tra le fiamme. Ecco, questo me l’ero scordato: i bambini hanno abiti variopinti, mentre invece gli uomini indossano toghe bianche. Sintetizzando: siamo lì tutti e sei intorno al fuoco, quando la Ierofanta getta sulle braci i cuori dei cinghiali e tre manciate di roba presa da un’ampolla – tipo semi e foglie tritate – che produce un fumo denso e aspro. Lo zio m’ha spiegato che si trattava di canapa di Fanoe, tant’è vero che mi sentivo leggero e annebbiato. La vecchia se ne va, ma prima di uscire versa sulle pietre che circoscrivono il focolare dell’acqua, che comincia a sfrigolare evaporando e trasformando la stanza in una sauna bollente e affumicata. Le sacerdotesse cantano una sorta d’inno ritmato, che imita – e quasi guida! – il pulsare delle tempie, in una lingua che non conosco e che non era di certo né l’Ecumenico fanoano, né l’Alto latino antediluviano, né – per quanto poco lo possa capire – l’A.g.a. Vanno avanti per mezz’ora, o almeno credo; perché ero rapito da quella litania evocativa, che sembrava fluirmi nel sangue, e dal fuoco. Una sensazione veramente curiosa! Verso la fine mi stavo addormentando nonostante l’eccitazione per la caccia e le femmine. Loro ci prendono per mano e ci conducono in un altro locale molto più luminoso e areato e lì ci lavano con cura in una piscina d’acqua fresca e profumata. Petali di loto viola. Poi, dopo averci cosparso d’olio e massaggiato tutto il corpo, ci portano ognuno in una camera separata. Ero contento, finalmente era arrivato il momento del sesso, ma un po’ deluso – anche se poco – perché mi sarebbe piaciuto fare l’amore nello stesso ambiente con le altre due coppie e di tanto in tanto sbirciarle. Che ti devo dire? Li sentivo come compagni e mi preoccupava l’idea di dividermi da loro.
«Vabbè, concludendo: la sacerdotessa m’ha fatto diventare un uomo. Dai! su, smettila di fare quella faccia, sto scherzando, ora ti racconto in dettaglio cosa è successo: da prima m’ha fatto stendere su un materasso a terra, m’ha sussurrato nell’orecchio il vero nome di Sacta, che solo gli iniziati possono sapere e che non ti rivelerò. Ha cominciato a baciarmi con tenerezza sulla fronte, sulla bocca, sugli occhi, sul collo, sul petto. Poi a mordicchiarmi l’ombelico mentre mi accarezzava le natiche e le cosce. È arrivata alle parti basse, quando me l’ha toccato io non… Ma chi diavolo è che grida così? Che è questo casino?» Francesco scattò in piedi, cercando d’individuare la fonte dell’improvviso vociare scalmanato.
Nel giardino, da dietro un tiglio, in direzione della Villa, sbucò il piccolo Giulio correndo a perdifiato. «Sta arrivando! Arriva Flavio!» urlava a squarciagola, inseguito a distanza da Varra zoppicante. «Francesco! Giulia! Sta arrivando! Flavio sta venendo a Pamona! Nostro fratello è stato convocato per domani dal Principe Aureliano insieme agli altri Generali. Giulia, ci verrà a trovare?»
Francesco si voltò e mi guardò. Arrossii. Troppo. Distolsi lo sguardo e fissai l’erba tra i miei piedi. Le guance mi scottavano. Mi passai una mano sulla fronte: era fradicia di sudore. «Flavio…» mi si strozzò in gola.
VIII – I NOMI
Da Dossografia universale. Libro terzo: La digressione come fondamento del discorso, del Logofante Eufemiostomo da Aghisoro
Il nome delle persone a Pamona consta di quattro elementi: nome proprio, patronimico, cognome e soprannome. Un esempio: Messenzio Varro Fortunata Antinterpolazionista. Messenzio è il nome proprio scelto dai genitori; Varro è il patronimico, ovvero il nome proprio di suo padre; Fortunata è il cognome che contraddistingue l’intera famiglia dei Fortunati e che si tramanda per via paterna; Antinterpolazionista è il soprannome, che è eventuale.
I Censori, su richiesta dell’interessato, posso disporre che un soprannome divenga il cognome; in questo caso ai figli viene trasmesso il soprannome e non il cognome originario, perché il cambiamento viene trascritto nelle leste censorie. Un esempio classico: Paolo Primo Burro Romano, diviene Paolo Primo Romano, il cognome Burro è cancellato, mentre quello Romano – ex soprannome – è passato alla storia.
Gli ocloici – ovvero i residenti stabili a Pamona non cittadini e non iscritti alla Corporazione mercantile – non hanno cognome, perché non hanno famiglia, ma hanno patronimico. Per i cittadini non nobili – le cui famiglie non hanno mai ricoperto magistrature nella Capitale – non si usa il patronimico, nemmeno nei documenti ufficiali; per i nobili nei contesti informali si tende ad ometterlo, ma compare sempre negli atti ufficiali. Gli schiavi hanno solo nome proprio. I liberti – schiavi manumessi – prendono come cognome il nome proprio dell’ex padrone o dell’ex padrona che li ha liberati. Un esempio: il padre di Messenzio Varro Fortunata Antinterpolazionista era uno schiavo e si chiamava Varro. La sua padrona, Donna Fortunata, lo manumise e così i Censori lo registrarono come Varro Fortunata. Gli schiavi manumessi non sono cittadini, a differenza dei loro figli. Varro Fortunata non poté mai concorrere alle magistrature, ma guidò l’Accademia come Reggente; l’Antinterpolazionista fu invece addirittura Propretore quatrumviro de legibus scribundis. Da questo si deduce che è più semplice divenire un cittadino della Repubblica per il figlio di uno schiavo che per il figlio di una ricchissima e antica famiglia ocloica. Gli ocloici divengono infatti cittadini solo per disposizione dei Consoli e per adozione.
*Illustrazione in copertina di Carl Gustav Jung (LIBRO ROSSO)