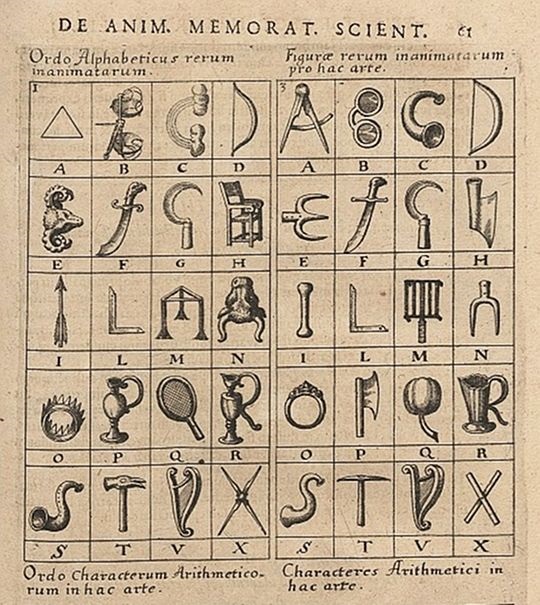«Sarà vero?» domandò lei, fissando l’uomo che batteva i pugni contro il vetro. Sembrerà strano, ma era quello su cui m’interrogavo anch’io da quando eravamo entrati nel museo. Nell’ultima mezz’ora avevamo ammirato un alce sotto formalina, caschi di banane che straripavano da un furgoncino, un teschio umano coperto da orsetti gommosi. Era tutto finto? A quanto lessi, le banane erano di resina, e così gli orsetti gommosi. Ma il bestione con le corna arrivava dritto dalle foreste finlandesi, e il teschio era stato la testa di un poveraccio del diciottesimo secolo. Ognuna di quelle opere era per me un punto di domanda, e l’uomo chiuso nella teca non faceva eccezione.
Già scendendo le scale verso il piano interrato, sentimmo i suoi colpi sordi, che si fecero più energici appena entrammo nel buio della sala. Non c’erano finestre alle pareti di cemento, le sole luci erano i faretti puntati sull’opera: una teca di cristallo delle dimensioni di una cabina telefonica. L’uomo rinchiuso al suo interno non era alto e aveva una macchia sulla camicia, per il resto non trovai in lui nulla di notevole, poteva sembrare un turista come noi. Sudava e non smetteva di battere i pugni contro le pareti di vetro spesso. Gridava, anche, ma da fuori non sentivamo altro che un mugugno ovattato, incomprensibile. Era vero? Beh, si trattava senz’altro di una persona in carne e ossa, ma l’intera situazione aveva qualcosa di ambiguo.
«Cosa facciamo? Chiamiamo qualcuno?» domandò ancora lei. Eravamo i soli visitatori nella sala, e il silenzio intorno a noi mi metteva a disagio.
«È solo una performance» dissi alla fine, come se questo chiarisse tutto. Mi accorsi di aver parlato a voce bassa, ma lei annuì lo stesso. Mi avvicinai alla teca; all’interno, in un angolo della base di metallo, c’era un cartellino con il titolo dell’opera e il nome dell’autore, ma i caratteri erano minuscoli e non riuscii a decifrarli. Intanto l’uomo aveva estratto il cellulare, lo vedemmo digitare in fretta un messaggio e premere lo schermo contro il vetro. Là sotto non c’era campo e noi non parlavamo la sua lingua, ma era chiaro che la sua era una richiesta d’aiuto.
«E se gli aprissimo?» chiese lei, avvicinandosi alla maniglia. La porta della teca ne aveva una, infatti, ma solo all’esterno. L’uomo la indicava con gesti sempre più espliciti, congiungeva le mani in segno di preghiera. Noi ci specchiammo, rovesciati e deformati, nel pomello d’ottone. Chissà, forse la performance era pensata per coinvolgerci, l’uomo sarebbe uscito e avrebbe fatto provare anche a noi la sensazione di stare sotto vetro. Tutto sommato, preferivo evitarlo.
«Meglio non toccare» considerai, indicando la videocamera di sorveglianza sopra l’ingresso. Quando capì che non avremmo fatto niente, l’uomo indietreggiò, prese slancio e si scagliò con tutta la sua forza contro la porta. L’impatto sembrò doloroso: la teca vibrò appena, non un singolo crepaccio si era aperto sul vetro.
«Andiamo via» disse lei, prendendomi la mano. La seguii senza resistenza. Ma mentre ci allontanavamo voltandogli la schiena, l’uomo riprese a gridare e a battere i pugni, e io mi chiesi se avessi commesso un errore.
Questo non c’impedì di passare le ore seguenti fra tele monocrome, piramidi di scarpe usate, gigantografie di funghi atomici, sale in cui si proiettavano film di un quarto d’ora su auto in fiamme e demolizioni al tritolo, installazioni di specchi e neon che ci facevano dubitare della nostra stessa esistenza. Il museo sembrava senza fine, e così la mia perplessità. Ma lei voleva vedere tutto, inclusa la caffetteria con terrazza panoramica e prezzi da rapina, e io l’accontentai. Però non riuscivo a togliermi dalla testa quel battito ottuso e disperato, gli echi delle manate contro il vetro infrangibile. Così, prima di uscire attraverso il negozio, insistei per scendere di nuovo nel sotterraneo.
Stavolta trovammo l’aria viziata e carica di voci, una babele di lingue. La sala era piena di famiglie con bambini, studenti d’arte che disegnavano schizzi, ragazze che giravano video e si scattavano selfie, una piccola e impassibile comitiva di giapponesi, un’intera scolaresca in uniforme. Lei voleva andarsene, ma io la trascinai fra i visitatori e, dopo aver pestato un paio di piedi, riuscii a guadagnare una posizione abbastanza vicina alla teca. Dentro, sulla base di metallo, erano sparsi i frantumi del cellulare dell’uomo. Lui era rimasto in maniche di camicia, zuppo di sudore. Continuava a battere i pugni e sferrava anche qualche calcio, ma appariva sempre più debole. Tutte e quattro le pareti di vetro erano opache per i segni delle sue mani, c’erano perfino delle scie rossastre, sangue sgorgato dalle sue nocche. Quanto al viso, era quello di un pazzo, stravolto, i capelli arruffati, le narici spalancate quanto gli occhi – un animale in gabbia.
«Da Oscar» commentò lei. Sembravano pensarlo anche gli altri, perché quando l’uomo si fece paonazzo e si portò le mani al collo, quando crollò all’indietro e cadde a terra immobile, tutti esplosero in un’ovazione.
«Capolavoro!» gridò qualcuno.
Un bambino approfittò della confusione per sgattaiolare fino alla teca e allungare una mano; ma il padre lo fermò e lo sollevò di peso prima che potesse sfiorare il pomello. Io non riuscii a unirmi agli applausi, che del resto scemarono appena fu chiaro che l’uomo non si sarebbe rialzato per raccoglierli. Calò il silenzio, sentii un freddo che non c’era. I ragazzini della scolaresca, sospinti dalla loro insegnante, furono i primi ad andarsene. Tutti gli altri, inclusi lei e me, seguirono a ruota, come se nessuno volesse rimanere là dentro per ultimo. Lungo le scale tenni lo sguardo a terra, ed ebbi l’impressione che anche gli altri evitassero di guardarsi in faccia.
L’idea era di passare la serata in centro, ma bevvi troppo sia durante l’aperitivo sia nel corso della cena, e in qualche modo il calice di rosso mi si frantumò in mano. Il mio sangue zampillò sulla tovaglia di lino e sull’anatra all’arancia, una scheggia di vetro mi era entrata nella carne. Da quel momento in poi non ricordo molto.
Il mattino dopo mi risvegliai nella nostra camera d’albergo, avevo la mano fasciata. Lei mi raccontò che dopo avermi medicato con l’aiuto del cameriere aveva dovuto portarmi via dal ristorante di peso. Non mi reggevo in piedi e per tutto il tempo, perfino mentre ero sdraiato a letto e lei cercava di sfilarmi i pantaloni, avevo continuato a blaterare frasi senza senso sull’uomo nella teca. Ora avevo un gran mal di testa, e né i rumori del traffico sei piani più in basso né la luce del giorno aiutavano. Eppure mi alzai e iniziai a vestirmi. La sbornia aveva cancellato dalla mia mente tutto, tranne la domanda che continuavo a ripetermi: «E se fosse vero?».
Quaranta minuti dopo ero in fila alla biglietteria del museo. Lei si era rifiutata di accompagnarmi: era il nostro ultimo giorno di vacanza, dovevo proprio sprecarlo in quel modo? Sordo agli insulti, avevo lasciato l’hotel senza nemmeno aver fatto colazione. Fui tra i primi a entrare nel museo, ad attraversare le sale ancora deserte sforzandomi di non correre, a lanciarmi giù per le scale verso il piano interrato. Dovevo sapere, dovevo vedere con i miei occhi che l’uomo era di nuovo al suo posto, riposato, ripulito, come ventiquattr’ore prima: un attore pronto a ricominciare la sua interpretazione.
Ma nella sala non c’era nessuno, eccetto un inserviente che fischiettava e finiva di strofinare il pavimento. La teca era vuota, la porta aperta, le pareti di vetro erano state tirate a lucido: dell’uomo non restava traccia, letteralmente, nemmeno un’impronta digitale. Cosa significava? L’emicrania era sempre più martellante quando mi avvicinai alla base, cercai il cartellino col titolo e il nome dell’autore. Mi bastavano quelle informazioni, su internet avrei trovato tutte le risposte. Ma i caratteri erano così piccoli, e appena mi chinavo per leggerli la testa cominciava a girare, la nausea risaliva…
Aspettai che l’inserviente se ne andasse, poi, fregandomene della videocamera di sorveglianza, entrai nella cabina e m’inginocchiai. Iniziavo a distinguere le lettere incise nel metallo quando sentii lo spostamento d’aria: la porta girò sui cardini senza un cigolio, si chiuse con un clic della serratura. Tentai di spingerla, mi alzai in piedi e feci forza, ma sapevo che era inutile, non si poteva aprire dall’interno. Presi il cellulare, cercai il numero di lei, solo per ricordare che non c’era campo. Ero in trappola, iniziava già a mancarmi l’aria. Appena sentii i passi di due visitatori che scendevano le scale, iniziai a battere i pugni contro il vetro.