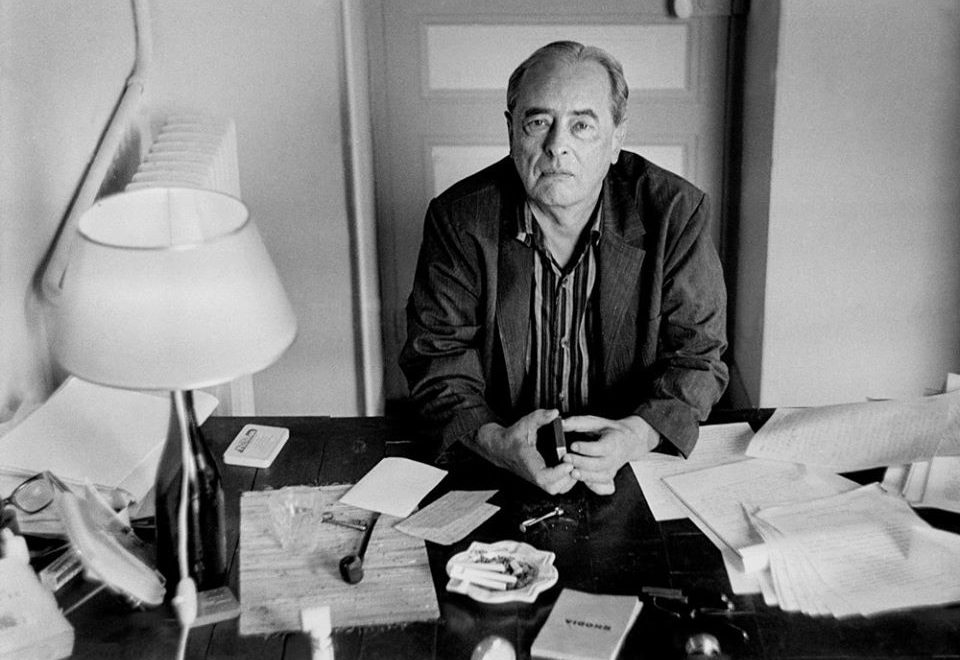C’è una regione dell’immaginario, compresa a grandi linee fra la Morte e la fanciulla di Hans Baldung e la «tempestosa leggiadria del terrore» che colse Shelley dinnanzi alla Medusa degli Uffizi, nelle immediate prossimità del Pandemonio ove precipitano, caduti, gli angeli, a mezzo tra «una sorta di immensa ed assai scoscesa forra» e una palude invero definitiva, non distante e forse anzi contenuta nel Gran Mondo in cui Mefistofele smarrisce Faust, animata dai concili orrendi che Tasso immagina nel Canto quarto della Gerusalemme non meno che dai riti dei benandanti, illuminata infine dal buio trasparente delle fiamme di Milton, fiamme esangui non dissimili dai bagliori d’oro che sfavillano sulla decadenza degli imperi, c’è appunto una regione dell’immaginario, così circoscritta, dove la bellezza è inestricabilmente avvinta alla corruzione e dove si salda per più non sciogliersi «il misterioso vincolo tra piacere e pena», per usare le parole di Mario Praz, che di questa bizzarra regione è stato il più lucido, appassionato esploratore.
Qui, per inclinazione forse nutrita dall’impressionabile lettura giovanile di un romanzo dallo scarso valore letterario ma dal perdurante potere immaginifico come Intervista col vampiro, con i suoi esausti eroi in cui l’angelico e il demonico sono indistinguibili quanto il connubio fra appetito sessuale e voracità ematofaga, ma in realtà forse innata, perché presente, dacché ricordi, nella predilezione per certe uggiosità della sera e dell’autunno e nel favore accordato a ogni opera si discostasse dal realismo più anodino – il realismo, dirà Lovecraft, non è mai bello –, favore in seguito confermato e accresciuto dall’incontro momentoso con Baudelaire prima e Rimbaud poi, qui, dicevo, mi sono trovato e tutt’ora mi trovo a soggiornare di frequente, e volentieri, anzi con trasporto, nella scrittura e nella lettura.
E al cinema, in televisione. Così, quando, tre anni fa, Showtime – il canale via cavo che, vale la pena ricordarlo, ci regalerà, spero presto, la terza stagione di Twin Peaks – ha annunciato una serie ambientata nella Londra vittoriana e popolata dei grandi miti della letteratura nera – da Frankenstein a Dracula –, al primo, travolgente entusiasmo è seguito il sospetto che inevitabilmente prende chi debba accogliere un ospite sconosciuto in stanze a lungo ritenute esclusivo appannaggio delle proprie fantasie; sospetto che solo si è dissipato davanti al primo episodio, e anzi, più ancora, davanti al secondo, imperniato su una macabra séance[1] così perfettamente pensata, diretta, interpretata da essersi subito profondamente inscritta nella mia riserva segnica e simbolica.
John Logan (The Aviator, Hugo, Skyfall, Spectre) è uno scrittore elegante, con un polso sicuro per il fraseggio vittoriano e un’idiosincrasia per le metafore ardimentose, e ha potuto giovarsi, a fronte di registi efficaci ma mai eccelsi, di una produzione sontuosa, che in nome di un barocchismo sfrenato ha dato fondo a ogni risorsa di cipria e corsetti, di broccati, boiseries e trucchi di teatro: il risultato è un’opulenza visiva che, a chi sia appunto abituato ai frutti maturi ma già guasti di quella regione fantomatica, scatena una dipendenza oppiacea. Non importa – almeno non importa a me – l’intersecarsi delle trame, l’acribia descrittiva, il labor limae psicologico, che pure concorrono alla riuscita della serie. Quello che importa è, e torno a Shelley, o meglio: torno allo Shelley raccontato nelle prime pagine de La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica, testo per me seminale se mai ce n’è stato uno, quello che importa sono l’orrore e la grazia che, in ogni inquadratura, impietriscono frammisti lo spirito del riguardante: ’tis the tempestuous loveliness of terror.
***
Alla fine dell’introduzione al Patto col serpente – suoi paralipomeni alla Carne – Mario Praz ricorda un passo del Paradiso perduto e scrive:
Adamo carezza Eva, e Satana il serpente, che è come il suo «doppio», la sua propria immagine. Non resta a Satana, nella sua invidia, che ripiegarsi su se stesso, e ciò è rappresentato da Blake con l’immagine di Satana che abbraccia il serpente, «self-contemplation is self-enclosure, and deadens the soul».
Praz lo definisce «abisso della sterilità», riconoscendovi un tratto cardine del decadentismo, ma oso dire che è forse possibile fare un passo in più.
Satana non abbraccia se stesso, a ben vedere; abbraccia un’immagine di sé, come Narciso, che, a differenza di quanto vuole la vulgata – è Agamben a sottolinearlo, in Stanze –, non è innamorato di se stesso, bensì della propria immagine riflessa. È insieme nel desiderio per l’immagine e nell’inattingibilità della stessa che si gioca la sua tragedia, e la nostra; almeno quella di chi condivide la natura in tutto precipua della regione che ho cercato di delineare all’inizio: regione perduta perché mai posseduta, e proprio per questo dolorosamente desiderata.
È allora un volgersi continuamente indietro, un riavvolgersi serpentino, quello che lì ci risospinge, fra i fantasmi, «all the shunned and broken creatures», nel tentativo, impossibile, di riappropriarci di qualcosa che abbiamo irrimediabilmente perso pur senza mai, appunto, averlo avuto: è lo stesso movimento – ancora e sempre giocato sullo sguardo – che porta il Satana ricordato da Praz nel Paradiso terrestre, a contemplare Adamo ed Eva, perfetti in un’unione edenica che non conosce la propria, pur imminente, fine,
… while I to hell am thrust,
where neither joy nor love, bur fierce desire,
among out other torments not the lest,
still unfulfilled with pain of longing pines…
Piacere e pena, misteriosamente saldati, un cerchio, una circonferenza, fanno di questo movimento all’indietro, à rebours, come il Des Esseintes cui molto deve il Dorian Gray di Penny Dreadful, forse ancor più che quello di Oscar Wilde, un supplizio di malinconia nostalgica che non guarisce.
D’altronde, e per questo torniamo, torniamo, non è forse «la mélancolie, toujours inséparable du sentiment du beau»?
[1] Ancorché il video su YouTube riporti la scena nella sua interezza, attenzione: ridicole leggi sul pudore di molto annacquano la coprolalia di cui cade vittima, durante la possessione spiritica, o invasione psichica, il personaggio interpretato da Eva Green, divina qui come altrove mai, se non nella sua memorabile apparizione statuaria in The Dreamers di Bernardo Bertolucci.