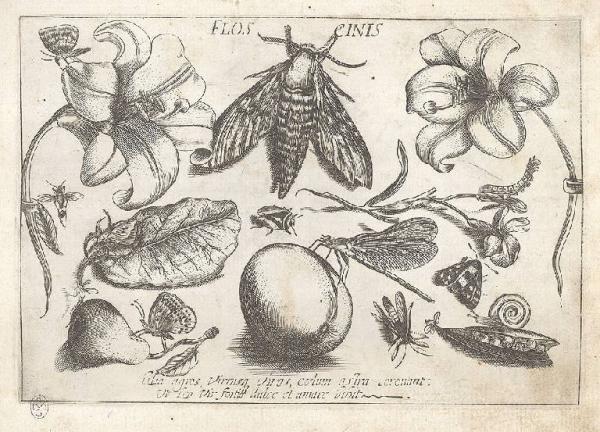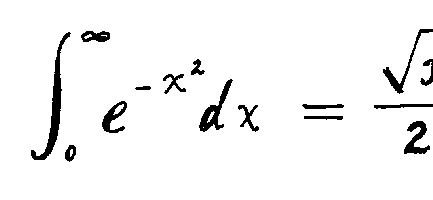
Il personaggio di cui diremo in queste righe vanta la singolare caratteristica di camminare sollevato da terra.
Per quanti passi egli possa compiere i suoi piedi infatti non toccano mai il suolo, nessuno però si accorge di questa peculiarità perché la distanza che lo separa da terra non è visibile a occhio nudo. Soltanto il terzo paradosso di Zenone, il calcolo differenziale di Leibniz (con buona pace per l’irascibile Isaac Newton) o l’infinita grandezza dello sproporzionato uomo di Pascal potrebbero rincantucciarsi nello spazio tra i suoi piedi e il suolo.
Non riusciamo a credere che questo caso sia l’’unico che, tra innumerevoli, ma pur sempre finite osservazioni, falsifichi una teoria — nello specifico, la legge di gravità della geniale mente del già (tra parentesi) citato Isaac Newton — preferiamo piuttosto pensare che questa anomalia gravitazionale sia la strana conseguenza di un’altra singolarità del nostro personaggio: la quasi altrettanto rara abitudine a tenere gli occhi costantemente rivolti verso il cielo.
Fingendo ipotesi, ci piace immaginare che tale postura gli abbia col tempo donato un inconsapevole slancio verso quegli infiniti spazi che lo atterriscono al punto da non curarsi di ciò che gli accade intorno. Non è infatti un’ipotesi, ma per l’appunto un dato di fatto, che nel muoversi nello spazio occupato in un tempo delimitato — chiedendosi peraltro senza posa: “Perché questo tempo? Perché questo spazio?” —, finisca con l’urtare chi, per caso o scelta, gli si avvicini.
Non è nemmeno da trascurare il dolore al collo che comporta tale postura: di non solo anima è fatto l’uomo!
Si racconta che Michelangelo, durante i quattro anni che impiegò per realizzare l’affresco sulla Volta della Cappella Sistina, dovendo stare supino sull’impalcature e dipingere guardando verso l’alto, si abituò a tal punto a questa posizione che, in quello stesso periodo, quando riceveva una lettera riusciva a leggerla soltanto tenendola sopra il capo e rovesciando la testa all’indietro. Lasciateci allora immaginare (immaginazione riproduttiva, stando a Kant) quest’uomo — è pur sempre un uomo il nostro personaggio — con lo sguardo perpendicolare al cielo (non sempre stellato), interrogarsi sul senso della luce: tra onda elettromagnetica e metafora di divina rivelazione; riflettere sulla possibilità del movimento — se decido di muovere la testa, questa si muove verso un altro spicchio di cielo: qual è il nesso tra intenzione e azione? chiedersi il perché dell’esistenza e finanche il perché dei pensieri sul suo perché.
Col corpo immerso nello spazio infinito e la mente nell’altrettanta infinita serie temporale di cause — causanti e causate — in cui riesce a scorgere soltanto l’impossibilità di giungere alla Causa Prima, il nostro personaggio si smarrisce in un terrore marcescente e che, quando in questa duplice infinitudine perde la consapevolezza di sé, diventa sussultorio.
Ma nonostante la paura o forse piuttosto proprio per questa, mantiene saldamente gli occhi all’insù. A volerla disegnare, la sua vita somiglierebbe più a una linea retta che non al buffo arabesco che anche l’osservatore più indulgente, da vicino, si vedrebbe costretto a riconoscere; arabesco condizionato dai malfermi passi ma anche dal continuo urtare contro cose e persone nel suo incedere con la fronte parallela al cielo.
Urti non senza conseguenze per sé, le cose e gli altri.
Urti che diventano ferite e colorano di sangue il suo maldestro cammino.
Urti da cui nascono frammenti e da cui i suoi piedi creano macerie.
Eppure, per quanto sofferente di dolori al collo e tremori sussultori, pur circondato da rivoli, frammenti e macerie, il suo sguardo resta fissato sul cielo e i suoi piedi eccetera eccetera.
“Questa”, direbbe se potesse leggerci, “è la mia vita”.
Potremmo raccontarla, anno dopo anno ora dopo ora, soffermarci suoi singoli fatti che l’hanno portato a essere ciò che è o sulle circostanze che hanno impedito che diventasse ciò che sarebbe potuto essere: parole da aggiungere a parole sino a giungere all’ultima possibile.
Ma consapevoli del limite semantico della parola fine, che di fine autentica non può esservene che una, e ammirando per di più la mano sinistra di Jan Six, preferiamo non indugiare oltre su questo ritratto, liberare da esso quel po’ di fantasia per permetterle di inseguire nuove ombre iridescenti, e lasciare il nostro uomo sospeso tra l’infinito che gli nega il cielo e l’invisibile spazio che lo separa dal suolo.