Giuseppe Girimonti Greco
Il tuo romanzo d’esordio, Il pantarèi, che sarà riproposto dall’editore pugliese TerraRossa nei primi mesi del 2019, è stato pubblicato nel 1985, ed è rimasto la tua sola opera edita fino al 2016, quando è uscito Eclissi per Nutrimenti. Le poche informazioni che si possono trovare online su quel libro (singolare sin dal titolo) lo presentano sostanzialmente come un “meta-romanzo”, e più precisamente come un meta-romanzo che racconta la storia del romanzo del Novecento. È una definizione efficace? In quel tuo esordio così meta-, quanto c’era di consapevolmente e deliberatamente sperimentale e post-moderno? Ma innanzitutto: com’è nata l’idea del Pantarèi? Forse la questione (vagamente ansiogena) del destino e del futuro della forma-romanzo, così com’era stata rimodellata nel corso del Novecento, era anche un po’ nell’aria, in quegli anni…
Ezio Sinigaglia
Ricordo molto bene la genesi del Pantarèi. Nel mio desiderio di scrivere mi sentivo frenato dalla consapevolezza di essere stato preceduto da una vera e propria rivoluzione del genere romanzo, ancora piuttosto recente, a quell’epoca. Una rivoluzione che si può grosso modo identificare con la stagione più matura – per non dire finale – del grande romanzo modernista, che da una parte capovolge completamente il concetto di tempo della narrazione (perdita dell’ordine cronologico) e dall’altra mette via via in discussione tutti gli elementi fondanti del romanzo: ambiente, vicenda, personaggi. Mi domandavo quindi, dopo che il romanzo era stato così fatto a pezzi da questa generazione di grandi autori, Proust, Joyce, Woolf, Musil, e pochi altri, che senso potesse avere mettersi a scrivere un romanzo e che romanzo si potesse scrivere. Così l’idea di cercare una risposta scrivendo un romanzo proprio su questo argomento nacque in modo abbastanza spontaneo. Fra l’altro io avevo cominciato fin dai ventitré-ventiquattro anni, appena finito il servizio militare, a collaborare con varie case editrici, che a quell’epoca (anni Settanta) producevano un numero enorme di enciclopedie, e quindi scrivevo di qualsiasi argomento: mi capitò anche di scrivere, come accade a Stern, il protagonista del Pantarèi, un breve saggio sul romanzo del Novecento. Quell’idea si fece quindi più concreta: era un’idea molto promettente, che mi consentì di scrivere, prima di tutto, un romanzo, mettendo alla prova il mio eventuale talento, e in secondo luogo di scrivere appunto un romanzo sperimentale che raccontava la fine del romanzo sperimentale.
Ma certo Il pantarèi nasceva, oltre che da una mia esigenza personale, anche dal clima dell’epoca. Eravamo nella seconda metà degli anni Settanta e la sensazione che circolava era che il romanzo sperimentale fosse finito, con il conseguente interrogativo: che cosa verrà dopo? Si sarebbe anche potuta trovare l’audacia di dire: il romanzo modernista è morto. Punto. E forse è proprio da questa semplice osservazione che potrebbe essere nata l’idea di post-modernità in letteratura, anche se il termine post-moderno credo che nasca in un ambito più filosofico, di storia del pensiero, che non in un ambito artistico o letterario. Il pantarèi, in fin dei conti, è in effetti un romanzo post-moderno, benché a quei tempi io non fossi in grado di formulare questo concetto. Post-moderno anche in questo senso: che viene ad affermare “il romanzo modernista è morto ma il romanzo non è morto e non può morire”, come appunto sostiene il saggio scritto dal protagonista Daniele Stern nell’ultimo capitolo, quello su Robbe-Grillet, l’autore che arriva alla negazione più estrema di tutte.
Giuseppe Girimonti Greco
Giacomo Debenedetti, se non ricordo male, non amava Robbe-Grillet. Per molti “lettori di romanzi” che si sono formati alla scuola di Debenedetti lo sperimentalismo francese alla Robbe-Grillet non solo, come giustamente ricordi tu, metteva in discussione le coordinate fondamentali della forma-romanzo, ma minava anche la compattezza ontologica del “personaggio-uomo”. In certo qual modo, Debenedetti ha cercato di salvare, perlomeno sul piano teorico, l’integrità del personaggio-uomo dal rischio di una sua irreversibile disgregazione e, parallelamente, la forma-romanzo dal rischio dell’autodistruzione; e lo ha fatto contrapponendo al Nouveau roman le migliori espressioni del romanzo modernista. Forse non è un caso che Il pantarèi si concluda proprio con Robbe-Grillet… Ha influito sulla genesi e sulla stesura del tuo romanzo il “racconto critico” di Debenedetti (penso ovviamente al suo Romanzo del Novecento, uscito postumo nel ’71 e poi più volte ristampato fino a metà degli anni Ottanta e oltre)? Prima della pubblicazione del Pantarèi, hai avuto modo di leggere altre narrazioni di taglio meta-romanzesco, o le hai scoperte più tardi? Quanto e come ti sei documentato per scrivere Il pantarèi?
Ezio Sinigaglia
Partiamo dall’ultima domanda. Per scrivere Il pantarèi mi sono documentato moltissimo, leggendo un’enorme quantità di materiale critico…
Giuseppe Girimonti Greco
Forse sarebbe meglio raccontare sinteticamente la trama del romanzo…
Ezio Sinigaglia
È la storia di un “poligrafo senza occupazione” (come viene definito nelle prime righe), Daniele Stern, che in realtà fa il “collaboratore editoriale”. Di solito fa piccoli lavori tipo correzione di bozze, traduzione di gialli, e simili. Stavolta invece gli viene affidata la stesura, per una non certo innovativa Enciclopedia della donna, di un saggio di 40 pagine sul romanzo del Novecento, all’interno di un progetto editoriale molto confuso. Un lavoro pagato benissimo: mezzo milione di lire in cinque giorni (circa 3 milioni del 2001, che mi sembrano parecchio di più di quel che contabilmente sono: 1.500 euro di oggi). Stern comincia a scrivere e, benché continui a dirsi che lo fa solo per ragioni alimentari, rimane molto coinvolto nel lavoro (anche perché è uno scrittore mancato, o non ancora realizzato). Stern si discosta dalla scaletta che gli è stata data dalla casa editrice (simbolica è l’esclusione di Thomas Mann, che lui immagina gli verrà contestata) e sceglie una linea molto precisa: quella che si potrebbe definire di rinnovamento e autodistruzione del romanzo. Più procede nel lavoro più trova che questa linea abbia una sua coerenza. È vero che nel “canone” di Stern entrano anche autori che non collaborano a questa distruzione, ma semmai a una costruzione diversa di quello che, come tu ricordavi,
Debenedetti definisce il “personaggio-uomo”: autori come Svevo e Kafka, diversissimi fra loro ma entrambi interessati a proporre un nuovo tipo di “eroe” come protagonista delle loro storie. O anche Céline, un autore antipatico ma che Stern giudica indispensabile inserire nella sua rassegna, perché porta al rinnovamento del romanzo il contributo della sua straordinaria inventiva linguistica. Ma il nerbo è costituito dagli autori (Proust, Joyce, Musil e per finire Robbe-Grillet) che danno invece ciascuno il proprio contributo alla demolizione del romanzo di impianto tradizionale, ottocentesco, in tutti i suoi elementi costitutivi: tempo della narrazione (Proust, ma non è certo questa la demolizione più traumatica), ambiente e personaggi (soprattutto Musil), vicenda (Musil e soprattutto Joyce, che fa esplodere la storia in una miriade di frammenti). Musil è in un certo senso il più estremista di questi tre “classici”: la sua opera distruttiva concerne tutti gli elementi costitutivi del romanzo, ed è anche l’unico autore che, anziché smontare il romanzo dall’esterno per poi ricostruirlo, lo corrode dall’interno con lo strumento dell’ironia: ad esempio l’incipit convenzionale del romanzo ottocentesco (“Era una bella giornata d’estate dell’anno x”) si trasforma, nell’incipit dell’Uomo senza qualità, in un vero e proprio bollettino meteorologico, lungo non meno di una pagina. Musil demolisce anche il personaggio, facendone appunto un “uomo senza qualità”, esattamente l’opposto dell’eroe del romanzo ottocentesco. Quale contributo porta Robbe-Grillet a questa demolizione che, apparentemente, era già stata compiuta dai suoi predecessori? Porta la distruzione più amara di tutte, la più difficile da accettare e da digerire, la soppressione di quella cosa che potremmo definire con una parola che non è facile tradurre correttamente dal francese: l’humanisme, cioè l’“umanismo”, piuttosto che “umanesimo”.
L’umanismo della letteratura, l’aspetto umano del raccontare, l’interpretazione umana della realtà: è contro questa residua forza del romanzo che Robbe-Grillet scatena la sua battaglia. Naturalmente Stern nel suo breve saggio cita la famosa pagina del romanzo d’esordio di Robbe-Grillet, Le gomme (a mio giudizio di gran lunga il suo più bello), in cui viene descritto un pomodoro, ed è una descrizione che – lo si capisce fin dall’inizio: “Uno spicchio di pomodoro senza il minimo difetto: ricavato a macchina da un frutto perfettamente simmetrico” – prescinde totalmente dalla natura o, per meglio dire, dalla funzione alimentare del pomodoro stesso (dalla sua mangiabilità). Lo rende cioè un oggetto non solo “inedibile”, ma del quale non è previsto alcun uso da parte dell’uomo. Tutti gli oggetti di Robbe-Grillet vengono trattati in questo modo: vengono deprivati della loro funzione in rapporto all’uomo. Intendiamoci, l’esigenza di Robbe-Grillet è in parte condivisibile: secoli, millenni di letteratura hanno accumulato su ciascuno degli oggetti che ci circondano una patina arbitraria di interpretazione umana, sentimentale, poetica, che ne deforma o nasconde la natura. Secondo l’allora giovane autore francese si trattava di cancellare (ecco il perché del titolo del suo romanzo d’esordio) queste stratificazioni e di restituire gli oggetti alla loro “magrezza” originaria.
Robbe-Grillet, poi, nei suoi libri successivi, a mio parere si perde un po’ per strada, ma la cosa interessante di questo scrittore (la cosa che mi ha indotto a inserirlo nel canone del Pantarèi) è il fatto che abbia anche molto teorizzato sul suo lavoro di scrittore e sul nouveau roman da lui fondato, e questo mi offriva la possibilità di contrastare la sua teorizzazione con un’altra teorizzazione (fondata sulla metodologia del paradosso) per dimostrare non soltanto come il romanzo non sia morto ma addirittura come proprio la posizione di questo autore porti a concludere che è impossibile ucciderlo, il romanzo, perché restano pur sempre, alla fine, un autore, un libro e un lettore. Robbe-Grillet era molto adatto, secondo me, a chiudere questo discorso: era più masticabile di Beckett, e quindi anche più verosimile in un saggio che il protagonista scrive per un’enciclopedia (tradizionalissima come impostazione) “della donna”, per una destinazione insomma molto convenzionale e divulgativa (questo, ovviamente, in una prospettiva di finzione che rifletteva le dinamiche del mercato culturale dell’epoca). Beckett è difficilissimo, quasi illeggibile come romanziere, mentre Robbe-Grillet lo si legge e capisce benissimo, ed è anche – almeno in questo primo romanzo – abbastanza divertente, e al tempo stesso conclude degnamente questa parabola con quello che potremmo definire il felice insuccesso del suicidio del romanzo. Un suicidio che sembra compiersi ma che alla fine fallisce. Restano le rovine di questa grande operazione di rinnovamento e insieme di demolizione, e su queste rovine non si sa più bene che cosa costruire.
È questo il problema da cui nasce l’esigenza di scrivere Il pantarèi e che resta, più che irrisolto, aperto alla fine del libro. Il romanzo non è morto, continua a esistere, ma che cosa sarà? Che cosa è destinato a diventare? Ecco perché, prendendo in considerazione la mia produzione successiva, non si può prescindere dal Pantarèi, che in qualche modo la determina. Io ho continuato a scrivere perché mi piaceva e mi interessava, ma a quel punto, non potendo più sperimentare là dove già molto era stato sperimentato – sull’architettura del romanzo, sulle macro-strutture –, ho pensato di sperimentare sulla lingua e sui generi. Così quello che ho scritto dopo non ha apparentemente una sua coerenza – ogni libro che ho scritto è un libro completamente diverso dagli altri – ma la sua coerenza sta proprio in questo, nel fatto che ho continuato a sperimentare, anche là dove non sembra: Eclissi non sembra un romanzo sperimentale, ma a suo modo lo è: in Eclissi ho giocato moltissimo con i registri linguistici, anzi: con le lingue tout court. È anche un romanzo appartenente a un genere per me nuovo: un romanzo della memoria, sì, ma soprattutto un romanzo di viaggio, genere molto affascinante e che non avevo mai frequentato. E forse è anche il primo esempio di un genere letterario nuovo: il romanzo astronomico o post-astronomico. Scherzo, ovviamente…
Giuseppe Girimonti Greco
Nei due decenni successivi al Sessantotto non si è parlato d’altro, in letteratura, che di questo: romanzo sperimentale versus romanzo, diciamo, “alla vecchia maniera”. Romanzo dopo Proust e Joyce versus romanzo scritto come se Proust e Joyce non fossero mai esistiti. È questo lo spartiacque…
Ezio Sinigaglia
Sono certamente d’accordo con la sostanza di quel che dici, ma forse non del tutto con la periodizzazione che proponi, perché, quando nel 1980 e negli anni immediatamente successivi Il pantarèi ha circolato per le case editrici collezionando apprezzamenti e rifiuti, la stagione del romanzo sperimentale, in realtà, si era già conclusa. Direi anzi che, in una prospettiva da editore lungimirante, si sarebbe potuto pensare di presentare quel romanzo (scritto, è vero, da un esordiente e quindi, per la mentalità di allora, troppo ambizioso e troppo importante per esistere), sì… di presentarlo, dicevo, come l’ultimo romanzo sperimentale, un romanzo che parlava di sé stesso, del romanzo sperimentale, dicendo in modo abbastanza scoperto che quella stagione era finita e domandandosi che cosa sarebbe seguito. I decenni del romanzo sperimentale erano stati i Cinquanta e i Sessanta, anche se certo in Italia questa evoluzione era stata molto rallentata dall’esperienza del neorealismo che, pur essendo in fondo l’unica scuola narrativa di una certa importanza nata in Italia, è stato anche una stagione che si è prolungata esageratamente nel tempo, frenando ogni altra novità (e oltre tutto, a lungo andare, stimolando quell’aspetto provinciale e localistico che già era stato tipico del verismo di fine Ottocento-inizio Novecento e che costituisce a ben guardare la palla al piede, tuttora pesantissima, della letteratura italiana).
Ma la vera stagione del romanzo sperimentale si era conclusa già alla fine degli anni Settanta, direi. Una data significativa è il 1981, che avrebbe potuto e dovuto essere l’anno di pubblicazione del Pantarèi e fu l’anno di pubblicazione del Nome della rosa. Da qui si può arguire che l’attesa di qualcosa di nuovo era molto forte e che Il nome della rosa è stato un romanzo a suo modo di grande importanza nel segnare una svolta che è stata definita, forse in seguito, e retrospettivamente, come post-moderna: un romanzo però che non andava nella direzione di un vero rinnovamento del genere romanzo che desse per acquisita quella rivoluzione di cui parla Il pantarèi, ma che ritornava un po’ (se vogliamo anche provocatoriamente e beffardamente) sulla cara vecchia forma-romanzo di matrice ottocentesca. E da allora in fondo è sempre stato così: anche i libri più interessanti, quelli presentati come nuovi, in realtà – e non solo in Italia – è raro che abbiano offerto (o offrano) qualcosa di davvero nuovo. Il post-moderno, in letteratura, scivola facilmente nel pre-moderno se non addirittura nell’anti-moderno. Io continuo a chiedermi: come si fa a scrivere romanzi che non tengano conto di quello che è successo nel secolo del modernismo? Come si fa a scrivere romanzi fingendo che Joyce non sia mai esistito? E in Italia, romanzi che non tengano conto del passaggio di un autore fondamentale come Svevo? Praticamente l’unico autore italiano che abbia dimostrato di avere letto e assimilato Svevo e di esserne stato trasformato è Giuseppe Berto. Anche Moravia sicuramente è stato un buon lettore di Svevo, ma il solo che ha tentato di proseguirne l’esperienza, secondo me, è stato Berto, che da Moravia e dal suo entourage era letteralmente detestato, e disprezzato.
Chi parlava di questi argomenti in quel periodo? Be’, sicuramente Giuliano Gramigna, che è sempre stato uno dei pochi critici militanti che avessero una profonda conoscenza del romanzo contemporaneo non italiano. Altri nomi? Non saprei. Giacomo Debenedetti era morto da un decennio. Certamente io, nell’accostarmi a questo progetto così ambizioso – che ho affrontato quando avevo ventotto anni e non avevo ancora scritto nulla che avesse una qualche dignità letteraria –, ho cercato, con i mezzi disponibili allora (repertori bibliografici e biblioteche), qualche saggio che avesse una prospettiva analoga alla mia, che cercasse cioè di ricostruire la storia del romanzo del Novecento in modo comparatistico. Non trovai quasi nulla. Il mio romanzo aveva anche questo di insolito: nella sua parte saggistica aveva un taglio assolutamente comparatistico; se ne infischiava delle letterature nazionali, e a quanto pare a quei tempi questa modalità era davvero rara. Degli otto autori a ciascuno dei quali è dedicato un capitolo del Pantarèi tre sono di lingua francese (Proust, Céline e Robbe-Grillet), due di lingua inglese (Joyce e Faulkner), due di lingua tedesca (Musil e Kafka) e uno di lingua italiana (ma diventato italiano a quasi sessant’anni: Svevo). Comunque non trovai nulla che mi tornasse davvero utile, che mi prestasse un’ossatura: l’ossatura ho dovuto costruirmela da solo, con la lettura dei romanzi dei vari autori e della letteratura secondaria su ciascuno di loro. Per me quindi Il pantarèi è stata un’esperienza straordinaria, che mi ha trasformato da un grande lettore e aspirante scrittore in uno scrittore realizzato: fu l’esperienza più formativa di tutta la mia vita. Tuttavia devo dire che le difficoltà che ho incontrato sia nella fase di stesura, per la mancanza totale di predecessori, sia soprattutto in fase di (mancata) pubblicazione sono state difficoltà sorprendenti, per certi aspetti molto significative della arretratezza della cultura italiana di quel decennio.
Giuseppe Girimonti Greco
Le postille al Nome della Rosa sono in effetti considerate un manifesto del romanzo post-moderno italiano. Ma anche secondo me il rinnovamento proposto da Eco va in realtà in direzione di modelli consolidati e “di sicuro effetto”, come il romanzo gotico, la detective story alla Poe, etc. Il che, beninteso, per me è un pregio inestimabile… Tra l’altro, sia detto per inciso, in ambito accademico sorge, periodicamente, quasi ciclicamente, un certo disaccordo sul canone post-moderno italiano e – più in generale – sul concetto stesso di post-moderno in letteratura. Non c’è convegno nel corso del quale non si registrino tensioni in questo senso… Da un lato, io apprezzo gli studiosi che si sforzano di sistematizzare questo “oggetto misterioso” della critica e della teoria letteraria (e di definire un corpus, una mappa); dall’altro, sento una certa affinità con chi contesta l’attribuzione alla narrativa post-moderna di caratteristiche che in qualche modo le preesistono ampiamente (il meta-, l’intertestualità, l’allusività, la vocazione combinatoria, l’ibridazione saggio-romanzo, ecc.).
Ezio Sinigaglia
E comunque Il nome della Rosa appartiene all’unico sottogenere del genere romanzo che in Italia abbia una vera tradizione illustre: il romanzo storico, che naturalmente ha i suoi limiti dal punto di vista di quella che è la grande, autentica gloria del romanzo, cioè la sua capacità di rappresentare la società del tempo, non solo con finissima sensibilità per l’attuale ma addirittura con istinto profetico. Per quanto riguarda la definizione di post-moderno, potrei aggiungere che, fra i caratteri genetici che sono considerati tipici della “scuola”, ne figurano alcuni che sono propri del romanzo fin dalle sue più remote origini (basti pensare alla dimensione ludica e parodica o alla commistione alto-basso di certi romanzi antichi, primo fra tutti il Satyricon); ma quel che più mi sorprende è che ne figurano altri che sono invece tipici del romanzo modernista, come appunto l’ibridazione saggio-romanzo, di cui almeno Proust e Musil sono stati indiscutibili maestri…
Giuseppe Girimonti Greco
Su questi problemi, che sembrano squisitamente teorici ma che vanno sempre riconsiderati in una dimensione rigorosamente diacronica, pena la totale vacuità dell’intera controversia, esistono, per fortuna, dei saggi fondamentali, che hanno il merito di fare chiarezza e che, in alcuni casi, hanno, come si suol dire, fatto scuola. Penso agli studi di Clotilde Bertoni e Massimo Fusillo sui topoi romanzeschi “di lunga durata”, a quelli di Conte sul Satyricon come organismo testuale implacabilmente allusivo (oltre che modernissimo, dal punto di vista narratologico); e, sempre a proposito di modernità dei classici (e di post-moderno ante litteram), mi torna in mente un bellissimo studio di Sergio Zatti, che è stato fondamentale nella mia formazione di italianista: Il Furioso fra epos e romanzo (1990). Di recente, poi, è uscito, per Bompiani, un volume di ampio respiro che fa il punto su quella che Barthes chiamava la “terza forma”, ovvero la commistione di romanzo e saggio: Stefano Ercolino, Il romanzo-saggio. Ma torniamo a una questione che, come avrai capito, mi sta molto a cuore: il meta-romanzo. Il pantarei appartiene di diritto a questa famiglia di testi, molto numerosa nel secondo Novecento, ma si inserisce bene anche in un’altra famiglia numerosa: quella del romanzo ambientato nel mondo editoriale, vero e proprio genere a sé, con una sua tradizione ormai consolidata. Mi sembra che questo filone sia tornato di moda, di recente, per ragioni forse anche ovvie (l’urgenza di riflettere sui meccanismi del mercato editoriale in una fase di transizione e di crisi); e mi sembra anche che stia soppiantando un altro filone che oggi gode di minor fortuna rispetto a qualche lustro fa: l’academic novel…
Ezio Sinigaglia
Quando cominciai a scrivere Il pantarèi avevo ventotto anni e da quattro anni collaboravo con varie case editrici. Avevo dunque un’esperienza ancora breve, ma tanto più interessante in quanto era di livello medio-basso. Non ero un collaboratore importante, ma un ragazzino cui venivano affidati testi da scrivere perché se la cavava bene. Testi da scrivere, e nient’altro: non traduzioni, o correzioni di bozze o simili (mansioni che mi piace attribuire ai protagonisti dei miei romanzi). Scrivevo testi per enciclopedie, e all’inizio per enciclopedie per ragazzi. Cominciai nel 1972, appena finito il servizio militare, in una piccola casa editrice, L’Esperto, del più giovane dei fratelli Mauri. Più un’agenzia editoriale che una casa editrice: vendeva opere progettate ma ancora da realizzare a editori stranieri. Ed erano opere, soprattutto grandi opere, per ragazzi. Avevo esperienza dei buffi rapporti che si creavano all’interno delle case editrici, soprattutto fra interni ed esterni. Naturalmente non avevo rapporti se non molto superficiali con gli editori, ma conoscevo i meccanismi psicologici che stavano alla base di quelle relazioni, nonché certi personaggi che gravitavano intorno alle case editrici. Devo però dire che Il pantarèi è ambientato in casa editrice solo nel prologo e nell’epilogo, con esclusione forse significativa di tutti i capitoli numerati, che sono invece ambientati, se così posso dire, nel Romanzo, inteso sia come quel romanzo, sia come genere letterario. La casa editrice affiora solo qua e là, nelle elucubrazioni di Stern, preoccupato di come saranno prese certe sue libertà (la soppressione di Thomas Mann, soprattutto, e dei sudamericani…), ma anche molto divertito dal – e orgoglioso del – fatto di essere ribelle e anticonformista. Ed affiora anche, un po’ stranamente, in una scena del lungo sogno che costituisce la parte narrativa del capitolo su Kafka: qui ricompare, inaspettatamente, la redattrice che gli ha affidato il lavoro. In pratica è solo il prologo a essere ambientato in casa editrice, perché l’epilogo è brevissimo e si svolge davanti alla casa editrice, nella quale Stern (che ha con sé la cartellina del suo lavoro finito) non si decide a entrare perché, proprio lì davanti, ha pestato una cacca di cane. Il prologo invece è lungo, di ampio respiro, ed è quello che marca il ritmo dei monologhi interiori in terza persona (destinata naturalmente a saltare spesso alla prima) che sono uno dei pochi fili conduttori stilistici dell’intero romanzo. Insomma, non lo definirei un romanzo ambientato nel mondo dell’editoria: è un romanzo fortemente radicato dentro il Romanzo.
Giuseppe Girimonti Greco
Stern è un personaggio vagamente beffardo, per certi versi, perché tende (compiacendosene e divertendosi) a fare delle scelte argomentative e redazionali abbastanza anticonformiste. Questo è un tratto del tuo protagonista che si coglie bene sin dall’inizio; anzi, mi sembra che questo ironico rovesciamento di alcuni luoghi comuni sul romanzo del Novecento sia un altro filo conduttore del libro…
Ezio Sinigaglia
Sì, è vero; c’è per esempio una specie di sfogo al quale Stern si abbandona mentre sta scrivendo il capitolo su Joyce, perché è esasperato dal numero enorme di opere che sono uscite (e siamo solo nella seconda metà degli anni Settanta!) per aiutare a leggere, o piuttosto a decifrare Joyce: le guide all’Ulisse. Ne ha una in mano e a un certo punto l’afferra ma, dice il testo, non ha l’alfieriano coraggio di gettare il libro dalla finestra: con quello che costano! Lo scaglia soltanto contro il muro, così da poterlo poi recuperare.
Giuseppe Girimonti Greco
Il gioco di Stern mi sembra particolarmente riuscito nel capitolo su Proust (là dove alla ineludibile madeleine si sostituiscono i lillà). Non c’è “tormentone” esegetico che non venga rovesciato o parodiato (quando non è scartato a monte). Mi sembra che il protagonista sia una proiezione dell’autore più in questo gioco che attraversa tutte le parti saggistiche che non nelle sezioni in cui lo vediamo vivere (le sezioni più propriamente narrative del libro).
Ezio Sinigaglia
Per la verità avevo subito avuto un’idea, che a me era sembrata molto semplice e perfino banale, ma che si dimostrò utilissima nella costruzione della parte saggistica. In pratica ogni parte saggistica vede Stern impegnato a scrivere, a macchina, il suo saggio su questo o quell’autore. Ma ogni tanto Stern interrompe la scrittura, che è riportata in corsivo, e ci sono righe in tondo in cui pensa. Questo mi offriva la possibilità di fare una specie di controcanto o di commento interno, dell’autore a sé stesso, con una conseguente moltiplicazione del gioco di sovrapposizione e sdoppiamento della figura dell’autore, del narratore o voce narrante, del protagonista in quanto autore del saggio, del protagonista in quanto ironico commentatore di sé stesso. Dunque: rapporto di derivazione di Stern dall’autore, cioè da me, e secondo rapporto di derivazione dello Stern commentatore dallo Stern autore. Così mi si offriva la possibilità di ironizzare sugli autori al di fuori di quel che viene scritto nel testo dove, per quanto ribelle possa essere, Stern deve comunque rispettare determinate convenzioni. A volte si ironizza anche sulla critica letteraria. C’è per esempio una specie di siparietto all’inizio del capitolo su Céline: Stern ha ormai esaurito gli autori per così dire obbligatori, i giganti della prima metà del Novecento (Proust, Joyce, Musil, Svevo e Kafka), a proposito dei quali scrive alcune azzardate semplificazioni. A questo punto si passa bruscamente dal corsivo al tondo, e si materializza un fantasma:
“Un accademico si levò in piedi proprio dirimpetto a Stern e la sua figura, benché gracile, si stagliò contro la luce della finestra con così solenne evidenza, che Stern e la sua olivetti se ne sentirono schiacciati.
– Io la condanno, Stern!
– Dio buono, a che cosa?
– All’abominio del rotocalco, all’abisso delle enciclopedie, al girone della flatulenza!
– Questa poi!
– Sì, flatulenza! Fra la Cultura e i suoi scritti passa la medesima differenza, ignobile Stern, che separa un buon pranzo da una scorreggia. Lei semplifica il Sapere fino a farne un fiato di gas puzzolente.”
Ecco, solo per dire che questo semplicissimo accorgimento del gioco corsivo/tondo, scrittura/pensiero (uno stratagemma da povero artigiano della penna, niente di più) mi ha consentito, anche al di là delle mie previsioni, un interessante gioco delle parti.
Giuseppe Girimonti Greco
Mi sembra che, sin dal tuo esordio, tu abbia messo al centro del tuo lavoro il problema del timbro della voce narrante: un problema (narratologico e stilistico) che ti ha portato a soluzioni particolarmente ardite e originali in Eclissi. Molti critici hanno sottolineato quanto siano raffinati, nella tua scrittura, la gestione del punto di vista e in particolare l’uso dell’indiretto libero. La questione è delicata: soprattutto in alcuni testi, si tratta, infatti, di modulare e gestire dal punto di vista tecnico la o le voci della narrazione, mettendo al tempo stesso il lettore in condizione di distinguere fra le voci dei personaggi e quella del narratore, senza che queste distinzioni condizionino troppo la lettura. È così?
Ezio Sinigaglia
Sì, io sono dell’idea che lo scrittore debba sperimentare moltissimo con tutte le tecniche narrative che ha a disposizione, e con la lingua, senza però che questo comporti una diminuzione del piacere della lettura o un aumento della difficoltà di lettura al di là di un certo limite. Il lettore deve fare secondo me un po’ di fatica, perché altrimenti diventa poco attento, poco ricettivo e qualsiasi cosa gli scivola addosso come acqua. Ma non bisogna costringerlo a una fatica eccessiva che gli tolga il piacere di leggere. Tutte le tecniche cui si ricorre devono quindi essere non dico mascherate, ma in qualche modo piegate alla loro funzione nella narrazione. Non ci deve essere mai da parte del lettore la sensazione che l’autore, se così posso esprimermi, si dia delle arie; il lettore non deve mai formulare il pensiero: “Ah, ecco, questo adesso sta facendo lo scrittore, ci sta spiegando come si fa l’indiretto libero”. L’indiretto libero, nella letteratura moderna, è diventato diverso da ciò che era prima, da Flaubert in poi, e in particolare da Madame Bovary in poi…
Giuseppe Girimonti Greco
Madame Bovary è un classico che si legge, anche in originale, con estrema facilità, oltre che con estremo piacere. Nella letteratura italiana contemporanea secondo me la questione si pone in modo particolarmente spinoso: l’indiretto libero non è mai di facile gestione, e spesso diventa il banco di prova della perizia dell’autore. C’è anche da dire che sempre più (perlomeno nelle letterature che conosco meglio: italiana e francese) si va ampliando il divario fra autori più attenti alla storia e autori più attenti alla lingua e allo stile…
Ezio Sinigaglia
Direi che si può prendere proprio Madame Bovary come punto di equilibrio perfetto fra queste due categorie di scrittori, gli “affabulatori” e gli “stilisti”. Flaubert è un perfetto esempio di stilista/narratore: un grande stilista e un grande narratore insieme. Nonostante tutta la mia passione per il romanzo del Novecento e per Proust e Joyce in special modo, se qualcuno mi chiedesse quale romanzo vorrei aver scritto, risponderei senza la minima esitazione: Madame Bovary. È una storia che tiene il lettore interessato e appassionato dal principio alla fine e nello stesso tempo è scritta in una lingua perfetta e di fortissima personalità. Ecco, questo per me è il punto d’arrivo, il traguardo cui bisogna aspirare: fare tutte le sperimentazioni possibili, piegare la lingua a tutte le necessità del momento e dell’occasione, ma senza nessuna forzatura.
Giuseppe Girimonti Greco
Di recente, e in modo del tutto inatteso, Michele Mari – in un’intervista, mi pare – ha detto qualcosa di simile: che il lettore non deve essere sadicamente ostacolato dallo scrittore, né privato del piacere della lettura… il che ha sorpreso alcuni suoi critici e alcuni suoi lettori forse ormai troppo assuefatti alla dicotomia stilista versus non-stilista su cui ci siamo soffermati prima. Ma in realtà Mari non è affatto uno “stilista puro”; è un abile inventore di storie, oltre che un grande appassionato di letteratura fantastica, gotica, etc.
Ezio Sinigaglia
Ha anche tradotto un capolavoro di Jack London, narratore-affabulatore per eccellenza (Il richiamo della foresta). In effetti questa dicotomia sembra anche a me molto discutibile e comunque piena di eccezioni. Un esempio opposto a quello di Mari potrebbe essere Edgardo Franzosini, un autore che – al contrario – è assegnato d’ufficio alla categoria dei narratori puri, sempre aderenti alle res, che nel suo caso sono res “non d’invenzione”. Ebbene, in realtà Franzosini è un autore che ha saputo costruirsi una lingua tutt’altro che neutra, sempre molto funzionale – è vero – e sempre al servizio della narrazione, ma anche fantasiosa e a tratti sorprendente: basti pensare alle note in calce, del tutto inattese e stranianti, che punteggiano uno dei suoi libri più belli, Il mangiatore di carta, nella nuova edizione di Sellerio. O alla presenza inquietante, sempre nel Mangiatore, di Balzac, un fantasma allusivo che sembra ricordare al lettore come questa “storia vera” appartenga in realtà al mondo della letteratura.
Giuseppe Girimonti Greco
Su Franzosini sono pienamente d’accordo. E per certi versi i suoi testi, così originali e spregiudicatamente ibridi, sono un buon modello di non-fictional literature alternativa a certa NFL che, a mio avviso, sta tragicamente scadendo nell’abisso del mainstream. Per finire, vorrei parlare brevemente di un altro tuo testo molto insolito che sarà pubblicato – se ho ben capito sempre nel 2019 – dallo stesso editore, TerraRossa, che si appresta a riproporre Il pantarèi. Si tratta di una novella lunga, di un centinaio di pagine, intitolata L’imitazion del vero. Cominciamo proprio da qui: perché questo titolo?
Ezio Sinigaglia
Il titolo ha sicuramente più di un significato. Diciamo che ne ha due, per semplificare, ma in realtà gliene si potrebbe attribuire anche qualcuno di più. Al centro della novella, ambientata in un’epoca imprecisata, forse all’inizio dell’età moderna, c’è un falegname-inventore, Mastro Landone, che è un abilissimo costruttore di macchine. Fin dalla prima pagina si precisa che alcune di queste macchine “mandavano fumo, altre […] producevan rumori come di cavalli al galoppo, altre ancora […] facevano apparir sul soffitto tutto il cielo stellato”. Ecco dunque uno dei significati dell’espressione “imitazion del vero”: macchine o automi che riproducono taluni aspetti della realtà hanno un ruolo determinante nella storia. Alla fine il talento di Mastro Landone si spingerà molto più avanti sulla strada dell’imitazione di ciò che è vero, di ciò che esiste in natura. Nella parte centrale invece sarà piuttosto il vero, il naturale a imitare il finto, a imitare un automa. Qui il titolo diviene ironico e paradossale, in quanto allude a un capovolgimento di cui soltanto il protagonista e il lettore hanno consapevolezza. L’altro significato nascosto nel titolo è – se vogliamo definirlo così – meta-letterario e allude alla novella stessa, che è scritta in un italiano “anticato”, un italiano che si può presumere risalga a un’epoca molto remota, ma che resta vaga. La mia novella, dunque, finge di essere una vera novella (licenziosa, dimenticavo di dirlo) della tradizione italiana, una tradizione, com’è noto, prodigiosamente ricca di testi novellistici; e invece è una sperimentazione letteraria fatta “a modo mio” (tra l’altro, anche un po’ spregiudicata per via del tema omoerotico), scritta una trentina d’anni fa…
Giuseppe Girimonti Greco
Scritta una trentina d’anni fa, è vero, ma il suo tema centrale mi sembra di grande attualità. Senza svelare troppo dell’intreccio (che ha qualcosa di surreale e fantasmagorico, pur partendo da premesse boccacciane), vorrei aggiungere almeno questo: la tua novella mette in scena un erotismo morboso e prevalentemente virtuale. Un tema che appartiene alla contemporaneità…
Ezio Sinigaglia
In effetti, nel 1988, quando concepii questa storia, che portai a termine l’anno seguente, Internet non esisteva ancora, almeno per noi comuni mortali. E non esistevano neppure i cellulari. Tuttavia, sulla difficoltà di praticare un erotismo libero e liberatorio, gioioso e senza colpa, avevo fatto ormai quasi tutte le prove possibili: nel 1988 avevo quarant’anni.
***
L’incipit de L’imitazion del vero.

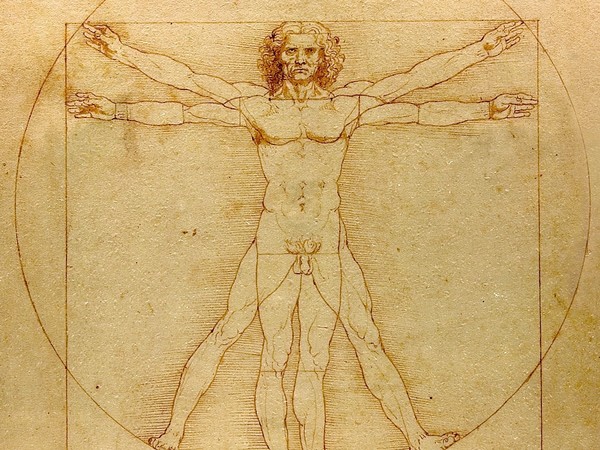


Ho seguito con interesse l’intervista. Che mi ha restituito un’immagine ben più corposa di Ezio Sinigaglia, autore e storico, in limine estremo, di quell’età dei grandi dello sperimentalismo senza aggettivi che hanno segnato il secolo della “fine del romanzo”. Attendo la pubblicazione di Pantarei per meglio seguire il sentiero, qui spesso ricordato, del filo senza colori della letteratura “ribelle e inquieta”, da Flaubert a Joyce e Svevo, da Proust a Kafka e Celine. Ci si ferma a metà Novecento. Fuori gioco e tempo quindi – purtroppo – il Don De Lillo di Underworld, là dove la realtà è solo atono sguardo e insieme specchio profetico del nostro disorientato presente.