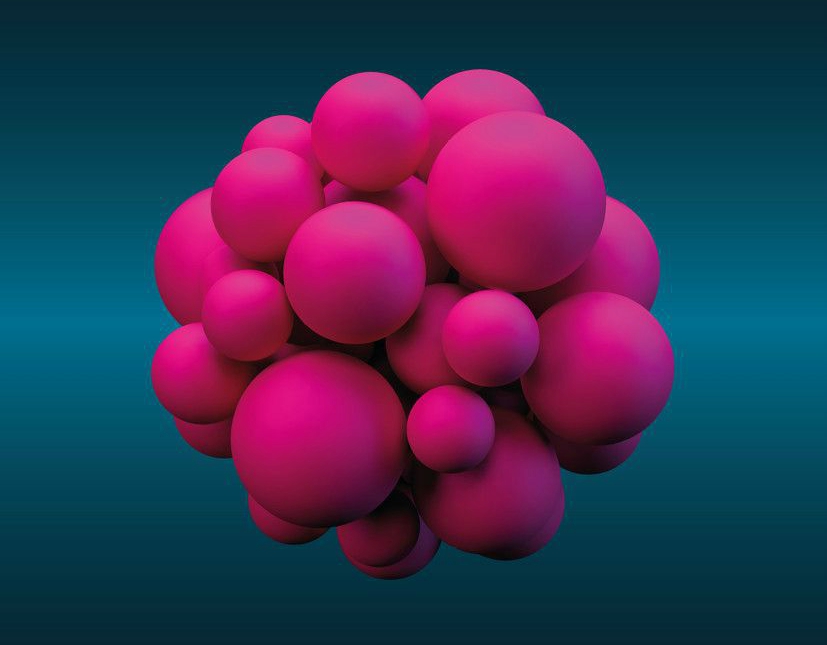La vita va avanti quando qualcuno ti aspetta, e il resto non è altro che sopravvivenza.
La cattiva luce è la fedelissima messa in scena di un pantano. Dei momenti in cui la vita ci passa accanto mentre noi stiamo raggomitolati dentro noi stessi. Di una perdita che scava in noi fino a diventare una voragine che divora ogni cosa per risputarci addosso un vuoto. Di un’identità che si afferma attraverso la sua negazione, riconoscendosi solo in ciò che ha perso e in ciò che gli manca.
Il protagonista del romanzo di Carlos Castán affronta una crisi sentimentale che diventa esistenziale, e che dà il via a un’infelicità costruita giorno dopo giorno, coltivata con cura, patologica; un vuoto che si allarga e si fa sempre più denso, vischioso, e capace di far annegare nell’indifferenza tradimenti e omicidi.
Al giorno d’oggi l’anziano che muore non lascia un mondo al galoppo pieno di progetti e promesse, come succedeva un tempo, ma più che altro una valle di lacrime. Alla fine questa sgradevole circostanza per lo meno ci ricambia con una piacevole contropartita: è meno difficile abbandonare un paesaggio desolato rispetto a uno pieno di quegli uccelli che secondo Juan Ramón avrebbero continuato a cantare. Ciò che rimane ora, aldilà della terra che copre la sepoltura, è una infinita domenica pomeriggio, una nebbia di noia e di sconfitta. Ed è più facile andarsene così, perché niente culla bene quanto la stanchezza. Non ci vuole molto a lasciare una festa quando ormai non ci sono più ragazze, né bibite, musiche o energie.
A guardarsi dentro si diventa ciechi, recita un adagio; e questo è ancora più vero quando gli occhi sono chiusi e non c’è niente da guardare, tutto è rivolto verso una sofferenza che si autoalimenta compiaciuta di sé, che si anestetizza contro tutto ciò che la circonda impedendo al dolore di sfogarsi, accudendo con ferocia chi la subisce e la alimenta.
Quella che Castán ci mostra è una sofferenza che non trova valvola di sfogo perché è intellettualizzata, scomposta in miriadi di dolori minimi che si richiamano l’uno con l’altro, si ramificano e si rafforzano, diventano stile di vita. Le parole non sono nemmeno strumento di analisi, ma si limitano a circoscrivere uno stato immobile, inamovibile, mortifero, rigirandosi in loro stesse, perdendo progressivamente contatto con ciò che vorrebbero esprimere, limitandosi ad accarezzarne la superficie ma senza soffermarvisi.
La morte non è nient’altro – come tutto il resto – che un affare da vivi.
La cattiva luce è una sfumatura plumbea che toglie aria al cambiamento, soffoca ogni prospettiva e tronca ogni slancio sul nascere, nel suo formarsi, restituendo al mondo uno sguardo sempre più cupo, sempre più depresso, affaticato dal vivere, immobile. Allora l’unico slancio consiste nel dare la morte, e non per giustizia, o vendetta, ma semplicemente per ricomporre l’oleosa ignavia dell’esistere, affinché la giustizia faccia il suo corso, ma senza aneliti, senza entusiasmo.
Non rimane che concentrarsi, ancora una volta, su quello che si è perso, che manca, che non è accaduto e che un giorno accadrà. E che verrà risucchiato nello stesso niente in cui finisce tutto.
Carlos Castán
La cattiva luce (2013)
Trad. it. Federico Di Vita
San Gavino Monreale (VS), Egg edizioni, 2015
pp. 184