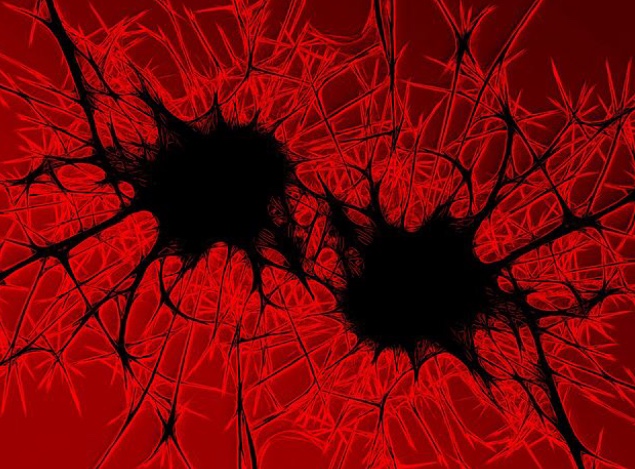La festa d’addio era da poco finita, gli invitati se ne erano andati lasciando sparsi per il salotto pezzi di torta mangiucchiata. Il substrato di luciferina faceva ancora brillare i caratteri dello striscione biologico: ‘Buon viaggio Matilde’.
Matilde abbracciò la madre e baciò il padre, li salutò per sempre.
L’uomo strinse la moglie a sé: erano orgogliosi che si sacrificasse in nome dei valori etici, morali e umanitari che con tanta dedizione e senso civico le avevano instillato.
Le operaie si calavano a balzi, come una cordata di alpiniste scivolavano lungo le pendici della madre colossale. Le funi erano ancorate al setto nasale, in un’apertura che univa le froge gigantesche: pareva di essere in una moschea d’acciaio.
Strette nelle loro salopette blu le ronzavano intorno come tafani, chi intenta a lucidare i tasselli della zip che da un capo all’altro della bocca si estendeva per sei metri, chi a saldare gli ultimi dettagli. Altre, in pausa pranzo, si gustavano panini di kamut e pomodoro sedute sul bordo dell’ombelico con le gambe penzoloni nel vuoto.
Alta quanto un piccolo grattacielo, diecimila tonnellate di metallo, la statua della Grande Madre si ergeva dai Piani di Pezza dominando le vallate circostanti. Quel luogo era stato scelto perché la Natura è donna, con le sue colline, le pianure e le montagne.
La Grande Madre aveva il ventre gonfio di adipe di ferro e i seni lucenti in titanio che quasi toccavano terra, perché le figlie sono stufe dagli ideali di bellezza fallo-imposti/magro-cratici.
Estrogeni in nichel trasudavano da pori temprati in fornaci sospese su Marte. La pelle verdognola, poi, era ricavata dalla fusione di cazzi di bronzo staccati da antiche statue di condottieri su cavalli rampanti (anch’essi naturalmente maschi).
La Grande Madre, primordiale e ultramoderna, sembrava un mastodontico Buddha con la fica e la tuta in latex. Niente occhi per non piangere, perché le figlie sono stufe di versare lacrime, niente curve al posto giusto perché le figlie sono stufe di essere corpi, di essere deboli, le figlie non vogliono più provare dolore, le figlie vogliono essere forti.
Il tubo ficcatole in bocca usciva dalla zip aperta per nutrire la grande incubatrice che come la conchiglia di Venere la faceva nascere rampante dalle viscere della lotta dei sessi. Altri due tubi, attaccati ai capezzoli da mungitrice meccanica, calavano tortuosi al basamento per spremere nutrimento a generazioni di non partoriti, di vivi senza essere nati.
La grande incubatrice, utero in nanotubi mucosali, sacchi amniotici ripieni di aerogel, placenta in spuma di alluminio. La Grande Madre aveva reso la donna finalmente libera e superiore all’uomo. Ma i maschi non l’accettavano e il numero di femminicidi era salito drasticamente.
Le scale non si vedevano, stavano dietro, dal basamento salivano a zig-zag lungo la schiena della statua. In quaranta minuti di buon passo si giungeva in cima, sul capo della Madre, e da lì ci si poteva godere l’ultimo sterminato panorama.
La fila per arrampicarsi iniziava da molto lontano, le donne aspettavano il loro turno scambiandosi baci e carezze.
La soubrette venne trascinata in mezzo, tirata per le catene. Doveva essere punita. Durante il suo programma aveva osato elencare in diretta nazionale i motivi per cui le sex-dolls dotate di autocoscienza erano mogli più calde delle donne in carne e ossa (non che le bambole non fossero di carne e ossa).
Loro non erano luoghi comuni, erano persone. Nessuno doveva permettersi di disegnare linee-di-comportamento-generale, o analizzare-profili-statistici, o peggio trarre-conclusioni-di-genere-basandosi-su-andamenti-di-mercato. Erano donne, non numeri.
Una Figlia le ficcò due dita in gola facendole vomitare il liofilizzato di mela con cui l’avevano ingozzata qualche minuto prima.
«Noi non partoriremo con dolore!» urlò un’altra.
Era scattata l’ora. La prima figlia si lanciò. Fluttuò per qualche metro rivoltandosi nell’aria come un aereo di carta sciancato. Il collo le si spezzò contro la pancia metallica proprio sopra l’ombelico della statua, poi scivolò e continuò a cadere fino a spiaccicarsi al suolo. Un rivolo di sangue colava a terra come una leggera pioggerella rossa, il terriccio non fece in tempo a assorbirlo che già un’altra Figlia si era tuffata.
Così si puniva il mondo, così gli uomini avrebbero sentito la loro mancanza.
Matilde respirava forte. La mano al petto che stringeva l’altra. Di lì a qualche ora avrebbe spiccato il volo anche lei.