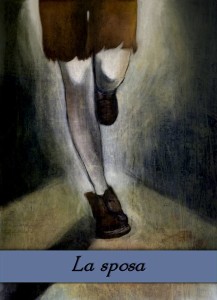«Uagliù, inizia a fare buio» disse Giannino Mezzarecchia «torniamo a casa, altrimenti sono mazzate».
Lo guardai di sguincio, piegato dentro dal ricordo della cruda cinghia, quella vecchia di cuoio consumato che il Nonno, uomo austero ma giusto, ligio a poche leggi ataviche, teneva solo per noi. «Allora? Ce ne andiamo o no?» continuò Giannino.
Tutti abbassarono la testa, imitando il sole appena fuggito, lontano, dietro i colli sconosciuti. Un giorno li avremmo vissuti, quei colli, ma fuori tempo massimo, ormai: chi ansioso di rinascere, chi solcato dalla vita, nessuno di noi li avrebbe mai goduti come promesso, da sempre, nei nostri sogni ad alta voce.
Giannino mi diede un buffetto alla nuca ed io, d’istinto, strinsi al grembo il mio pallone di pezza.
«Jamm’?»
Fui l’ultimo a piegare la testa. Davanti a me, gli altri, a turno, svanivano ripiegando nelle loro strade. Al mio fianco, Giannino, solo, respirava. Poi c’era il vento; il tremore delle braccia nude, e delle cosce, una sensazione quasi di languore. Noi, intanto, tornavamo abbrutiti da quella fatica troppo giovane che, impreveduta, ti risucchia dal midollo.
Erano giorni che il cielo, pesante come un tronco, ci gravava sullo scalpo. Il freddo, improvviso e pungente, anchilosava tutti in paese, e le bestie tacevano più degli uomini. Io e Giannino non scendevamo mai al borgo, tranne che per fare commissioni o improvvisare fantastiche avventure con gli altri. Arrivarci era già una bella avventura, a dirla tutta. C’erano più pietre che cristiani, e quei pochi, grigiastri e smunti, si confondevano tra le casette tutte uguali, tra le botteghe polverose. Dalla chiesetta, i lamenti scandivano ogni funzione liturgica. Era, quella, l’unica parte del paese che sembrava vivere; teli e drappi rossi e viola decoravano la facciata, e la grande porta di ferro restava sempre aperta, notte e giorno, per accogliere i bisognosi, così diceva il prete. Ma si sapeva che al borgo nessuno veniva, nessuno riusciva ad andarsene. La vera guerra era ora e si riversava sui sopravvissuti, come diceva il Nonno. I morti rapirono il sole, per questo il paese, una volta esposto ai raggi, era come spento e cupo. E ad una certa ora, preferivo fuggire via da lì, senza darlo a vedere agli altri, per non essere preso in giro.
Noi tutti subivamo la disfatta del tempo, unico viandante, tediato e afflitto, che girovagava per i viottoli ciottolosi. Così i giovani sarebbero stati sconfitti da sogni mai realizzati, i vecchi sempre più vinti da una senilità che paralizzava mente e corpo.
Solo io e Giannino abitavamo nello stesso porticato, uno accanto all’altro.
Si raccontava che fosse figlio del vento. Non era uno di noi perché lui, un giorno, spuntò così, all’improvviso, come un fungo cattivo. Non ho mai saputo da dove sia venuto, né il perché. Una mattina, quando l’aria era più leggera, uscii per raccogliere l’acqua nel pozzo. Lui era proprio lì, al lato della tinozza, scalzo, che mi osservava con occhi vispi e curiosi. Era sporco di fango in viso, chissà come mai, e puzzava come quando Ciccio si rotola nel terriccio, e poi piove, e la sua pelle di spinone trasuda di tempeste chiuse. Io, allora, feci l’unica cosa giusta: gli buttai una secchiata d’acqua gelida con l’illusione di vederlo svanire, come un verme rinsecchito, tra i molteplici rivoli pronti a solcare la terra, e di vederlo riapparire, infine, lindo come la gente onesta della domenica mattina. Lui però non seguì la via dell’acqua. Disse solo «So’ Giannino!».
Poi ci picchiammo, e ci assaggiammo tra i morsi – aveva il sapore delle more verdi, quelle che nessuno mangia perché acerbe e discrete come i bambini nei conventi – e ci dichiarammo amici. Finalmente non ero più solo, ero stufo di parlare con le bambole stupide di Annarella, da un pezzo.
Non ho mai capito perché gli altri lo chiamavano “mezzarecchia”; le orecchie erano tutte e due intere, perfettamente simmetriche, insomma normali. Le fissavo, mentre eravamo al centro della nostra strada.
«Che mi guardi?» Giannino chiese, irritato.
«Niente, pensavo che fa proprio freddo» arrossii, e la luce fioca dei lampioni che ci accompagnavano, lungo i margini, a schiere rade, un po’ riuscì a velare il mio imbarazzo. Ma non mi bastava.
Per strada mi sentivo angustiato, era da giorni che avevo dei grovigli nella testa, inestricabili come rovi, ognuno, a suo modo, appuntito. Mi accorsi che le scarpe mi stavano strette, eppure l’altro giorno erano comode… “è proprio strano addormentarsi piccolo e svegliarsi grande”, pensai. Ma non potevo crescere proprio allora, dovevo accontentarmi di quelle chissà ancora per quanto tempo, perché “senza sord’ nun se canten’ ‘e mess’”, diceva Nonno, e quando il Nonno diceva qualcosa, noi dovevamo ammutolire e approvare. Per fortuna in inverno sarebbe stato più facile rannicchiare il piede, giacché sarebbe stato sempre rattrappito dal gelo.
Giannino non se la passava meglio: lui non poteva mostrare la sua spensierata felicità di quegli anni crudeli, il suo sorriso era bucato dalla carie e se ne vergognava molto, ci soffriva a portare sempre una mano alla bocca quando le risate, da dentro, lo squassavano. Proprio lui che l’acqua la vedeva poco e non poteva, come i gatti, leccarsi lo sporco dalle dita. È che ognuno ha il suo pudore, e quello di Giannino, vestito di stracci unti e di terra sedimentata sulla pelle scura, era confitto nei denti.
«Domani mi tocca» mi disse, sfinito, come se lo stesse pensando da tempo.
«Cosa?»
«Spalare la merda delle vacche».
«Di nuovo? Ma non era il turno di Mino?»
«Che ci vuoi fare uagliò, je so’ gruoss, e po’ chi arriva per ultimo nella masseria…»
Giannino aveva qualche anno in più di me, ma non sapeva né leggere né scrivere. Mi chiedeva sempre di raccontargli una storia – diceva che io sapevo sognare – o di leggergli David Copperfield, il suo primo regalo rubato, proprio per me, su una bancarella durante la processione di san Cosma e Damiano. Sapeva che mi piaceva leggere ma non potevo permettermi di studiare ancora, dopo la licenza elementare; a quei tempi, dopo la guerra, anche la quinta era per pochi. Ero fortunato.
«Continua a leggere, io non mi addormento mica» incalzava, mentre a me il fiato mancava eccome, dopo ore e ore di lettura. Allora, quando ero sul punto di cedere, mi tirava un calcio sul polpaccio per obbligarmi a proseguire, ed io sbuffavo, e gli urlavo dietro che era un grosso asino dalle orecchie lunghe e che non c’era bisogno di andare a scuola per imparare, non era necessario che un grande glielo insegnasse. Potevo farlo io.
La verità è che Giannino del protagonista del libro se ne fregava ben poco, a lui interessava solo una minima parte; di certo a saperlo prima tanto fiato non lo sprecavo. Era questa qui: “Morendo, ella era tornata alla calma serena della sua giovinezza, cancellando tutto il resto. La madre ch’era sepolta nel cimitero accanto alla casa, era la madre della mia infanzia; la piccola creatura tra le sue braccia, ero io stesso, com’ero stato un tempo, unito a lei nella sua pace, per sempre”.
Quando la leggevo, lui taceva, prendeva un forte respiro e socchiudeva dolce le palpebre; forse finalmente fantasticava. L’ho sempre immaginato buio, senza sogni dentro.
Una volta, era un pomeriggio afoso, mentre innaffiavamo i pomodori, prese un legnetto storpio e disegnò nel terreno umido una casetta senza porte né finestre, un bambino con due teste e un corpo sottile come un fuscello, senza braccia.
«Giannì, carino ‘sto mostriciattolo, ti somiglia quasi» e divertito presi a schernirlo, spingendolo nell’erbaccia irta, quella che prima ti fa il solletico e poi ti fa venire il prurito forte.
Quella volta, però, Giannino non sorrise per niente.
Ricordo ancora il suo sguardo dilatarsi come se avesse visto un fantasma, gli occhi verdi quasi sbiadirsi, raggelarsi e perdere pian piano luce.
Lasciandosi strattonare, sbiascicò qualcosa: era più un suono mutilato che una parola.
Intanto che ci allontanavamo dal piccolo centro abitato, le nostre anime venivano inghiottite dall’oscurità del sentiero sterrato. I pini maestosi ed alteri ci osservavano, i rami oscillando nel vento sembravano afferrarci da dietro. Non c’erano altre strade da prendere o ulteriori svincoli, il percorso s’era fatto lineare e portava dritto all’origine della mia vita, lì nei campi. Insomma, era impossibile perdersi. Ma poteva essere pericoloso, ultimamente si sentiva sempre più parlare di strane creature che si aggiravano per il boschetto, mimetizzate tra il muschio e il fogliame, che avevano occhi rossi per ipnotizzare. Giannino ci rideva su e poi diceva che la noia del gregge è alquanto buffa ma fatale perché può distogliere il pastore e fargli vedere le cose che non esistono, distrarlo lungo il suo cammino e farlo cadere nelle trappole per i lupi, ad esempio.
«Guarda con la capa tua, non con quella degli altri» mi suggeriva «e poi, basta una pecora che bela e tutte le altre la seguono» continuava.
Nel frattempo, mentre mi giravo di scatto per essere sicuro che nessuno ci seguisse, inciampai in un fosso e caddi come un salame in una pozzanghera.
«Ha-ha-ha, sei un cacasotto! Ha-ha-ha», Giannino se la rideva cattivo e saltellava intorno come un grillo fastidioso e rachitico.
«È tutta colpa tua, ti avevo detto di andarcene prima, è già notte e qui non c’è luce» piagnucolai.
«No, sei tu che prima continuavi a fare lo scemo con Peppe. La prossima volta t’impari. Io non ce lo voglio a giocare con noi altri, chi lo conosce a questo, non mi piace! Non mi piace!»
«Smettila! Aiutami, ho freddo!»
Non se lo fece ripetere due volte, mi sollevò subito da terra, e mi poggiò sulle spalle il suo maglioncino rattrappito. Mi accorsi per la prima volta che era molto più alto di me e che le sue mani erano già da uomo. Se avesse voluto poteva davvero picchiarmi e farmi male. Ebbi un attimo di timore e indietreggiai.
Giannino mi guardò fisso negli occhi, come se volesse leggere cosa stessi pensando.
Poi accennò un caldo sorriso e mi diede un buffetto sul volto. In quell’istante ogni cosa svanì: la paura delle ombre, il dolore al ginocchio per la caduta, e l’inquietudine interiore che, quella sera, continuava a soggiogarmi.
Mi sentii infinitamente bene, al sicuro.
«Andiamo, dai» disse «facciamo così: cammina avanti tu, e io sto dietro e ti guardo le spalle, tanto manca poco».
Stavamo per attraversare il ponticello, intravedevo già le luci di casa, quando il gracidio stridulo di una cornacchia mi fece sobbalzare nuovamente. Mi bloccai, abbassai lo sguardo e vidi le mani di Giannino cingermi la vita, stringendomi a sé sempre più forte. Avvertivo il suo respiro umido e affannoso sul collo nudo. Poi sentii la sua bocca, quasi impercettibile, sfiorarmi la nuca.
Divenni marmo, col groppo in gola, duro come una biglia, che non scendeva.
Così come la cornacchia preannunciò, il peggio non tardò ad arrivare.
In lontananza le urla del Nonno ci riportarono alla realtà. Agitava le mani e ci intimava di correre, di raggiungere subito la masseria. Allarmati e col fiato mozzo, arrivammo in breve tempo nel porticato.
«’U No’, cosa è successo?»
«Annarella… Annare…» s’interrompeva e piangeva e si prendeva a schiaffi in faccia da solo. Mentre Giannino cercava di abbracciare il Nonno e consolarlo, io spalancai il portoncino, attraversai il tinello rovesciando tutto per terra e, con un tonfo, entrai in camera da letto.
Non vedevo niente, un muro nero di gente la proteggeva. Spinsi qualcuno e mi si aprì un varco, lei era lì. Annarella, vestita di bianco come una sposa morente, giaceva supina e rigida sul letto di paglia, gli occhi sbarrati volti al soffitto.
Gialla in viso, con la bocca serrata, teneva i pugnetti stretti e lividi, proprio come quando si arrabbiava, e scalciava, e liberava urla verso l’alto dei cieli silenziosi. Il sudore le incorniciava il faccino, e i suoi capelli lunghi e folti, di solito sciolti e liberi come i cavalli sulle colline, erano stati legati da qualcuno in una lunga e brutta treccia, così simile a una vipera.
«Annarè… Anna! Anna!»
Continuavo a ripetere il suo nome, e intanto con un pizzico le stritolavo la tenera bianca carne del braccino: avrei voluto trasmetterle la mia vita e morire io per lei.
«Che è succies’? Che è succies’? Ricit’! Che è succies’!»
Piangevo e urlavo, nel mio dialetto più aspro, stretto com’ero in quella calca di gufi e civette. Alla fine, senza più controllo, presi per il bavero il padrone della masseria e lo scossi talmente forte che insieme cademmo a terra.
«Ha le febbri forti… non mangia e non beve più…» disse lui, agitato.
«’U dottor’! Chiammate ‘u dottor’! Muvitev’!»
Scivolai miserabilmente in ginocchio, gli abbracciai le gambe e, a capo chino, emisi un rantolo straziante.
Nessuno fece nulla. Una moltitudine di macchie nere, alcuni con il crocifisso in petto e altri tra le mani, pregavano silenziosamente Dio e i santi affinché accogliessero la mia Annarella in luoghi migliori.
Don Antonio mi carezzò i capelli sporchi e disse:
«Caro ragazzo, stiamo facendo il possibile, non ci resta che aspettare. Il dottore è stato già avvisato, Mino ha preso il cavallo per fare prima, quello più veloce che abbiamo per la nostra Annarella. Ora possiamo solo pregare. Caro ragazzo mio, tu credi in qualcosa?»
Il mio pianto s’interruppe.
Lo guardai stranito, non sapevo che rispondere. Non mi ero mai posto prima questa domanda.
Tacevo imbarazzato e impietrito.
«Don Antò, secondo voi le preghiere degli uomini importanti salvano i poveri cristi?» disse Giannino, con aria di sfida, dall’uscio della porta. Teneva sottobraccio il povero Nonno piegato in due dal dolore.
«Mezzarè, stai sempre in tredici, queste non sono cose che ti riguardano. È il uaglionciello che mi deve rispondere, vai a prendere la legna tu, muoviti!» sbraitò il prete, e avanzando gli diede uno sganascione.
La gente continuava a recitare preghiere, come se tutto quanto stava accadendo fosse stata la cosa più naturale del mondo.
Giannino, imperterrito, con la chiazza rossa dipinta sulla guancia, disse con piglio fermo e autoritario:
«Nossignore, io non mi muovo di qua. Voi pregate pure le vostre statuette ridicole, io vado a prendere il catino con l’acqua fredda e le pezze. Nonno, tu vai a fare l’acqua di riso. ‘Sta piccerella se deve morire, lo farà con la pancia piena».
«Noi due facciamo i conti dopo, quando tutta questa storia sarà finita, in un modo o nell’altro. Mezzarè, nun te scurdà, io ti tengo puntato» gli sussurrò nell’orecchio Don Antonio e, sputandogli sui piedi, uscì di scena. Lo seguì devoto tutto il gregge del paese, in un brusìo di santi e madonne in latino.
«Cammina, vai a prendere le coperte, tu. Non stare impalato, datti da fare. Tanto di Mino ci si può fidare» mi spinse verso il corridoio, dove stava il grande armadio di legno di noce.
Avvolsi Annarella come una crisalide in un bozzolo, le tenevo in mano i piedini e soffiavo per riscaldarli, glieli baciavo anche. Ormai non tremava più, era un pezzo di ghiaccio che mai si sarebbe sciolto. Avrei dato dieci anni della mia vita per lei, che dico: avrei dato la mia vita stessa e oltre. Non era più cosciente quando Giannino le mise in fronte e nelle giunture gli impacchi freddi per farle scendere la febbre, strofinandola con precisione e dolcezza, come avrebbe fatto nostra madre. Poi arrivò il Nonno con l’acqua di riso. Provammo ad aprirle la bocca ma niente, l’acqua sgorgava dai lati, bagnandole il collo e le lenzuola.
«Venite dottò, sta là, oggi pomeriggio è svenuta e non si muove più, poi è salita la febbre alta» era la voce di Mino.
«Spostatevi voi, su» disse il dottore.
La spogliò e la visitò accuratamente: occhi, orecchie, spalle e toccò per molto tempo l’addome gonfio e contratto.
«Dottore, allora? Fate qualcosa!» disse Giannino con ancora le pezze in mano. Il Nonno si era ormai rassegnato.
«Pregate» disse l’uomo di scienze, riponendo gli strumenti e richiudendo la borsa.
«Io qui non posso far proprio nulla, chiamate un prete. È molto grave, è piccola e debilitata ‘sta creatura, forse se presa in tempo… ma ora è troppo tardi».
Giannino diede un calcio alla porta e iniziò a bestemmiare, il Nonno, invece, le baciava le manine violacee.
Mi sembrava di impazzire, era un incubo, la realtà lo è.
«No!» urlai. Poi sbattei la porta e corsi a perdifiato giù, oltre il porticato, nell’erba.
Non c’era una stella sopra la mia testa da ragazzino, avrebbe piovuto a breve. Sera d’ottobre come inverno inoltrato. Pensai al fatto che stavo crescendo, che non ci potevo far niente, che le cose cambiano. “Forse è meglio così” mi dicevo “meglio che Annarella muoia adesso, su quel letto di paglia, così non vede le cose brutte intorno”. Pensavo alla guerra, ancora troppo vicina, che aveva cambiato tanto e ci aveva fatto crescere prima. Ma Annarella no, non l’aveva mai capita la guerra, era troppo piccola, più piccola delle bambole. Era anche lei una bambolina, mia, del Nonno, e pure un po’ di Giannino.
Disperavo, ma senza più lacrime. Finché una luce fioca, all’angolo del muro, attirò la mia attenzione. A passi lenti, mi avvicinai a quella che era un’insenatura minuta lungo il porticato. C’era un quadretto, in alto, con tre lumini accesi, forse erano state le vecchie a metterlo lì. Mi inquietava.
Erano san Cosma e Damiano, proprio i santi patroni del paesello.
Erano stati medici, almeno il Nonno così mi disse, una volta.
Osservandoli bisbigliai cose strane, mai pensate, mai dette:
«Il potere degli uomini importanti sta nel costruirsi, a loro immagine e somiglianza, il proprio sfacelo. Ma una preghiera di un povero diavolo per una vita innocente quanto peso ha nel mondo?»
Mi voltai e mi sembrò di vedere mia madre camminare verso il pozzo.
Gridai: «Mamma!»
Poi mi girò la testa, non mangiavo dall’altra sera.
Crollai.
Fui svegliato dopo qualche ora da Giannino. Gli potevo vedere le carie: farfugliava, rideva e non si copriva i denti. Io non capivo, stordito com’ero dal digiuno e da tutto il resto.
«Annarella, Annarella! Annarella mangia! E beve!»
«Che dici Giannì? Sei matto? Lasciami stare per favore» lo allontanai col braccio.
«No, è vero! È vero!»
Lo guardai serio, non scherzava, non avrebbe mai scherzato su una cosa del genere. E io non stavo sognando, sentivo i morsi della fame provenire dallo stomaco.
Corsi dentro col cuore in gola, trovai la piccola sposa di Dio seduta sul letto che ingoiava l’acqua di riso. Era ancora un po’ pallida ma viva, le guanciotte rosee e le manine calde. Toccai la fronte, la febbre era scesa. Mi guardò, non riusciva ancora a parlare, ma i suoi occhi mi dissero grazie. Io non avevo fatto nulla.
Mio Nonno asserì che era stato un miracolo.
«Solo una grazia dall’alto poteva fare tanto» e puntava il dito al cielo, «il Signore ha voluto che la mia sposa vivesse ancora», così farneticò, anche lui stremato.
Scesi di nuovo giù, davanti ai due santi, mi inginocchiai e urlai:
«Quanto è fortunato l’uomo che nulla possiede perché quando qualcosa giungerà ne saprà riconoscere il giusto valore» e baciai la terra, quella terra che lavoravo e che amavo ogni benedetto giorno. Prima o poi, i tempi sarebbero stati maturi per andare lontano.
Mi raggiunse finalmente Giannino, lo aspettavo, lui lo sapeva. Sentivo di nuovo alle mie spalle il suo respiro affannoso, come quando mi abbracciò sul ponticello, prima della disgrazia. Questa volta mi girai. Ci trovammo faccia a faccia. Non esitammo a baciarci sotto gli occhi dei santi.
*****
La sposa è uno dei tre racconti che compongono 24h: Trilogia di un giorno, illustrato da Roberta Montemurro, disponibile dal 2014 in formato kindle su Amazon.
Immagine di copertina: Roberta Montemurro Illustrations.