
Le crepe è un hard-boiled di montagna in cui il romanzo d’intrattenimento e quello con pretese letterarie si incontrano. Il punto di forza di questa opera prima sta proprio nel saper dosare, e con maestria, lo scrittore alto e l’intrattenitore di massa, apparentemente inconciliabili. Lo dicono persino le note in quarta di copertina, forse bruciando la sorpresa del lettore, che certo, prima di catalogare il romanzo, si sarebbe fatto molte domande e avrebbe avuto più di un’incertezza. Io, onestamente, penso che proporre una lettura univoca – giallo o Bildungsroman di ambientazione montanara? – sia particolarmente penalizzante. Le crepe è un romanzo. E, secondo Teoria del romanzo di Guido Mazzoni, un romanzo è «raccontare una storia qualsiasi in qualsiasi modo». Basti questa definizione per Le crepe.
Nel 2010 ho preso parte a un seminario in cui Andrej Konchalovskij, regista russo nonché collaboratore alla sceneggiatura di Andrej Rublev di Tarkovskij, parlava di cinema. Fra le varie osservazioni che il maestro russo espresse quel pomeriggio d’estate, ce n’era una che si addice perfettamente al caso di Bottaro, cioè il fatto che, quando si fa un film, la trama e i personaggi sono sempre gli stessi e accadono circa le stesse cose. Si nasce, si vive, si muore. Ma la cosa che distingue davvero un buon film da un cattivo film è l’atmosfera. Questa osservazione, trasposta in letteratura, crea notevoli complicazioni. Ed è un’osservazione che certo necessiterebbe di essere notevolmente raffinata per reggere in ambito critico e che sarebbe interessante problematizzare (certo, ça va sans dire, in separata sede). Però, prendendo per buona l’osservazione di Konchalovskij e trasponendola immediatamente in ambito letterario, si può dire che Bottaro vince la sua scommessa giallistica grazie all’atmosfera che pervade, dalla prima all’ultima pagina, il suo romanzo d’esordio. E la montagna in copertina ben anticipa l’atmosfera cupa e metafisica che il romanzo seguiterà ad avere persino quando, nella seconda parte, il setting cambierà in favore della città. Continuando su questa falsa riga, si può dire che la montagna è il vero correlativo oggettivo di tutti i personaggi di Le crepe. Ognuno è paesaggio alpestre di sé stesso, impenetrabile cartolina racchiusa in un’eternità incerta. Parola del vicecommissario De Biase: «Fottuto Novecento. Fottuto progresso che fa schifo. Progresso di tetti d’eternit e monossidi. Già io non ci credo nella vita eterna. Forse neanche mi conviene crederci nella vita eterna, perché io sono ancora indenne dalla giustizia terrena, ma prima o poi qualcuno dovrà punirmi per tutte le gambe che ho spezzato e per quei due della Lancia blu. Non credo neanche in Dio, ma non perché non c’è. Solo perché mi sembra strano che, se esiste un ente come Dio, si occupi degli uomini, somigli agli uomini e via così. Perché Dio deve avere la barba e non può essere un criceto? O un canarino?» (p. 57) E ogni azione sembra essere la riprova dolorosa di una necessità macchinica che non sembra avere una vera e propria presa sul reale.
Sfoghi metafisici a parte, l’eternit è più dell’eternità in Le crepe. Perché tutto e tutti sembrano essere dentro il famoso motto «polvere alla polvere» ancor prima di abbandonare la propria forma di corpo o oggetto che sia. Da questo dolore prendono forza molti dei monologhi del vicecommissario. I suoi perché sono, in fin dei conti, i perché di tutti: «Io non ho fede. Io ci campo, sui miei dubbi. Vado avanti di dubbio in dubbio, aggiornando le mie teorie. Certo, se non avessi dubbi sarei felice. Ma è come un impulso incontrollabile che mi guida ogni volta a un nuovo perché. Quelli che hanno un cervello devono chiedersi perché anche se poi non sono felici. Noi no. La nostra felicità sta nell’essere agitati dai dubbi» (pp. 57-58).
Detto questo si comprende perché non si può scindere il giallo dal romanzo di formazione e viceversa. Sarebbe come leggere il Pasticciaccio dimenticandosi dell’edificio in corpo di pensiero gaddiano o al contrario leggendolo come un gialletto talmente ingarbugliato che il povero scrittore non è nemmeno riuscito a trovargli un finale. Gadda, fra l’altro, è ingegnere come il nostro Francesco S. Bottaro. Ma certo quest’ultimo non si sognerebbe mai di dire che «Barocco è il mondo». Semmai direbbe: «Il mondo è eternit. Ogni respiro che compio, finisco per intossicarmi». Da qui lo stile tipico del giallo da bancarella con copertine pulp e venduto per quattro soldi assume una postura molto più intima e dolorosa. Aggettivi onnipresenti come schifo, brutto, fottuto, lurido non sono la riprova che questo è un romanzo di terz’ordine. Anzi, raccontano il disagio del protagonista e così dei suoi compagni di avventura, che paradossalmente respirano aria velenosa proprio in alta montagna. E credo di poter dire a ragione che il vero titolo schifo, brutto, fottuto e lurido di questo romanzo doveva essere «L’eternit è la mia eternità»: «Ci sono addirittura periodi in cui mi sento inadeguato alla mia fulgida vita. Periodi in cui penso che una tegola mi cadrà addosso e mi schianterà, periodi in cui penso che in fondo vivere mi serve solo ad arrabbiarmi, a infervorarmi, a imbiliarmi, che in fondo ci sono solo poche persone che si curano di me e comunque soffrirebbero se mi cadesse addosso una tegola per cui io servo soltanto a fare del male a chi mi sta vicino. Ed è una battaglia persa. Ma è comunque la mia fulgida vita. È come una vasca di miele in cui una mosca sta affogando» (p.97).
L’imbiliarsi è neologismo che ben incarna la poetica di Bottaro. Tutto si riduce a quel granello di eternit in un paesaggio di morte da dopobomba. La vita può anche essere fulgida ma tutto affoga nel dolce e velenoso miele dell’inabissamento. E forse, se c’è il ritrovamento di un cadavere all’inizio del romanzo, come ogni stereotipo giallo che si rispetti, più si prosegue nella lettura, più si ha il dubbio che se c’è un cadavere è quello del vicecommissario, ibernato in una non-vita d’altura che viene scossa da un evento luttuoso a cui si susseguiranno numerosi colpi di scena, fino alla risoluzione, almeno parziale, dello gnommero.
Il finale sembra rischiarare apparentemente gli orizzonti, quasi riscrivendo al contrario il famoso excipit di Con gli occhi chiusi di Tozzi, autore che certo Bottaro deve aver frequentato, insieme al conterraneo Bilenchi. Ma a essere sinceri, l’amore che sembra essere sul punto di incarnarsi sembra quasi uno scaricabarile. La forma è un pulviscolo a puntini di polvere cancerogena. Se li uniamo, come in un giornalino d’enigmistica, si può parlare, sebbene solo incidentalmente, di vita.
Adesso, starà a Bottaro decidere come continuare il suo percorso: se pubblicare una Meditazione milanese o fare un best-seller o continuare sulla falsariga del promettente esordio, non risolvendo così l’equivocità che l’attraversa. Credo che i lettori saranno curiosi di vedere come proseguirà questa carriera all’insegna della meditazione giallistica o del giallo da meditazione. E, stando agli addetti ai lavori, si dice essere prossima la pubblicazione di un nuovo romanzo dell’autore.
Concludendo, un pregio che va riconosciuto al giovane autore è quello di infischiarsene beatamente di certe polemiche critiche che hanno attraversato la contemporaneità: Bottaro scrive romanzi come si faceva una volta, con un alter ego che si prende la responsabilità, attraverso mascheramenti, self-fashioning, ambivalenze capziose, di essere portavoce del pensiero dell’autore: niente co-individui, niente auto-fiction, niente auto-poiesi. Questo consapevole gesto di distanziarsi dal cuore dell’agone letterario contemporaneo, certo non sminuisce la bontà dell’operazione scrittoria.
Non resta che goderci questo bell’esordio promettente, dove i pregi vincono sui difetti, e vedere se all’aggettivo promettente si potrà aggiungere, un giorno, qualcosa di più.
Francesco S. Bottaro
Le crepe
Prometheus, Milano, 2012,
pp. 227

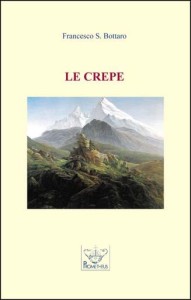
![Prometheus – [Il dono abbietto dell’Eternità] – Lord Byron](http://www.crapula.it/wp-content/uploads/2017/02/Museo_Archeologico_Nazionale_delle_Marche_-_Dinos_di_Prometeo_-_particolare_della_consegna_del_fuoco.jpg)
![TRILOGIA DELLA FORMA – DISSERTAZIONE III [CONCLUSIVA] – Il postmoderno mistico in Rimini di Tondelli](http://www.crapula.it/wp-content/uploads/2016/12/t4-rimini-.jpg)
