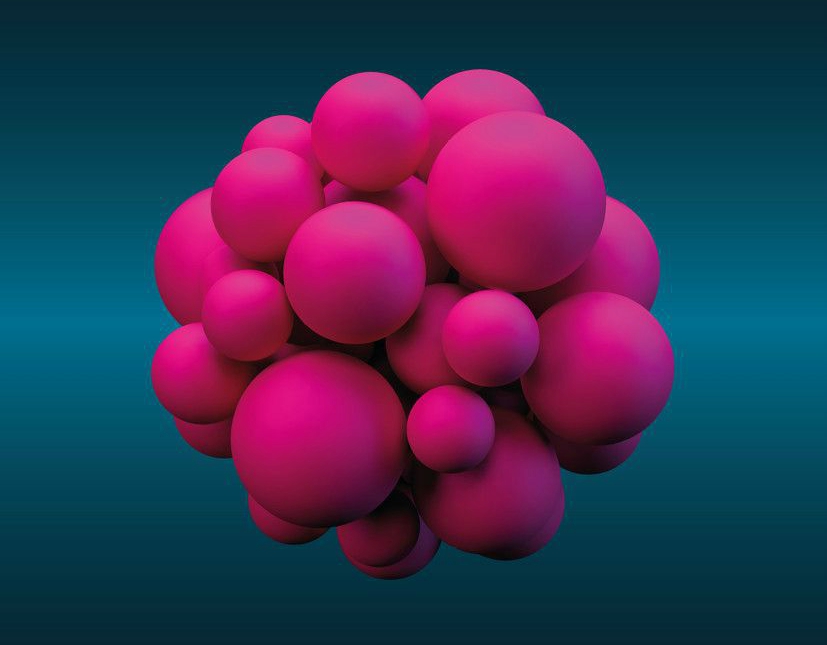Chi narra il narratore?
Abbiamo fatto il nostro tempo – Vincenzo Testo
Suppergiù nel 1999, i giovani più istruiti e al passo con i tempi smisero di leggere romanzi. Abbandonarono sia la buona vecchia narrativa edificante, sia le astruse scritture di avanguardia.
In quel momento, con le parole di Sloterdijk, la letteratura diventò una subcultura.
Gli autori che non se ne accorsero furono relegati nella c.d. “narrativa ombelicale”, spregiativo di sapore stalinista venuto di moda dopo la reazione di Saviano; quelli che invece non ci credettero intentarono il “ritorno alla realtà”, finendo per scimmiottare, come negli anni novanta ma più seriosamente, la TV. Ai margini restarono quelli estranei al negazionismo, che nella subcultura si erano trovati a loro agio, gli esponenti della letteratura come cospirazione. Autori come Michele Mari e Vincenzo Testo.
Il clima è cambiato. A forza di ridimensionamenti commerciali generalizzati, Michele Mari ha finito per emergere, simile a un dorso di scoglio che appare solo con la bassa marea, e trovare già in vita una qualche versione subculturale della consacrazione.
Vincenzo Testo invece si è congedato, per così dire, in continuità con la sua esistenza. Nessuno lo conosce né probabilmente lo conoscerà. Come senza dubbio desiderava.
Mi assumo perciò la piena responsabilità di tradire la sua memoria, quando lo dichiaro, di fronte a questo uditorio vuoto, uno dei romanzieri più significativi dell’ultima stagione.
***
Conobbi Vincenzo Testo una notte di maggio a Ravenna.
Viaggiavo per spingere un mio libro, trovandomi di frequente a passare notti solitarie in hotel. Nessuna differenza se stavo in una grande città o a Montecavolo: rientrato a tarda sera in una stanza estranea, senza nemmeno l’energia per darmi una sciacquata, spulciavo lo smartphone, spegnevo l’abat-jour e mi raggomitolavo nel letto sentendomi un disgraziato.
Mi sentivo solo, ma preferivo la solitudine familiare del viaggiatore al disagio di cercare svago negli sconosciuti. Infatti temo gli incontri perché non mi fido delle persone. Mi trovo bene solo con chi frequento da tempo.
Spesso gli anfitrioni locali, dopo l’incontro, m’invitavano a una situazione conviviale. Se avevo pronta una scusa plausibile, declinavo. Altrimenti limitavo i danni fino all’orario in cui potevo tornare in hotel senza risultare totalmente maleducato. Un’ora di sonno perduta, poco male.
Se altri autori pernottavano nell’hotel, era più difficile. La compagnia degli scrittori mi è sgraditissima, perché parlano solo di altri scrittori e figure del mondo editoriale di cui non so e non m’interessa di saper nulla, come se al mondo non ci fosse niente di più interessante che commentare l’entità dell’anticipo intascato dalla D. per il suo prossimo romanzo, o l’imbarazzo causato dalla supplica che M. ha spedito a T. nella speranza che la casa editrice si rimangiasse la trombatura. (T. l’ha subito girata a tutti i suoi gruppi WhatsApp – pare che odi M. perché quando questi era un semplice correttore di bozze era innamorato di lui, ma M. lo ignorava.)
Non tutti gli scrittori sono così: ci sono anche quelli come me, che tacciono. Quel che tutti ci accomuna, i loquaci e i taciturni, è che non parliamo mai di letteratura, vuoi perché ne siamo gelosi, vuoi perché tutte le attenzioni che le abbiamo dato non hanno fruttato uno straccio di confidenza, e dopo tanti anni di frequentazione, di lei non sappiamo nulla.
A volte, rientrati nella hall, quando già precorrevo la liberazione del letto, il collega m’invitava al bar per l’ultimo goccio, invito a cui non ero capace di oppormi perché dettato da una malinconia identica alla mia, e la tortura si prolungava per un’altra mezz’ora.
Il simposio “Di cosa scriviamo quando scriviamo di crisi: per farla finita con la Fine della Storia” era andato abbastanza bene. Avevo esposto il mio concetto, mi sembrava, senza troppi giri di parole: la fiction pura potrà anche sparire, ma le storie rimarranno a insegnarci a vivere e a prenderci cura di noi stessi e degli altri. Gli altri relatori avevano portato relazioni prive di difetti evidenti. In fin dei conti avevamo detto tutti la stessa cosa, ognuno dal suo peculiare osservatorio: che la letteratura è il volano d’ogni discorso sociopolitico, è dalla traccia delle storie che prendono piede le avventure collettive. Qualcheduno aveva avuto addirittura il coraggio di accennare alla mitopoiesi.
Dal canto suo, Vincenzo Testo aveva scombiccherato una disamina del parto abominevole di Chiara Uzeda nei Viceré, «episodio che da solo è sufficiente a riscattare le angustezze dell’Ottocento letterario in Italia» – falsissimo, purtroppo! ma un bel pensiero, una di quelle stronzate autoriali che nondimeno fanno l’effetto del vero, – e poi aveva schiacciato un pisolo. Qualcuno aveva ironizzato, ma senza troppa malignità perché la maggioranza ne aveva compassione.
Durante il ritorno in taxi non ci rivolgemmo la parola e nella hall Testo mi fece un cenno appena di saluto, mentre deviava in direzione del bar, a cui risposi d’istinto con un «Buona notte, Professore» di cui continuai a congratularmi soddisfatto in ascensore e in corridoio e in bagno e persino sotto le coperte. Era stato un ottimo saluto, deferenza meritocratica con un’obliquissima, quasi assolutamente implicita, angolatura parodica, esattamente il modo con cui mi piaceva rapportarmi con i decani come Testo, della cui produzione, peraltro, all’epoca non avevo letto una riga.
Avevo l’ansia di addormentarmi al più presto perché l’indomani mi aspettava una faticosa doppia presentazione nel punto libri del centro commerciale di Malnate presso Varese, alle 17 da solo, un normale incontro con i lettori e firmacopie, e alle 19 in tandem con Ludmilla Rana e il suo Senza colpo ferire, un confronto sulle donne che scrivono per un pubblico maschile, come lei, e gli uomini che scrivono per un pubblico femminile, come me.
Ludmilla Rana era molto brava nel suo genere, ma spesso doveva subire insopportabili ironie sessiste a causa della sua bellezza, che era talmente abbacinante da sopravanzare il suo pur notevole talento. Oltre che un’ingiustizia, era un peccato, perché ciò la rendeva diffidente nei confronti dei suoi colleghi, maschi e femmine. Di ciò bisogna ringraziare la misoginia diffusa purtroppo ancora oggi nel mondo delle lettere. Addirittura, in quella occasione, nell’evento Facebook c’era stato scritto per un’intera giornata, invece che “doppia presentazione”, “doppia penetrazione”. Gravoso lapsus di G., l’ufficio stampa del mio editore, uno che era cortesissimo affabilissimo dolcissimo ma appena si distraeva (leggi: beveva) si rivelava il maschilista incontinente che era.
Dopo un po’ di giravolte sotto le coperte mi ritrovai a guardare il riverbero dei lampioni sul soffitto e a dover ammettere i sintomi del sogno senza sonni (cit. me stesso), la mia compagna notturna, l’insonnia. Avevo anche fame, mi accorsi. Scesi al bar.
Trovai Testo seduto al bancone, appollaiato s’uno sgabello come un gufo in giacca e cravatta. Infatti era ancora vestito di tutto punto con il completo classico con cui aveva affrontato la giornata. Si era tolto solo il cappello e lo aveva appoggiato sul banco. Fece cenno di avvicinarmi e quando lo raggiunsi disse: «Sa cosa diceva Balzac dell’insonnia?»
«No.»
«Nemmeno io!» Ridacchiò senza riguardi; io abbozzai un sorriso.
M’invitò a sedere e spostò il cappello per farmi spazio.
«Ha ragione,» dissi, «al giorno d’oggi sono tutti buoni a saccheggiare internet per riempirsi la bocca di citazioni. Sa che c’è gente della mia età che la sera prima di uscire ripassa Wikipedia?»
«Leggere l’enciclopedia mi pare un’attività encomiabile. Lei non lo fa?»
«Certo. Ci spreco le giornate.»
«Intendo: lei non si riempie la bocca di citazioni?»
«Ho smesso. Il fatto è che ho rinunciato a scrivere, anche se non l’ho detto ancora a nessuno. Mi sono reso conto che non sono capace. Scrivo male.»
«Scriviamo tutti male. Colpa dell’italiano. È impossibile fare un discorso coerente, con l’italiano.»
«Concordo. Brutta lingua. Da pataccari.»
Mi squadrò coi due noccioli d’oliva dei suoi occhi affusolati: «Forse sono stato troppo pessimista,» disse parlando più a se stesso che a me, «almeno un orecchio aperto ce l’avrei avuto.»
«Oggi l’abbiamo ascoltata tutti con grande interesse.»
«Seriamente? Non so nemmeno io che cosa ho detto.»
Chiamò il barista che, mezzo addormentato, guardava roba nel telefono, e ordinò due bicchieri di sgnappa. Chiesi da mangiare, mi consegnò un pacchetto di patatine. Dopo che si fu bagnato le labbra, Testo depose il bicchierino e trasse di tasca un fascicolo gualcito.
«Oggi ho parlato a caso perché ho improvvisato. Dovevo leggere questo, ma all’ultimo momento non ne ho avuto il coraggio. Non mi fraintenda, non ho avuto paura delle conseguenze; si figuri, alla mia età! Ho temuto per voi giovani, di contribuire alla vostra infelicità ammaccando certe speranze.»
«Si rassicuri, siamo ben al di là di qualsiasi speranza.»
«Questo lo crede lei. La disperazione è una faccenda assai più vasta di quanto si è in grado di cogliere a un’età come la sua. Ci sono bisogni così profondi che ci vuole quasi una vita intera perché vengano alla luce. E quando lo fanno, allora sì che uno è in grado di sentire l’immensità di quel che manca.»
Parole enfatiche dette senza enfasi che mi colpirono. Fu in quel momento che pensai per la prima volta che forse valeva la pena leggere qualcosa di questo Testo, forse Ferie ingenerose, romanzo sul quale avevo letto, mi ricordai, che faceva scrosciare dalle risate. Rimanemmo taciturni a guardare nei nostri bicchieri quasi vuoti.
«Ebbene,» dissi, «non si faccia pregare, legga[1].»
«Mi si chiede di dare un contributo a una conversazione sulla letteratura civile o d’impegno. Non so da dove cominciare, dunque comincerò dalla fine, con una proposizione tanto netta quanto ovvia: c’è una relazione diretta tra l’aumento delle disparità sociali portato dall’imperialismo mercatista e la perdita di legittimità del narratore. Si potrebbe procedere a ritroso da questa conclusione per mille versi. Scelgo il più letterale. In un regime editoriale deregolato com’è quello della Cosmopoli post-borghese, che tende all’accentramento e al monopolio, lo scrittore di successo, in quanto prodotto di una fuggevole egemonia commerciale e promozionale, che è il risultato di una concorrenza all’ultimo sangue di cui egli stesso è il sopravvissuto, l’individuo più adatto, sarà indifferente al deserto che la sua prominenza diffonde tutto intorno con un’energia corrosiva e dissuasiva paragonabile a un’occupazione di territorio. Per mera forza di attrazione, soffocherà, accentrando su di sé lo scarso tempo a disposizione dei lettori, ogni domanda di letteratura che si troverà a sfuggire alla sua orbita. Egli agirà in campo letterario come un aspirapolvere, simile in ciò a un centro commerciale o al suo corrispettivo virtuale, il social network, e ciò a prescindere da qualsiasi contenuto sia veicolato dalle sue opere. Quale mai autorità, prestigio, ricchezza di proposte per l’universo sociale può avere un autore che si è affermato in questo modo? Egli è solo una bestia che ha scavalcato altre bestie. Adesso ch’è in cima al mucchio il suo ululato sovrasta i lamenti degli sconfitti. Altro che impegno, altro che civiltà. Il narratore non ha più ascoltatori, perché ormai sa raccontare soltanto la storia di come è diventato famoso.»
«[…] Qualsiasi proposito d’impegno letterario in direzione della società non può che prendere le mosse dal rifiuto del commercio librario. Solo nel relativo anonimato di una ricerca stilistica che si dedica al proprio prossimo immediato, è possibile favorire la creazione di un ambiente spazioso a sufficienza per dare ai tanti la libertà di perseguire i propri fini che è il presupposto di ogni vero, solido edificio artistico, che è a sua volta il presupposto di una possibile funzione progressiva dell’arte. Non mi si fraintenda: tale proposta non nasce da alcuna vocazione utopica o fantasia di progresso. Non ho mai incontrato un’idea di mondo migliore che mi scaldasse a sufficienza da accendere in me il fuoco della modernizzazione. Mi ritengo immune dalle grandi aspettative. Al contrario, ciò che pone le premesse della mia conclusione è una profonda sfiducia nella letteratura, verso ogni aspetto della disavventura letteraria. La denuncia della letteratura, da Platone in giù, è un genere così ben frequentato e prestigioso che anche i (sempre più rari) fautori delle lettere mettono le mani avanti ammettendo, prima d’ogni discorso, che se qualcosa di buono pure uscirà, il punto di partenza e di arrivo sarà sempre il deserto dello spirito che sottostà all’immaginazione poetica. Ho sempre odiato la scrittura più di quanto non l’abbia amata: la mia prima di tutto, ma anche grandissima parte di quelle degli altri, e sono in ben nutrita compagnia con tale sentimento. L’amore per il testo sta rapidamente scomparendo, sostituito dal suo esatto opposto. Solo un grandissimo ingenuo ormai può amare il libro e il rosario di parole indistinguibili che vi se ne svolge. E in questo mondo qua, il letterato ingenuo fa poca strada. Siamo tutti serpentelli. E partiamo tutti, quantomeno, da una profonda sfiducia verso il linguaggio, che di solito si solidifica in un robusto disgusto per le arti della parola. Confesso che queste stesse parole, pensarle, buttarle giù, pronunciarle, mi dà una certa nausea. Ecco. Per questo voglio andare avanti: perché provo schifo, e mi faccio schifo, e vedo solo schifo in tutta questa impresa, e questo semplice, crudo, istinto di sopravvivenza mi dà il diritto di procedere. Se vi pare di aver già sentito e risentito queste tiritere, è perché è vero. Intrant banalia.»
Vuotò la sgnappa rimanente e mise giù il bicchiere con uno schiocco.
«Al contrario di quanto amano sperare gli scrittori, e amavano sparare i critici prima di svanire, la letteratura non conosce né una gerarchia, né un ventaglio di valori. Le opere letterarie, quando sono compiutamente letterarie, sono tutte identicamente vergognose. Quando si dice che un racconto è bello o brutto si parla di dettagli che interessano solo agli specialisti, – esseri così inetti da non essere neppure in grado di articolare il grado zero dei propri vizi, – si mangia la buccia. Il nocciolo è sempre lo stesso ed è l’esposizione delle mancanze che hanno reso l’opera necessaria. La trascendenza estetica non redime dal peccato originale. Il male risplende attraverso la bellezza. Forse che il rancore non trabocca dai versi di Dante? Quanto è vigliacco Petrarca? Ariosto non cincischia nell’inconsistenza? E Leopardi, chi più di lui invalido di così tanta parte dell’esperienza umana? Manzoni ce ne accorgemmo già al liceo, imboscava come ogni scrittore borghese una famiglia di esauriti e di alcolizzati. Calvino, parole sue, un bambino buono, cioè scemo. Manganelli si millantò turpe dalla nascita pur di nascondere un’inettitudine così assoluta che gli precludeva persino il crimine. Dei contemporanei, nemmeno a parlarne, una manica d’incapaci ignoranti storditi dai narcotici.»
S’interruppe e rivolgendosi a me: «Con rispetto parlando.»
«Incapace e ignorante: c’est moi. E se continuo a non riuscire a dormire inizierò pure con i narcotici. Prosegua.»
«Una delle frottole più clamorose è il cosiddetto piacere del racconto, quando in realtà a nessuno piace raccontare. È un’attività di una pesantezza insopportabile che s’intraprende solo in cambio di qualcosa, di solito favori sessuali o per intontire gli ascoltatori e sviare così la loro attenzione da qualche fatto increscioso che si vorrebbe dimenticato. Ma ancor più bugiarda e quasi altrettanto ladra è la propaganda dell’arte in generale e della letteratura in particolare come funzione epistemologica, secondo la quale essa rappresenterebbe una terza grande via madre della conoscenza, una cosa a sé, alternativa sia alla via scientifica che alla via mistico-religiosa, non equidistante ma equamente idiosincratica. Quando invece è ovvio che leggendo non si conosce niente, ma anzi si dimentica, e tanto più si apprezza quanto meno s’impara, e quanto più si dimentica. Peggio ancora, chi si esalta esaltando il potere sovversivo della letteratura. Sono sempre quelli che non saprebbero sovvertire nemmeno una frittata nella sua padella, e la lasciano sempre cadere, la frittata, non dalla padella nella brace della rivolta, come vorrebbero, ma sul pavimento di cucina, a faccia all’ingiù. I rivoluzionari, quelli veri, mandavano i letterati nella Terra che dorme, dove potevano scongelarsi, se gli pareva, usando i loro manoscritti come combustibile per il samovar. Già! La sovversione, o come la chiamano oggi i francesi, la destituzione richiede fede e organizzazione, mentre gli scrittori hanno fede solo nella propria capacità di mentire, e di organizzazione conoscono soltanto, e a malapena, quella prodotta dalle regole della sintassi. Ma anche dire che la letteratura è impotente è una menzogna. La letteratura è sempre all’opera, crea, disfa e muta incessantemente, solo che si muove nel caos, colpisce, premia e punisce a caso. Oh, la letteratura è potentissima, e lo è in special modo quando gli uomini credono di essersene liberati, di non aver più bisogno delle farraginose pesantezze dei libri, perché allora li trasforma in personaggi dei romanzi, quelle marionette menomate che esistono solo in quanto voce di qualcun altro. Stravolge le menti e sradica le visioni del mondo come una forza della natura, e non c’è ignoranza che la possa bloccare. C’è chi sostiene che il linguaggio è un virus e le storie sono il vettore che lo trasmette. Una similitudine che sottovaluta: le storie sono mostri feroci che vagano sfuriando e colpiscono a caso il malcapitato in cui s’imbattono. Dopo aver letto Il giro di vite, per decenni non potevo riportare alla mente il nome di Peter Quint senza cadere nel terrore che s’aprisse sotto la scrivania un portale per l’inferno. Se non è potere questo! Un potere che sembra beffardo, ma è solo cieco… Un’altra grappa, per favore.»
«[…] Ma di tutti i motivi per non scrivere, la questione della sovrapproduzione è il più importante. Tutta questa valanga di libri, è innanzi tutto ragionevole evitare di aggiungerci sopra anche il proprio, il fiocco di neve, lo Speciale. Ma una sana emotività, prima ancora d’iniziare a ragionare, si spaventerà di quell’onda di carta, e colta da disagio interiore (è un’emotività tardo-adolescenziale, da sedici-diciassettenni), se ne terrà sanamente alla larga. Chi invece non si lascerà spaventare, e anzi sarà attratto e vorrà metterci del suo, sarà una persona così autarchica da suscitare subito sospetto, e subito dopo schifo. La qualità che accomuna tutti gli scrittori moderni, è un disinteresse per gli altri umani così pronunciato che fanno fatica a riconoscere che esistono. È una selezione naturale, non una ideologia (forse si dovrebbe dire, se ciò non mi facesse sembrare comunista, ch’è l’ideologia della selezione naturale?), è semplicemente quello che succede date le condizioni, chi ha un minimo di sensibilità si ritira e restano soltanto i freddi, gli egoici, gli stralunati. Sono loro che moltiplicano gli ISBN. La soluzione più semplice e diretta a questo stato di cose sarebbe limitare la produzione diminuendo gli scrittori. Ma ciò implicherebbe ucciderne in gran massa, perché non è mica che lo scrittore può essere convinto a smettere, al contrario più lo reprimi più scrive, come strizzando un tubo l’acqua schizza più forte. Ti toccherebbe proprio, civilissimamente, ammazzarli. Oppure potresti abbracciare la prassi che va forte al giorno d’oggi tra le classi abbienti, che puntano a rendere poveri i colti e ignoranti i poveri, riparando a quell’errore della seconda industrializzazione di aver reso troppo economica la cultura, così economica da consentire ai meno dotati d’infarinarsi di quel sapere, quel poco sufficiente a consentir loro di concepire l’idea di scrivere. Più analfabeti, meno scrittori. Ma qui entra in scena la posizione etica, che pur torcendo il collo, ti costringe a riconoscere che non ce l’hai in te, la passione per lo sterminio. Ti toccherà agire, keynesianamente, dal lato della domanda: aumentare la domanda di libri. Un turnover più rapido. Risolverebbe il problema della quantità ingigantendolo. Darebbe al lettore in rara visita a una libreria, ormai trasformata in un centro d’arte contemporanea, la sensazione, sempre dolce, e sempre più rara di questi tempi, di partecipare a un flusso. Colonnine si svuoterebbero nell’ordine dei minuti, una circolazione perpetua, a questo serviranno le librerie, saranno installazioni pubblicitarie sul tema della circolazione accelerata della letteratura.»
«[…] Lo spettacolo è noioso, ma non è monotono: cambiando di epoca in epoca la morale, variano anche i simboli della perversione letteraria. L’Ottocento, specie in Francia, nascose l’ossessione pel denaro dietro l’ossessione per la natura; gli scrittori italiani del secondo dopoguerra ebbero il problema della rivoluzione, di rapportarsi con la rivoluzione, di sostenere o invocare, diluire, dileggiare o ignorare – soprattutto ignorare! – la rivoluzione; i postmoderni si persero nei labirinti del narcisismo e si riconobbero nei narcisismi del labirinto. Oggi, in tutti i paesi, primeggia il tema dell’identità, della questione esistenziale intesa come tentativo di mettersi nei panni di qualcun altro cercando di non pestarle i piedi. Prudenza, si tratta sicuramente di una moda. Sappiamo bene che lo sfarfallio variegato della superficie non è altro, appunto, che superficie (ciò che Borges chiamava specchio), sotto la quale si dissimula il magma della vergogna bruciante, della verità insopportabile perché mette a nudo il vuoto dei valori, il centro empio della truffa millenaria. Prudenza, ma, dato che non abbiamo altro che mode, coraggio.»
Finita la seconda grappa, Testo si alzò e, leggermente malfermo sulle gambe, si allontanò di qualche passo dal banco, in direzione del lato buio della sala, dove s’intravedevano i tavoli apparecchiati per la colazione.
«L’identità, dunque. Mettiamola sul banco, questa identità. All’identità, ci si avvicina raccontando di sé, inventando a partire solamente da sé, abbandonando ogni immaginazione che non sia su di sé e attraverso di sé. Si avverte, così facendo, di non avere alcuna altra autorità che sé. Non si riesce ad assumere alcun ruolo. Non si è mai sofferto noie dalla polizia, quindi non si è autori. Non si è intellettuali, perché ci si sente ignoranti e privi di ricette, contemporaneamente non all’altezza della specializzazione di competenza, la letteratura, e incapaci di allargare le ali sopra le generalità umanistiche, se non direttamente umanitarie, che si pretenderebbe da se stessi. Non si è poeti, perché la poesia si è dissolta nel linguaggio, la poesia perdendosi si è tramutata nel linguaggio stesso, l’unica parola rimasta esclusa dal regno della poesia ormai è la poesia in senso proprio, la parola poetica, i libri di poesie. Né si è interpreti della realtà, non lo si è mai stati. Che risate la realtà. Non si registra, non si riproduce, non si esprime, non si copre. Non si è nemmeno, a voler essere pedanti, scrittori, perché in senso stretto tutto ciò che si fa è pensare. L’unico appiglio che resta è il fatto di essere se stessi. In assenza di una retorica una poetica una critica un’estetica, non resta che raccontare storie su di sé. Se uno è un essere umano, ci si dice, avrà esperienze umane, e umanamente le potrà raccontare ad altri esseri umani. Quasi sempre sono vicende d’amore, perché l’amore è l’esperienza più intensa. Sennò si scrive molto delle proprie fissazioni: mi si dice che oggi vanno forte i videogiochi. Ogni tanto ci si avventura in esaurimenti nervosi; crisi psicotiche; esperienze mistico-religiose, ma sempre con riserva, perché non si è in grado di dire a cosa, là fuori, davvero rimandino quelle esperienze. Resta la storiella di uno che pensa delle cose, e magari racconta quello che gli è capitato pensando quelle cose, di solito una sconfitta, linee d’azione rese impraticabili dalla necessità di sopravvivere o dall’orgoglio. Si continua ad arricchire i propri personaggi, sperando che la massa, la quantità del vissuto rielaborato finisca prima o poi per produrre una qualità del pensiero, un punto di vista che non è solo il proprio, ma non succede mai, il momento di presa di coscienza, di chiusura e corroborazione, non avviene mai. Tutte le storie continuano ad allontanarsi. Insomma scrivere di noi è l’unico modo di scrivere che conosciamo, ma in fin dei conti è solo un modo di ritardare la confessione interiore che non possiamo dare senso a niente. Nel migliore dei casi, dunque, quando cioè non siamo distratti dal lavorio vano del mantenere una dignità (raccontandoci, mitizzandoci, ecc.), raccontiamo la nostra incapacità di raccontarci. Questa dunque è l’identità: il criceto della coscienza.»
«[…] Questa è brutta davvero. A Tizio gli è morto il padre. Dice ch’è uscito matto. Nello studio dove il vecchio è spirato, ci ha messo un totem che lo rappresenta, fatto di paglia e cappotti. Lo tratta come se fosse vivo e gli porta da mangiare tre volte al giorno. Lo conduce a passeggio su una seggiola a rotelle e sua madre è indecisa se chiamare lo psichiatra o l’esorcista.»
«Mi scusi» bofonchiò Testo scartabellando, «devo aver mescolato le pagine. Qui sarebbe stato il passaggio in cui mi rivolgo all’uditorio. Un gesto un po’ cialtrone, da prestigiatore con i calzini bucati, ma in fondo la mia arte non è più nobile di quella di chi trae la colomba dal cilindro. È solo un po’ meno biodegradabile. Vi chiedo il permesso di fare un esperimento, un piccolo “what if”. Facciamo che io sono venuto qui come rappresentante dell’identità, cioè a parlare di me. Vediamo dove ci porta. Abbia pazienza, mio giovane collega, se andrà tutto a ricadere su di lei. Può immaginare, se la fa sentire più a suo agio, che siano presenti i nostri colleghi di oggi, tutti qui in fila al banco. Manca il pubblico. Toh, dimenticavo questo giovane barista che pare un marinaretto. Non ha smesso un secondo di spippolare al telefono. La facilità con cui c’ignora è invidiabile. Un ottimo rappresentante della nostra audience.» Testo prese a guardarsi intorno indicando gli sgabelli, i tavoli vuoti nella penombra, «Immagini che il bar è pieno di gente venuta ad ascoltare, del resto non sarà difficile, nei locali chiusi, a quest’ora della notte, restano tracce, vorrei dire quasi gli spiriti, degli avventori passati.»
Incantato da quella evocazione, ritardai a rispondere. Cercai veramente di credere che la sala fosse gremita di fantasmi in ascolto. Soddisfatto dell’effetto, riprese a leggere con piglio quasi aggressivo. Mentre prima era parso rivolgersi soprattutto a se stesso, adesso alzava le ciglia dalla pagina ogni volta che poteva, e continuando a memoria fino alla fine della frase, mi fissava negli occhi.
«Chi sono? Vincenzo Testo, scrittore. Ho pubblicato i romanzi Roncobilaccio, Fedora a brandelli, La comanda, Il veneziano ammattito, Ferie ingenerose, Turbo e I coniugi Quattrone; le raccolte di racconti Via mare e Atti lucidi; la silloge poetica Obitorio e un volumetto di scritti critici di cui ho felicemente dimenticato il titolo e dimenticherei volentieri l’esistenza. Ho partecipato a tal blog, diretto la tal rivista, tale festival (molti di voi ancora non eran nati), e così via. La domanda però è “chi sono”, non “che cosa ho fatto”. L’identità guarda con sospetto al fare, perché il fare implica dinamismo, dispendio, adattamento, in una parola: mutamento – e non c’è niente di più pericoloso per l’identità che il mutamento. Chi sono? In uno dei miei primi romanzi, non ricordo esattamente quale, uno dei protagonisti stava tutto il tempo a chiedersi “chi sono? chi sono?” allo specchio. Ovunque andasse Vito – già, si chiamava Vito – appena poteva si defilava in bagno per interrogarsi e siccome chiedeva chiedeva ma non si rispondeva mai, finiva per mandarsi sempre al diavolo, e la sua vita andava a rotoli. Oppure era un film? Sì, forse mi confondo. Un vecchio film ambientato a New York. Vito si era fissato con quel film e si chiudeva nei bagni per recitarsi le battute. Cercava se stesso attraverso il film, non funzionava mai e si arrabbiava, sempre di più, “chi sono!” grida, “chi sono!” sempre più disperato e furioso finché alla fine… Aspetta, non ricordo più come andava a finire.»
Aveva alzato la voce, roteava le orbite. Il barista si distrasse un secondo dallo schermo per lanciare un’occhiata preoccupata al vecchio e una, imperscrutabile, a me.
«Chi sono? Presto detto, sono uguale ai quattro quinti dei presenti: un maschio bianco eterosessuale occidentale benestante con elevato livello di istruzione. E cisgenere (si dice così? il correttore ortografico me lo segnala). Percepisco un brusio di disapprovazione. Come? Non siete benestanti? Ah, ma alla mia età lo sarete. Siete troppo svegli per dilapidare l’eredità e non trovare presto o tardi un modo per ricevere un reddito decente dalla società grata per la vostra passione di sostenerla, salvarla con la letteratura. Chi sono? Sono un vecchio arrapato. Sono quel vecchio bavoso che mentre conduce una vita regolata, quasi austera, di studio e lavoro, mentre sostiene, moralmente ed economicamente, una famiglia di ormai tre generazioni, con fedeltà ininterrotta e sollecitudine, in realtà pensa esclusivamente, costantemente, alle dune porose che increspano i corpi femminili. Ormai senza più neanche ribollire del sangue; ero già paterno trent’anni fa, sono stato nonnesco a lungo, adesso scivolo a scossoni ovattati in una benevolenza spettrale verso tutto ciò ch’è giovane e femminile. Ma il desiderio è identico, sebbene reso innocuo dall’impotenza. O dalla saggezza, se vi piace chiamarla così. Infatti le bambine, quando escono da scuola, a volte sobbalzano di vergogna e disgusto quando incrociano un mio sguardo involontario. Solo le bambine lo capiscono; le donne adulte lo scambiano per dolcezza. E non è trasparito mai niente, neppure nei romanzi. Sono pieni di perversioni sessuali, i miei romanzi, ma la mia non c’è.
«A volte le sogno ancora, le ragazze giovani, mi guardano di sottecchi e irradiano la loro bellezza,» disse Testo, lo sguardo perso nella memoria. Sarà stata la suggestione, ma mi pareva che fra i tavoli oltre il limite dei piccoli coni soffusi disegnati dai faretti del bar, si addensasse una cappa di fumo come quella che si forma in una sala piena di fumatori (ma nessuno di noi aveva fumato), tra le cui volute emergevano ormai delle sagome di figure umane in ascolto.
«Chi sono? Un pettegolo. Non lo pensereste mai perché ho questa maschera misantropica e non m’intrometto mai nelle chiacchiere, ma tendo sempre l’orecchio e mi segno tutte le storielle, siete tutti molto bravi a raccontare gli affari degli altri e ormai ne ho raccolte così tante da farci un libro, un libro schifoso che si prenderà gioco delle vostre vite e di tutti gli altri scrittori. Ci sarà tutto: da chi si è realmente fatta mettere incinta Giada Piovani; chi odia in segreto gli ebrei, chi non ha fatto outing e chi ne ha finto uno; chi ha imparato il russo per plagiare impunemente; chi è caduto nel Po, chi nella Giudecca, chi nel Tevere, chi nell’Arno. Il giovanotto in prima fila, per esempio. Sì, tu con la sciarpa rossa. Conosco i tuoi problemi con l’alcol. Ne ho avuto contezza poco tempo fa, quando l’argomento tenne banco durante mezza cena in trattoria, presso un’allegra tavolata di tuoi pari e colleghi. Se c’era del moralismo, tutti lo tennero nascosto. No, era una classica tavolata di artisti: non si risparmiarono alcun tipo di giudizio, fuorché quello etico. La questione che appassionò i commensali fu se la continua ubriachezza non stesse iniziando a ottundere le facoltà creative del ragazzo. (A vedere la maniera in cui avvampa, si direbbe di no, o almeno non del tutto.) La maggioranza riteneva che è così. Fu citato Cormac McCarthy: L’alcolismo è la malattia professionale degli scrittori. Non sfuggì a nessuno l’ironia che a un simile pronunciamento fosse pervenuta un’accolita di avvinazzati.»
«Chi sono chi sono chi sono,» esclamò il ragazzo in prima fila, l’alcolizzato. «Ma chi cazzo se ne sbatte!» Balzò in piedi e così facendo uscì dalla zona d’ombra, penetrando nella piccola ribalta illuminata davanti al bar. Aveva l’aria sbattuta e storta tipica dei postumi da sbronza, le borse sotto gli occhi vitrei e le labbra arse. Spiccava la sciarpa rossa che aveva annodato stretta al collo. Del suo corpo, oltre alla testa scarmigliata, vedevo solo le braccia, – doveva essere di quelli che appena arrivano da qualche parte si tirano su le maniche, come se si volessero spogliare.
«L’abbiamo capito, sei un vecchio di merda, ti piace la figa. Siccome non hai immaginazione, vivi prendendo appunti, e tutti i tuoi romanzi sono scritti saccheggiando le vite della gente.»
Il vecchio, il mento all’insù, cercava la voce con gli orecchi, mentre gli occhi li aveva sbarrati, quasi rivoltati. Sorrideva beatamente e mormorava: «Esatto… Continua…»
«Guardatelo, sembra Palpatine. Però c’ha ragione, chi si lamenta è un imbecille. Non c’è cosa più grottesca di un buffone che cerca di sembrare una persona seria; la vetta della piramide è sicuramente occupata dagli scrittori che parlano della propria persona come se fosse interessante. Heh. Gli scrittori che credono nella letteratura ne stanno uscendo pazzi, stanno diventando tutti nazisti o giù di lì. Forse anche io. Pazzo dico, non nazista. La situazione socio-tecnologica è tale da avere ormai minato le condizioni di nascita e sviluppo delle subculture stesse, che si polverizzano nel magma vorticoso di una memetica che, trionfo del trotzkismo, si rivoluziona ogni minuto. Dove si ritrovano, in questo pulviscolo, i quanti di letteratura?»
Si stropicciò la faccia a piene mani, si ravviò i capelli e si tirò su i pantaloni che, senza cintura, tendevano a calare.
«A volte mi piace pensare che nel kebab che sto mangiando c’è una molecola che aveva fatto parte del corpo di Maometto, che nell’aria che sto respirando c’è un atomo già passato nei polmoni di Gandhi, che la fiamma del mio accendino sta bruciando di nuovo una minuscola particella dei capelli di Giovanna d’Arco.
«Noi stiamo assemblando, prefigurando, balbettando il superamento del linguaggio. Quello che era già un diluvio di menzogna impastata nell’odio, è ormai una palude marcia. Ma non possiamo vivere nel rancore. Il mondo è vecchio, vecchissimo. Sentiamo l’indifferenza del pilota d’aereo che vede la metropoli scorrere piccina laggiù.
«Siete stati testimoni, senza vederla, della distruzione di tutti i sistemi. E quando – così lo chiamavate – lo sviluppo della produzione raggiunse il livello estremo di saturazione, quando tutta la superficie, e parte delle profondità, del mondo, furono completamente placcate di cose e in qualunque direzione vi volgeste a guardare scorgevate solo oggetti che nascevano da altri oggetti, come piante fatte di pixel, allora dalle cose cominciarono a nascere idee fatte di cose – in principio le chiamavate icone – e la realtà fu iniettata di una seconda realtà in cui danzavano liberi, ninfe in campo aperto, miliardi di possibili stili, affetti, futuri.
«In quel mare etereo di concrezioni simboliche, compresente, come una dimensione aggiuntiva, col mare corpuscolare delle cose in decomposizione, chi di noi non volle morire si tuffò, e ci dimenticammo non tanto della natura derivata, velare della nuova realtà, quanto della vulnerabilità della precedente: della fragilità delle cose. Andammo a cercare l’eternità in una regione effimera.
«Non mi preoccupo se non mi capisci. Queste parole non sono per te. Tra qualche anno avverrà una catastrofe, e dopo, i sopravvissuti, verranno a ripescare cosa dicevano quelli che la catastrofe l’avevano prevista. E allora sarà importante che tra le cose dette dai corvi ci sarà un’espressione chiara, di una possibilità di rinascita. Questa è la possibilità di agire sulle cose, e persino sul pianeta che rovinano, a partire dal mondo alternativo in cui ci siamo ritirati. L’umanità, collettivamente, si rapporterà col suo pianeta come indossando dei guanti. Sarà capace di lavorare su due livelli. Pensare in sovrapposizione. Non insegneranno più a leggere, ma a guardare in controluce. Non più a scrivere, ma a perforare. Sarà un mondo perfettamente risvoltato.
«Se la fortuna ci assiste, dopo la catastrofe questa consapevolezza prenderà piede, rompendo il ciclo delle morti e delle rinascite capitalistiche. E non sarà particolarmente deprimente se ormai l’aria sarà veleno e i paesaggi saranno deturpati oltre ogni riconoscimento. Tanto potremo sempre evitare di respirarla, di guardarli. Ma senza perdere contatto, perché quello che conterà sarà rappresentato nelle nostre simulazioni. Alla fine riusciremo a guarire il pianeta, e lo faremo divertendoci.
«Abiteremo una foresta lussureggiante, di ficus, sandalo e kapok, in un meriggio dorato che brilla tra il verde sovrassaturo solcato da liane gommose.»
Il giovane retrocedette nell’oscurità senza muovere le gambe. L’ultimo dettaglio a scomparire fu il rosso della sua sciarpa.
Il barista tossì.
«Dove siete finiti tutti?» gridò Testo.
Si voltò qua e là, smarrito.
«Non ci vedo più.»
Mi feci incontro per aiutarlo ma mi respinse:
«Non mi tocchi! Potrebbe essere contagioso.»
Scoppiò a ridere, gorgogliando. Mi accorsi che gli mancavano diversi denti.
«Non ha riconosciuto la citazione? Un intero nido di citazioni? No? Non importa. Andiamo avanti.»
Quel che segue lo pronunciò senza consultare i fogli; impossibile dire se andasse a memoria o improvvisasse; l’unica cosa certa è che nel manoscritto resta traccia solo dell’ultimissima sezione:
«[…] Non va come avevo iniziato a sperare. Il vecchio rimane solo. La storia rimane incompiuta. Il discorso è lasciato per sempre sospeso. (Eccola qua, la verità fonte di ogni verità dell’uomo: ciò che non è accaduto, non potrà mai accadere.) Il mio giovane amico è scomparso, si è dileguato. Non ho fatto in tempo a insegnarti praticamente nulla. Sempreché non fossi tu a insegnare a me. C’è una singola verità universale che noi siamo in grado di pronunciare? No. Eppure andiamo avanti, dobbiamo continuare a lavorare come se fosse possibile farlo, perché un giorno torni possibile farlo, anzi diventi, per la prima volta nella storia dell’umanità, possibile farlo. Solo in quel giorno, mi unirò al coro di quanti invocano “più letteratura”. Non ho altro da dire. Grazie.»
«Credo che ora riuscirà a dormire. Le auguro una buona notte,» disse il vecchio.
«Buona notte, Professore,» dissi e lo guardai caracollare verso l’ascensore. Quando la porta si chiuse dietro le sue spalle, pensai che sarebbe stato il momento perfetto, per lui, di morire. Per questo motivo, quando la mattina seguente il portiere venne a bussare alla mia camera, e mi comunicò che Vincenzo Testo era spirato nel sonno, fui contento di non avergli restituito immediatamente il manoscritto che aveva dimenticato sul banco.
***
[1] Trascrivo dal manoscritto dell’intervento, titolato Letteratura e identità, che è in mio possesso. Purtroppo mutilo: mancano alcuni fogli e non posso nemmeno dire quanti perché le pagine non sono numerate. La carta inoltre è quasi macera, perché Testo mentre leggeva stropicciava i fogli come se cercasse di toccare ciò che non riusciva a udire nelle proprie parole. Mi sono perciò preso la libertà di colmare le lacune più piccole con l’ausilio della mia scadente memoria; le altre sono segnalate dai puntini di sospensione. Si consideri questa una prima difettosa edizione, cui seguiranno certamente proposte filologiche assai al di fuori della mia portata. Gli originali sono a disposizione.