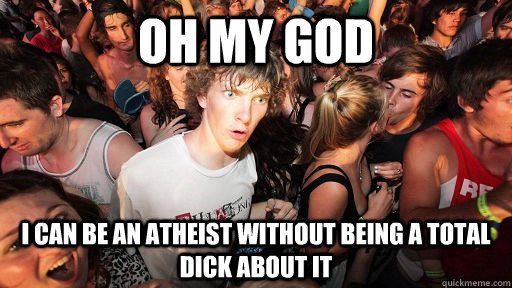
Roma, 23 dicembre 1903
Mio caro signor Kappus,
Lei non deve rimanere senza un saluto da parte mia adesso che è quasi Natale e che Lei, nel bel mezzo della festività, sopporta la Sua solitudine con maggior fatica del solito. Ma se proprio adesso dovesse notare che essa è grande, ne gioisca; perché – se lo chieda – cosa sarebbe una solitudine senza grandezza? C’è solo una solitudine, ed essa è grande e non è leggera da sopportare, e quasi per tutti arrivano quelle ore in cui vorrebbero volentieri scambiarla per una qualche compagnia banale e scontata, per l’abbaglio di un minuscolo accordo con il primo che capita, con il più indegno… Ma forse sono proprio quelle le ore in cui la solitudine cresce; perché la sua crescita è dolorosa come la crescita dei fanciulli, e triste come l’inizio delle primavere. Ma questo non deve farla impazzire. L’essenziale è certo solo questo: solitudine, solitudine interiore grande. Pentrare in se stessi e non incontrare nessuno per ore: ecco cosa si deve raggiungere. Essere soli come si era soli da bambini, quando gli adulti gironzolavano alle prese con cose che parevano importanti e grandi, perché i grandi apparivano indaffarati e non si capiva nulla delle loro azioni.
E quando un giorno si intuisce che le loro occupazioni sono miserabili, i loro mestieri pietrificati e non più connessi alla vita, allora perché non continuare a guardare, come i bambini, a tutto questo come a qualcosa di estraneo, dalla profondità del proprio mondo, dalla vastità della propria solitudine che è essa stessa lavoro, rango e mestiere? Perché voler scambiare il saggio non-comprendere di un bambino con il rifiuto e il disprezzo quando la solitudine è proprio non-comprendere, mentre il rifiuto e il disprezzo sono un modo per prendere parte a ciò da cui ci si vuole separare per mezzo loro.
Caro signore, pensi al mondo che Lei porta in sé e chiami questo pensiero come vuole; può essere ricordo della Sua infanzia o nostalgia del Suo futuro, faccia solo attenzione a ciò che sorge in Lei e lo ponga al di sopra di tutto quel che nota attorno a sé. La Sua storia interiore è degna di tutto il Suo amore, è ad essa che deve in qualche modo lavorare senza perdere troppo tempo e animo a chiarire la Sua posizione alle persone. Perché, chi Le dice che Lei ne abbia una? Lo so, il Suo mestiere è duro e pieno di contraddizione per Lei, e io prevedevo la Sua lamentela e sapevo che sarebbe arrivata. Adesso che è arrivata, io non posso calmarLa, posso solo consigliarLe di riflettere se forse non siano tutti i mestieri così, pieni di pretese, pieni di inimicizia contro il singolo, come impregnati dell’odio di chi si è trovato muto e imbronciato nel freddo dovere. La situazione in cui Lei deve vivere adesso non è più carica di convenzioni, pregiudizi ed errori di tutte le altre situazioni, e se ce ne sono alcune che danno una maggiore libertà all’osservazione, parimenti non ce n’è alcuna in sé ampia e spaziosa e che si relazioni con le grandi cose di cui è fatta la vita vera. Soltanto il singolo, che è solo, è come un oggetto sottoposto alle leggi profonde, e quando esce al mattino, o scruta nella sera che è piena di accadimenti, e sente cosa accade lì, allora ogni situazione scivola via da lui come da un morto, nonostante egli sia nel pieno della vita. Quel che adesso, caro signor Kappus, Lei deve provare in quanto ufficiale, lo avrebbe provato similmente in ogni altro mestiere, sì, persino qualora Lei – al di fuori di ogni posizione – avesse cercato un contatto leggero e indipendente con la società, questa stringente sensazione non Le sarebbe stata risparmiata. Ovunque è così; ma questo non è motivo di paura o tristezza; se non c’è alcuna comunione tra Lei e le persone, cerchi di essere vicino alle cose che non La abbandoneranno; e ancora ci sono le notti e i venti che vanno attraverso gli alberi e sopra molte terre; e tra le cose e gli animali tutto è pieno di eventi ai quali può partecipare; e i bambini sono ancora così, come Lei è stato da bambino, così tristi e felici. E se pensa alla Sua infanzia, vivrà di nuovo tra loro, tra i bambini solitari, e gli adulti saranno nulla, e il loro rango non avrà valore.
E se Le risulta spaventoso e tormentoso ripensare all’infanzia, alla semplicità e alla calma che la accompagnano, perché non riesce più a credere in Dio che lì è presente ovunque, allora si chieda, caro signor Kappus, se davvero Lei abbia perso Dio. Non è semmai il caso di dire che Lei non lo ha mai posseduto? Quando sarebbe accaduto? Crede Lei che un bambino possa possederlo, lui, che gli uomini portano solo con fatica e il cui peso opprime i vecchi? Crede che chi lo abbia davvero possa perderlo come una piccola pietra, o non pensa anche che chi lo abbia, possa essere perso da lui? Ma se Lei riconosce che egli non c’era nella Sua infanzia e neanche prima, se ritiene che Cristo sia stato ingannato dalla sua nostalgia e Maometto tradito dal suo orgoglio, se Lei sente con paura che egli non c’è neanche adesso, in quest’ora in cui parliamo di lui, allora cosa La autorizza a sentire la mancanza di lui, che non c’era mai, come di uno che se n’è andato? A cercarlo, come se fosse perduto?
Perché non pensa che lui sia colui che viene, colui che incombe dall’eternità, il futuro, il frutto inesauribile di un albero le cui foglie siamo noi? Cosa La trattiene dal proiettare la sua nascita nei tempi futuri e dal vivere la Sua vita come un giorno bello e doloroso della storia di un’immensa gestazione? Non vede poi come tutto ciò che accade è sempre un inizio, e non potrebbe essere il suo inizio, dato che l’inizio in sé è sempre bello? Se egli è il sommo, non deve esserci un che di piccolo prima di lui affinché egli possa autodeterminarsi dalla pienezza e dall’abbondanza? Non deve egli essere l’ultimo per abbracciare tutto in sé, e che senso avremmo noi se colui a cui aspiriamo fosse già stato?
Come le api raccolgono il miele, così noi attingiamo da tutto ciò che vi è di più dolce e costruiamo lui. Cominciamo persino con le piccole cose, non appariscenti (se lo si fa per amore), poi con il lavoro e col riposo, col silenzio o con una piccola gioia solitaria, con tutto quel che noi facciamo da soli, senza partecipanti o seguaci, noi iniziamo Lui, che non vivremo, come i nostri avi poco hanno vissuto di noi. Eppure questi antenati da lungo tempo andati sono in noi come un’inclusione, un carico sul nostro destino, come sangue che risuona e come un gesto che si innalza dalle profondità del tempo.
C’è qualcosa in Lui, nel suo essere il Lontanissimo, l’Esterno, che può un giorno toglierLe la speranza?
Caro signor Kappus, festeggi il Natale con il sentimento pio che Lui forse abbia proprio bisogno di questa Sua paura di vivere per cominciare; proprio questi giorni del Suo passaggio sono forse il tempo in cui Lei elaborerà in sé Lui, come già ha fatto da bambino senza respirare. Abbia pazienza e non si irriti, pensi che il minimo che possiamo fare è non rendere a Lui il divenire più difficile di quanto la terra lo renda alla primavera, quando essa vuole venire.
E sia lieto e consolato.
Suo
Rainer Maria Rilke
Tradotto da: R. M. RILKE, Briefe an einen jungen Dichter, mit einem Vorwort von Joachim W. Storck, Zürich: Diogenes 1997

