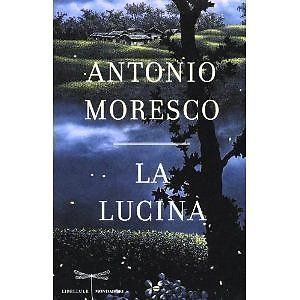
La logica editoriale presenta l’ultimo romanzo di Antonio Moresco “La lucina”, edito da Mondadori, come una storia sospesa tra Leopardi e Il piccolo principe. Ah! La logica!
Capisco la necessità di attirare il lettore a comprare il libro, la rete di librerie reali e virtuali per le quali viaggia l’opera, l’astuzia di fare corrispondere il prodotto alla volontà di chi legge, che vuole immediatamente il paragone. (Mi viene in mente la presentazione, da un altro retro di copertina, a Cosmopolis di DeLillo, dove il romanzo viene introdotto come “un’Odissea contemporanea”. Nulla di più stupido e falso!) Eppure non accetto che un’opera intuitiva, come La lucina, possa essere ridotta a un paragone così misero. Non che Leopardi o Il piccolo principe siano poca cosa, tutt’altro! Dico che il lettore resterà deluso se davvero crede di trovare Leopardi e Saint-Exupéry fusi insieme. Per voi, lettori, in realtà c’è dell’altro!
C’è un uomo che vuole sparire.
C’è un infinita solitudine, che va attraverso le stagioni segnate dalla natura che fiorisce e muore, per ritornare a fiorire. Natura senza memoria, esplosiva e annientatrice e insieme seminatrice del proprio disastro. È la violenza terribile di tutto ciò che è cieco, che non vuole dire istintivo, né le due cose, cecità e istinto, possono convivere. – Che l’istinto sia cieco, in fondo è una superstizione. – E questa solitudine trova nella natura selvaggia, indomabile, lo specchio in cui riflettersi e parlarsi. È una solitudine che porta alla folle impresa di cercare un dialogo con i rospi, le vespe e le radici aeree, invertite, che seminano lo spazio vuoto. Eppure nessuno di questi risponde, solo le rondini. Ecco cosa si dicono, uomo e rondini in coro, come nella tragedia greca:
«Che cosa state combinando?» Ho gridato poco fa.
«Non lo vedi? Stiamo volando! » Mi hanno risposto.
«Sì, sì, questo lo vedo! » grido ancora. «Ma state facendo anche qualcosa d’altro! Volate come non vi ho mai visto volare…»
«Noi voliamo sempre come non ci hai mai visto volare! »
C’è un borgo silenzioso, un cimitero di lumini silenziosi, uno pastore che spala merda e crede agli extraterrestri, tracciando e mappando con un computer la loro presenza tra i boschi. Tutti questi appaiono indifferenti al grande dolore naturale, alla morte che sembra vita – e alla vita che sembra morte. Vivono e muoiono, non chiedono altro e, forse, non vogliono altro.
C’è un terremoto che scuote ogni cosa, un mostro titanico che si attorciglia nelle viscere della terra e il cui rivoltarsi ispira all’uomo solo nel suo letto, di notte, che tutto questo possa finire e anzi non abbia mai smesso, inarrestabile, di finire e iniziare. È questo, pare che suggerisca il terremoto, il mio modo di parlare.
C’è la neve, che ricopre ogni cosa e tutto fa “bianco e oscuro”. È la morte che mette a tacere, che toglie il respiro.
C’è la lucina. Il mistero – e che cos’è questo se non il passaggio, l’apertura (ricordate il terzo libro dei Canti del caos?) tra la vita e la morte? Tra la presenza (l’essere in un luogo) e la non-presenza (non essere più in alcun luogo)? La lucina è la chiave di volta, e io mi chiedo se non è il modo in cui Moresco sia riuscito nel suo intento di superare Kafka?
Dietro la lucina, c’è un bambino. Egli vive da solo. Di fronte alla lucina, a fissarla come un’ossessione, c’è l’uomo, solo. E ci sono alcuni indizi – come se ne possono trovare ne Gli esordi e nei Canti del caos – ad anticipare le loro identità, a creare somiglianza prima dell’unità che, poi, ancora si separa. Eccone uno:
“Ma sì, l’ho trovata!” mi dicevo riprendendo a spostarmi piano lungo quel sentiero stretto attraversato dai rovi che colpivano parabrezza e portiere con i loro lunghi rami pieni di spine, come fruste. “È da lì che viene quella lucina! Da quella finestrella che c’è in alto al primo piano sopra la cucina… riesce evidentemente a filtrare attraverso gli alberi da qualche punto dove i rami sono più distanti fra loro il fogliame più rado. L’accende dall’altra parte della gola quel bambino che vive da solo in mezzo al bosco, in calzoncini corti da cui spuntano quelle magre gambette. Però che strano… non li mettono più i calzoncini corti da un bel po’ di tempo, i bambini!”
Ecco! Il lettore che si aspetta, come da copertina, un ibrido tra il poeta di Recanati e l’esploratore francese, sarà deviato, condotto per sentieri che portano verso qualcosa di più lontano e sconosciuto. Egli non troverà solo il pensiero che affonda infinitamente nel dolore della vita o un bambino, principe di un regno allegorico. Si troverà di fronte, insormontabile e ineluttabile, la natura nella sua totale incoscienza, nel suo silenzio di parole. E, infatti, proprio di fronte a tutto questo irreversibile processo di fioritura e di distruzione – questo eterno ritorno dell’uguale, di tutto ciò che atterrisce – l’uomo tenta una spiegazione:
“[…] Non so gli alberi, i rovi, le feroci paritarie che invadono tutto, e che sembrano sempre uguali a sé stesse, sempre le stesse identiche foglie, gli stessi gambi dallo strano colore rossiccio che si spezzano subito quando li strappi, e intanto il resto della piccola pianta continua inarrestabilmente a germogliare, e più in là sempre le stesse colonne di legno che si innalzano verso la luce. Mentre gli individui della nostra specie appaiono diversi gli uni dagli altri, o hanno solo una parvenza diversa, o è così che noi fantastichiamo che siano mentre li guardiamo attraverso il diaframma deformante dell’atmosfera, dietro il velo denso e nero e increspato dal vento, e cerchiamo di interpretare dalle configurazioni dei loro volti ciò che avviene nell’imbuto buio delle loro vite come quando vediamo trasalire quella schiuma improvvisa che si leva vicino a riva delle onde del mare nero, di notte…”
Infine, c’è la scrittura di Moresco. Una volta, parlando con una Montecchi scrittrice e blogger (in quest’epoca anche le eroine tragiche devono sbarcare il lunario), uscì nel mezzo del discorso un esaltato (e giusto) apprezzamento dello stile del poeta Mantovano. A più riprese da quel giorno mi sono chiesto, se in fin dei conti, ciò che importa è davvero solo lo stile. (Questo in pratica il succo del discorso!) E ogni volta che mi sono posto la domanda in rapporto a Moresco, mi sembrava sempre troppo misera. A che serve uno stile che sa toccare mille corde, se non è sostenuto da un’armonia di intenti? Poi, un altro giorno, in una discussione con una vecchia conoscenza universitaria, è venuto fuori un dibattito sulla scrittura e gli scrittori di confine. Non sto qui a dirvi com’è andata a finire, basta l’argomento di quella discussione e che in mezzo ci fosse anche Antonio Moresco. Allora mi sono chiesto che cosa significasse confine, come un luogo letterario che rappresenta una situazione di mescolanza potesse, proprio per questo motivo, rappresentare anche una armonia di intenti. Non è per puro caso o per la vita che si è vissuta che viene fuori lo stile. L’armonia c’è – come nel jazz modale – ma questa, per dirla con Eraclito, ama nascondersi. Ossia: vuole farsi cercare. E quindi, ribadisco qui una cosa già detta altrove, Moresco si pianta in questo mondo come un saggio antico? E questa velocità di tratteggio, la minuzia dell’ossessione di dire e nascondere, di attendere, non ricorda i poeti siciliani, rinnovati davanti al vuoto e a una nuova luce più terrificante di quella di Dio?
Se non vi ricorda queste e altre suggestioni (o chiamatele come volete) tutte insieme, allora è meglio che vi teniate ben stretta la sensazione di galleggiamento tra Leopardi e Il piccolo principe. Non vi resta altro. Oppure?



