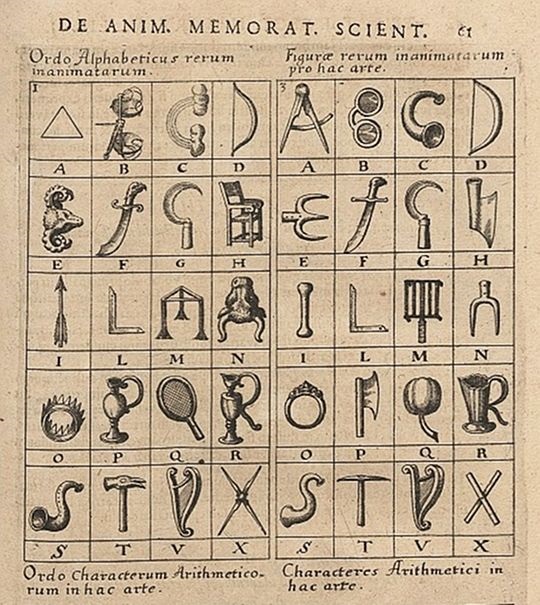Nella sala vi erano sette persone ed erano troppo piccole per uno spazio così grande. Le luci fredde illuminavano la platea assente, il silenzio s’infilava tra gli archi troppo ampi e le panche vuote: alla porta due uomini in divisa s’assicuravano che nessuno potesse oltrepassarne la soglia. Uno dei due indossava un viso grottesco, all’altro calava sul volto una pietà fin troppo umana. Nessuno dei due respirava più del necessario. La voce del Giudice giunse sottile senza nascondere l’interesse per la particolarità del caso in esame. Colpevole senza dubbio, ma di quale reato?
«Vorrebbe ripetermi per l’ultima volta come sono andate esattamente le cose?»
L’imputato era basso, poteva sembrare un bambino e in effetti quasi lo era. Portava i capelli lunghi, legati in una ciocca bionda, e le mani stringevano con forza il banco. Accanto all’avvocato difensore sembrava quasi scomparire, ma non tremava né mostrava timore di sorta. Dopo essersi alzato, lentamente, tornò con passo sicuro alla sinistra del Giudice.
«Devo giurare di nuovo?»
La domanda era così ingenua. Lo stesso Giudice non poté trattenere un sorriso che gli macchiò la faccia. L’avvocato dell’accusa, invece, sembrava essersi stancato e tamburellava nervosamente con le dita sulle carte davanti a sé. Gli eventi gli parevano così chiari, per quale motivo chiedere al ragazzino di ripeterli? Era colpevole, punto. Il Giudice si mostrava fin troppo incuriosito da sottigliezze in cui forse è meglio non immischiarsi. La legge aveva tutto il dovere di compiersi, e in tempi rapidi tra l’altro.
«Non è necessario, proceda pure con il riepilogo dei fatti» acconsentì il Giudice. Il ragazzo prese la parola: le prime lettere gli scivolarono lente, come un fiume che cerca la strada in un letto sabbioso e abbandonato per poi inondarlo senza angoscia quando la via pare sicura.
«Durante il terzo anno delle scuole classiche io ed Eleonora avevamo preso l’abitudine di studiare la filosofia insieme. Lei era molto attenta e io avevo avuto da bambino un maestro di studi: le ore trascorse insieme ci permettevano di imparare molto e in poco tempo. Di lì a poco molti altri nostri compagni di classe decisero di studiare con noi e ne nacque il gruppo di studio. Avremmo dovuto occuparci di tutte le materie, svolgere i compiti del giorno, ma la maggior parte del tempo la trascorrevamo studiando la filosofia. Eleonora era…»
«Obiezione, vostro onore. A che pro far ripetere tutta la storia all’imputato?»
L’avvocato della famiglia Re era nervoso e stanco – o forse soprattutto turbato. Lui che conosceva la ragazzina da sempre provava un immenso dolore ogni volta che il suo nome era ripetuto: rispetto e dovere soltanto lo tenevano lì ad assistere a quella commedia. Il Giudice, d’altra parte, non sembrava per nulla impietosito dalla situazione dell’avvocato e non mosse gli occhi dal ragazzo: continuava a guardarlo senza dare segno d’aver udito l’interruzione. In quella vicenda c’era un errore che non riusciva a vedere e che lo attraeva. Troppi dettagli nell’inquadratura: l’età della vittima, l’età dell’omicida, i racconti dei compagni di classe, la lettera ritrovata tra i seni della ragazza, le dichiarazioni dei presenti e la loro passività al momento dell’omicidio, gli occhi spalancati e l’espressione come d’incredulità sul viso esangue della ragazza, lo stupore del ragazzo una volta accusato, la lenta rassegnazione e la sicurezza, mai venuta meno, di sentirsi innocente. Si trattava di un omicidio, certo. Erano state provocate immani sofferenze, senza ombra di dubbio. Dove si nascondeva l’equivoco? Il suo ruolo gli imponeva un’attenzione speciale. Si rese conto che il giovane non avrebbe continuato senza il suo consenso e solo allora guardò l’avvocato.
«Obiezione respinta. Continui, imputato, la prego.»
L’avrebbe riascoltata finché quell’imperfezione non fosse scomparsa dallo schermo. L’avvocato poteva obiettare quanto voleva. Il ragazzino tornò ad incespicare sulle prima parole poi, con gli occhi fissi nel vuoto, il fiume trovò di nuovo il letto sabbioso.
«L’anno di scuola finì, ma non interrompemmo i nostri incontri. Spesso ci ritrovavamo in casa di Eleonora, facevamo merenda in terrazza e poi restavamo in camera sua a discutere di filosofia. Eleonora amava la libertà, la libera scelta dell’individuo sopra ogni cosa. Per essere liberi bisogna essere forti, diceva, e mi guardava. Io ero forte e glielo avrei dimostrato».
«Ritiene di essere stato invitato a compiere quel gesto?» chiese il Giudice, interrompendolo.
«No, assolutamente no. L’idea di una dimostrazione pratica fu mia, soltanto mia. Si discuteva da tempo e le maggiori critiche venivano mosse dai gemelli Anelli: parole, dicevano, belle parole ma pochi fatti. La filosofia per loro era solo aria. A me non andava di passare per un venditore di fumo, così chiesi a tutti di poter dimostrare la mia forza».
«Fu allora che decise di uccidere Eleonora?»
«Non ho mai deciso di uccidere Eleonora.»
L’avvocato della difesa, che fino a quel momento aveva mantenuto una posa rilassata e conciliante, socchiuse gli occhi mostrando paura, rassegnazione o forse solo stanchezza. In ogni caso restò immobile come il collega mentre la dattilografa teneva il punto del racconto. Tutti sapevano che nulla avrebbe potuto interrompere l’ennesimo riepilogo. Il Giudice non riusciva a comprendere perché dei ragazzini potessero avere così tanto a cuore l’integrità del proprio essere e la limpidezza della propria volontà al punto da mettere in gioco ogni cosa, la vita stessa se fosse stato necessario. Al banco dell’imputato non sedeva né un folle né un criminale. Non capiva, tuttavia riconosceva la necessità del movente, sebbene per la legge non fosse importante il perché ma soltanto il cosa, e in alcuni casi il chi. Chiese, con voce sottile, di spiegarsi ancora: aveva ucciso, senza una decisione premeditata, eppure con la ferma volontà di premere il grilletto. Tutto ciò aveva un senso?
«Chiesi solo di poter dimostrare la mia forza d’animo e le prime prove furono piuttosto banali. Si trattava di baciare la Andrevaldi, di dare un calcio al cane di casa Re, di masticarsi un dito fino a farlo sanguinare. Lo feci e tutti furono soddisfatti, persino i fratelli Anelli. Era un gioco, una provocazione, ed erano stati accontentati. Soltanto Eleonora non lo fu, credo per il bacio alla Andrevaldi».
«Quindi fu mossa da gelosia?»
«Non era così stupida» gli occhi dell’imputato divennero come di fuoco. «Voleva una dimostrazione inequivocabile della mia forza d’animo e anch’io volevo mostrare a tutti come un uomo sia in grado di compiere qualsiasi gesto».
L’uomo in divisa lasciò cadere la maschera grottesca e cacciò una specie di sbuffo, forse un segno di insofferenza. Come poteva parlare così un assassino? Si stava prendendo gioco di tutti e il Giudice lasciava fare. L’età non avrebbe dovuto essere una scusa, anche i giovani devono imparare il dovere.
«Chi trovò la pistola?»
«Eleonora, chiaramente. La pistola era nascosta nello studio del padre, in un cassetto di cui solo lei era a conoscenza, e la portò in camera senza il nostro consenso. Nessuno di noi sapeva dove fosse andata a finire: sparì per poi tornare con la pistola. La posò sul tavolo e ci guardò uno per uno. Gli altri erano spaventati. I gemelli chiesero cosa volesse farci e quando lei parlò pensarono che stesse scherzando. La filosofia era una cosa da libri di scuola, mica una roba da morirci. Lei fu inflessibile, loro si pentirono di aver iniziato quello scherzo».
«Così Eleonora portò l’arma e lei la impugnò?»
«Chiesi di poterla toccare e lei mi domandò se ne avessi il coraggio. Le risposi che la forza d’animo è imbattile, ma che avevo paura delle conseguenze.»
«Aveva paura di essere condotto in carcere?»
«No, avevo paura di essere accusato d’omicidio. Non sono un assassino.»
Sopra lo scranno del Giudice un raggio di luce raggiunse la parete. Per un breve momento le lettere d’oro incastonate nel marmo brillarono come nuove. La legge è uguale per tutti. Poi l’ombra del giorno piombò di nuovo nella stanza.
«Non avrei mai ucciso Eleonora se lei non me l’avesse chiesto.»
«Conferma quindi che fu lei a proporsi?»
«Certo, confermo quanto già detto e quanto credo abbiate già letto nella sua lettera. Presi l’arma e la puntai contro ognuno dei presenti, chiesi loro di firmare un lasciapassare. Nessuno mi prese sul serio. Dicevano che non ne avrei avuto il coraggio e la forza di premere il grilletto, ma allo stesso tempo nessuno si offrì spontaneamente. Finché Eleonora non prese carta e penna e iniziò a scrivere. Quello che scrisse potete leggerlo nella lettera che si pose sul petto.»
«Fu una mia scelta. Muoio per dimostrare il potere dell’uomo. Non accusate Luigi Onuto di omicidio perché non ve ne fu. Eleonora Re.»
«Queste stesse parole.»
«E dopo che ebbe terminato la lettera, come andarono le cose?»
«Sparai.»
L’ultima parola esplose dalla bocca di Luigi. Il Giudice si tastò l’addome con entrambe le mani, tirò un lungo sospiro e come sconfitto o rassegnato parlò per l’ultima volta.
«Si ritiene colpevole?»
«Eleonora mi amava e per questo si è offerta. Se sono colpevole, è d’amore e di volontà.»
Il silenzio tornò a riempire la sala. Le dita della dattilografa avevano terminato la corsa, nulla più sarebbe stato detto.
Il sette settembre millenovecentosettantasette morì la napoletana Eleonora Re, sedicenne figlia del ricco impresario Armando Re, per via di un colpo di pistola sparato a corta distanza dall’amico fraterno Luigi Onuto, di anni diciassette e nipote del filosofo Ugo Bruto. Le reali motivazioni dell’omicidio restano ignote – presunta una lite amorosa –; la lettera ritrovata tra i seni della vittima del delitto è da considerare con buona probabilità un falso. La famiglia Re si rammarica per il triste destino della ragazza. Nessuna dichiarazione, invece, da parte della famiglia Onuto. Il filosofo Ugo Bruto, intervistato dall’inviato del Mattino, ricorda che è dall’alba dei tempi che l’uomo uccide il proprio fratello per eccessi di filosofia.
***
In copertina: John Dyer Baizley, artwork