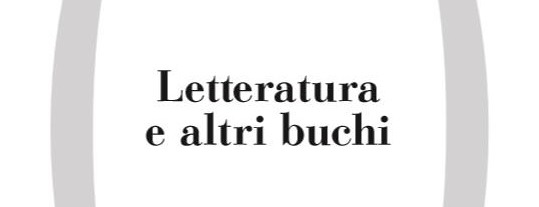
Razziddu Buscemi, avvocato in pensione, agonizza in West Virginia. Intanto si racconta, solo, e la sua è “litania” dichiarata, cioè, secondo etimologia, «supplica», «preghiera» rivolta a Maria e ai santi per ricevere una benedizione o per placare l’ira divina:
“Ora, pieno di morte, mi sforzo di parlare, tramite la debolezza, per saggezza. Sotto forma di litania, invaso dalla mia fine ultimativa.” (p. 11)
 Lo Scuru, romanzo di esordio dello scrittore siciliano Orazio Labbate (classe ’85), ha inizio con la fine, una fine che invade il protagonista in quanto tutto pervade: mentre muore Razziddu “gli animali stanno morendo. I campi non sanno più annerirsi”, “la gente aveva le facce incavate come teschi di coyote” (p. 10), “la fattoria rossa perde vernice dal tetto isoscele” (p. 11).
Lo Scuru, romanzo di esordio dello scrittore siciliano Orazio Labbate (classe ’85), ha inizio con la fine, una fine che invade il protagonista in quanto tutto pervade: mentre muore Razziddu “gli animali stanno morendo. I campi non sanno più annerirsi”, “la gente aveva le facce incavate come teschi di coyote” (p. 10), “la fattoria rossa perde vernice dal tetto isoscele” (p. 11).
Da qui principia la memoria del morente.
Butera, terra d’origine di Labbate, è il luogo dove tutto sembra accadere. Sembra, perché la memoria, è provato, è una particolare forma di tradimento della realtà: dice David Shields, “ricordo e invenzione sono indistinguibili” (Fame di realtà, Fazi, 2010, p. 71) e, citando qualcuno che lui stesso non ricorda — andando, dunque, a memoria —, “nel ricordo il suo paese diventava immaginario” (Fame di realtà, p. 72). Per quanto Razziddu si sforzi di parlare per saggezza, utilizzando una mezza lingua (siciliano fuso all’italiano), per quanto dica di contare su un verbo meno confuso rispetto alla giovinezza, egli sa che, tuttavia, la sua vista ha perso in chiarità, sa che tutto vede sfuocato.
Tutto è fuoco e tutto è fuori fuoco: in questo paradosso la narrazione nasce offuscata, cerca affannosamente snodi, ossigeno per bruciare e far luce sugli eventi.
Il giovane Razziddu, di poche parole, solo come una bestia nonostante (o proprio per) tutto quanto lo circonda — streghe, maghi, preti, familiari e la statua —, ricerca la verità sulla morte di suo padre, ma la ricerca, in un mondo che da ogni lato gli si mostra eccentrico e in un tempo sempre in procinto di deflagrare, non può che coincidere con un processo di conoscenza di se stesso e del suo mondo e del suo tempo. E poi con la scoperta dell’amore, magia tra le magie, fuoco tra i fuochi, una potenza esterna che ostacola l’oscuro cammino del ragazzo, una potenza vivificatrice che si oppone alla sua passione per la morte (“Io sono un pescatore e pensu solo a morti, Rosa. Sulu ai morti”, p. 58).
Ma lo Scuru non è solo la cappa di oscurità che grava su quanto è ricordato/narrato da Razziddu, lo Scuru è anche un’entità, un enigma, e l’enigma, si sa, può coincidere con la mostruosità. Il tema principale del romanzo, eluso — come è naturale in questa storia eccentrica — dalla ricerca della verità sulla morte del padre, concerne proprio tale presenza spaventosa e inafferrabile, un’ombra che appare (il tòpos del Doppio?), che viene più volte evocata, che sfugge; il completamento della ‘formazione’ di Razziddu dipende dalla sorte di questa entità. Dopo lo Scuru c’è la vita che non ha ragione di essere raccontata, e lo Scuru è il fondamento della litania, la sua ragione d’essere. Da qui si torna al principio, alla fine ultimativa, l’enigma pare risolversi e il lettore può destarsi dall’incubo rassicurato — a meno che l’enigma, il mostro, lo Scuru, non sia fuggito: da un essere duplice, si sa, ci si può aspettare tutto, eccetto la verità.
Orazio Labbate, Lo Scuru, Tunuè, 2014.



