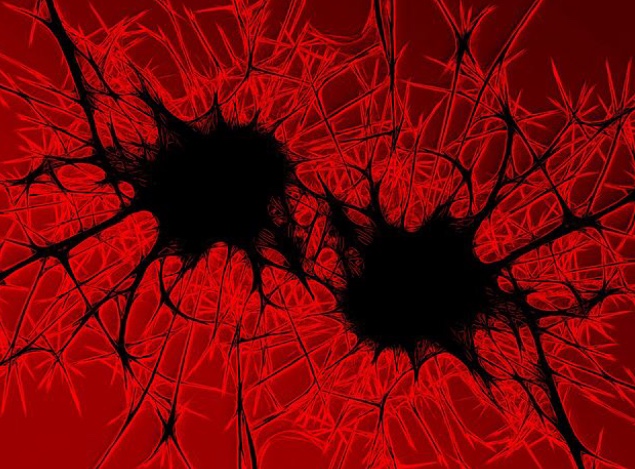Poi siamo andati al Carrefour. Dovevo mangiare qualcosa per placare la chimica, in più i lampioni fulminati intorno alla stazione mi stavano facendo salire le paranoie nere, come se la notte dovesse divorare tutto da un momento all’altro.
Là dentro invece c’erano le luci bianche; le corsie e la roba in perfetto ordine mi davano l’impressione che non stesse andando tutto a puttane, che ci fosse ancora un senso netto delle cose.
Andrea era accanto a me. Non parlava da quasi mezz’ora. A volte gli prendeva così ultimamente, consumava la sua parte in due o tre tiri e ce lo perdevamo per tutta la sera.
Una volta glielo dissi: zio, se ti chiudi così è difficile venirti a ripigliare, un giorno di questi ci toccherà scassinarti la testa per tirarti fuori quella poltiglia che chiami cervello, poi chi glielo dice a Carla. Quella volta rispose: hai ragione, cazzo se hai ragione, poi il sorriso gli si era spento quando gli avevo ricordato che stava per diventare padre e doveva smetterla con le cazzate.
Dovevamo smetterla tutti.
Eppure eravamo lì, a vagare fra salamini Beretta, sottilette Kraft e montagne di Red Bull bianche, verdi, rosse, blu.
Andrea è rimasto un po’ davanti alla pila delle lattine. Per un attimo ho pensato volesse tirarle giù, poi si è voltato, ha abbozzato un ghigno e si è diretto allo scaffale delle patatine. L’ho seguito. Era pieno di buste, pacchi e confezioni colorate. Ho preso a toccare tutto con le mani, volevo sentire la consistenza della roba che stavo per mangiare, per essere sicuro della sua reale esistenza. Mi si è fatto vicino, ha annuito fissando qualcosa e si è messo a toccare pure lui la roba. Ci appoggiava l’orecchio per sentirla crepitare sotto le dita.
Quando si è girato verso di me aveva uno sguardo allucinato. Non lo so che cazzo s’era pippato quando stavamo al parco. Quel maledetto aveva aspettato che fossi troppo rincoglionito prima di tirare fuori la stagnola. Tutto quello che ero riuscito a fare era stato osservarlo tirare sul col naso. Aveva avuto uno scatto di convulsioni, ricordo di aver pensato cristo, mo’ questo ci lascia la pelle. Invece un paio di calci a terra e s’era ripreso, aveva fatto due passi e urlato che cristo santo la vita fa schifo ma ’sta roba ti strappa l’anima dal corpo. Hai fame? aveva detto. Io sto morendo.
E ora aveva il diavolo negli occhi. Io stavo lì col tubo delle Pringles in mano, indeciso fra quelle gialle e quelle verdi. Lui continuava a frantumare le Puff in silenzio. L’ultima volta che l’avevo visto così concentrato era stato ai tempi della maturità, che se lo bocciavano il padre lo cacciava di casa e invece alla fine aveva preso più di me.
Poi dal nulla, come riprendendo un discorso che non avevamo mai cominciato, ha detto comunque Cla’, c’è toccata l’epoca peggiore.
Ho aspettato qualche secondo per accertarmi che quella voce fosse uscita proprio dalla sua bocca. Poi ho chiesto: quale epoca?
L’epoca delle cose, ha detto con fermezza.
Ma di che parli?
Ho visto la tristezza scendergli nello sguardo, poi ha allargato le braccia, ha fatto un giro su se stesso come una ballerina di danza classica sgraziata e ha detto: non lo vedi?
Che dovrei vedere?
Cristo santo, ha detto, non lo vedi che viviamo su un’isola di promesse impacchettate, sottovuoto, catalogate, etichettate, tutte cose finte – la vedi qui la scritta l’immagine ha il solo scopo di rappresentare il prodotto? Ma veramente ci fanno così rincoglioniti da dover scrivere ’sta pagliacciata? Non c’è niente di vero qua dentro. Viviamo su un’isola di promesse impacchettate, ha ripetuto, e là fuori c’è solo il merdoso nulla in cui far crescere i nostri figli.
Wow, gli ho detto. Roba profonda, Andre’.
Profonda un cazzo, è una verità che tutti abbiamo davanti. E mi terrorizza l’idea di essere il solo a pensarla così. Guarda qua, guardati intorno: ci sono cose ovunque, siamo circondati, non potremmo liberarcene neanche se sprofondassimo dentro una qualche fossa oceanica.
Gli ho messo una mano sulla spalla e l’ho sentito scattare. Mi ha guardato di nuovo con quello sguardo. Ora prendo queste e ce ne andiamo, ok? gli ho detto. Prenditi qualcosa pure tu, così smaltisci e ti riprendi.
Fissava la mia mano senza dire niente. Poi ho capito che non era la mano a interessargli, bensì l’orologio. Segnava mezzanotte passata.
Lo vedi, ha detto, questo coso ci dice che fra sei ore dovremo essere in piedi per andare a lavorare, così a fine mese possono darci i soldi per comprare altre cose.
Andre’, calmati.
Mi calmo un paio di palle, ha urlato schiaffeggiandomi la mano. Ovunque mi giri ci sono cose che cercano di fregarci con i loro slogan da coglioni, le offerte tre per due, gli sconti speciali, le promozioni valide dal al per riempirci i frigoriferi e poi farle scadere così poi dobbiamo buttare tutto e ricominciare da capo.
Guarda che non sei obbligato a comprare la roba che non ti serve.
È uguale, ha urlato, lo capisci o no? Quando mangiamo le cose i conservanti ci entrano dentro, ci attraversano, diventano parte di noi. E poi compriamo la carta igienica – questa con la volpe, la vedi quant’è carina la volpe? – e ti restano i pezzi attaccati al culo, e quando usiamo i telefoni le radiazioni si fissano nei neuroni e ci fanno venire i tumori. Le cose siamo noi, cristo, siamo noi.
No Andre’, noi non siamo cose: noi siamo vivi, vedi che ci muoviamo e parliamo mentre loro se ne stanno immobili là sopra? Siamo noi a decidere cosa fare.
Mi ha guardato con appena un barlume di ragione dietro le pupille. Hai ragione, ha detto, hai ragione da vendere amico, siamo noi a decidere cosa fare di tutto questo.
Poi mi ha spinto via e ha preso a tirare giù roba dagli scaffali. Afferrava i pacchetti e li scaraventava a terra, oppure li strappava e buttava tutto all’aria. Io stavo lì, incapace di fare alcunché, a osservare la tempesta di patatine e salatini che mi volavano intorno. Con una manata ha svuotato tutta una fila di lattine e bottiglie di birra, che hanno preso a esplodere e schizzare ovunque, finché sul pavimento si è formata una melma giallastra, e intanto lui diceva ecco, guarda come si agitano, guarda qua quanta vita.
Poi è rimasto immobile a guardare lo spettacolo che aveva creato, gli occhi così gonfi che credevo gli sarebbero esplosi fuori dalle orbite.
Neanche un minuto dopo è comparsa la sicurezza. L’ho vista svoltare l’angolo, fermarsi a guardare tutto quel casino e alzare il mento verso di noi. Ci ha urlato qualcosa contro, ma intanto avevo già preso Andrea per il braccio, gli ho detto andiamo, qua chiamano le guardie, allora si è ripreso dalla catatonia e mi è corso dietro mentre l’uomo ci inseguiva.
Ci siamo scapicollati sul cavalcavia inciampando sui gradini, sotto di noi i binari del treno erano due spine dorsali di ferro. Ci siamo fermati dall’altra parte, entrambi col fiatone e piegati sulle ginocchia.
Come stai? gli ho chiesto. Lui s’è voltato a guardarmi, ha sorriso e ha alzato il pollice. Allora gli ho dato una pacca, poi mi sono guardato intorno e ho detto andiamo alla macchina, torniamo a casa.
Ho guidato piano e in silenzio, ancora col buco allo stomaco e la testa leggera. Vedevo tutto sfocato e avevo l’ansia che qualcuno ci fermasse per chiederci i documenti.
Sotto casa sua gli ho chiesto di nuovo come stesse. S’è lambiccato con la cintura e intanto diceva tutto ok, tutto ok, è l’ultima volta che compro quella merda. Gli ho chiesto che diamine fosse, lui ha farfugliato qualcosa che non ho capito e io non ho insistito.
È sceso, s’è messo a pisciare sull’albero accanto al portone di casa. Lo guardavo, ingobbito e concentrato per dirigere il getto.
Poi è tornato, si è sporto dentro appoggiandosi allo sportello. Grazie del passaggio, zio.
Figurati. Mo’ va’ a dormire, ne hai bisogno.
Domani è lunedì.
Appunto.
Non ce la faccio, Cla’.
A fare cosa?
A vivere così.
Che gli rispondi a uno che ti guarda in quel modo? Prima lo sguardo allucinato mi aveva spaventato, ora se ne portava dentro uno peggiore. Aveva lo stesso terrore che si legge negli animali dei documentari poco prima che vengano sbranati. Andrea era una gazzella e la sua esistenza la leonessa acquattata.
Tutta questa fatica serve a qualcosa, gli ho detto. Pensaci.
Non serve a niente, Cla’. Ci siamo lasciati. L’ho fatta abortire. Non lo voglio crescere un figlio in un mondo come questo.
Gli ho detto di risalire, di andare a prenderci una birra per parlarne. Mi ha detto che era stanco, anzi esausto. Ha detto proprio esausto, come le batterie delle macchine.
Siamo rimasti che ci saremmo visti stasera per raccontarmi com’erano andate le cose. Così sono tornato a casa, in cucina mi sono preparato un panino col salame ma poi l’ho lasciato a metà e mi sono buttato sul letto.
Poco prima di addormentarmi, mentre già la realtà diventava liquida e si affollava di immagini, ho ricevuto un suo messaggio. Mi ringraziava di averlo riportato a casa e si scusava ancora. La botta gli era calata e ora che vedeva tutto con lucidità aveva chiaro cosa dovesse fare. Gli ho risposto che doveva stare tranquillo, che le cose si sistemavano, bastava volerlo. Noi – tutti noi, gli amici eccetera – c’eravamo sempre.
Quando mi sono svegliato stamattina, dopo essere andato in bagno a pisciare e aver messo su un caffè che ho buttato giù insieme a una bustina di Oki, ho acceso il telefono e l’ho chiamato. Non ha risposto e ho pensato che fosse ancora collassato sul letto.
Poi ho aperto WhatsApp e lì ho trovato il messaggio. Ci pensi a quando tutto sarà morto e il mondo sarà abitato dai sacchetti di plastica? aveva scritto verso le tre e qualcosa.
A quell’ora ero sprofondato in un sonno durissimo. Quello che è successo dopo me l’ha raccontato suo padre poco fa, mentre ero sull’autobus per andare al lavoro. Dopo avermi scritto è uscito di casa, è tornato al Carrefour, ha preso l’alcol e spacchettato un accendigas e si è dato fuoco. I paramedici l’hanno trovato carbonizzato, la pelle e la carne fuse con la plastica delle confezioni dei pannolini, circondato dai sorrisi di centinaia di bambini che lo guardavano dagli scaffali.
Commenti