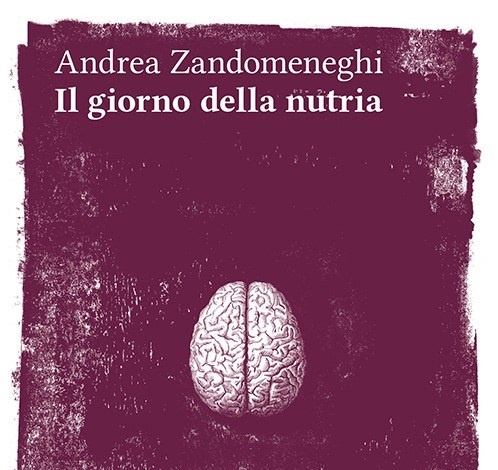Dieci giorni dopo la fine della guerra mia sorella Laura volò giù da un ponte con un’automobile.
L’assassino cieco è un romanzo che non va letto, ma va scavato. Quella che dà il titolo al libro è solo una delle storie raccontate da Margaret Atwood, una storia nella storia, narrata da un personaggio che viene narrato a sua volta, e che offre una chiave di lettura sia della voce narrante principale che dell’oggetto della narrazione.
Lo scavo è necessario a districare i legami tra il racconto della vita di Iris Chase, una vecchia signora amareggiata e sarcastica, la narrazione che Iris stessa fa della sua vita e della sua famiglia e la storia dell’Assassino cieco; il tutto intervallato da altre interpretazioni di una vicenda misteriosa, da narrazioni solo in apparenza più oggettive delle altre, articoli di giornale che nella loro pretesa di esaustività danno invece solo una versione molto parziale (ed edulcorata) di ciò che è raccontato da Iris.
Anche se in fondo c’era l’amore, era sepolto sotto un gran cumulo di cose, e che cosa puoi trovare, una volta che ti metti a scavare? Non un semplice dono d’oro puro e scintillante; no, qualcosa di antico e magari di funesto, come un amuleto di ferro che si arrugginisce tra vecchie ossa. È un talismano che non vale granché, questo amore, ma è pesante; un arnese pesante; un arnese pesante da portarmi dietro, appeso alla sua catena di ferro attorno al collo.
Sembra che Atwood inviti chi legge non tanto a cercare una verità univoca, quanto a intersecare le diverse diramazioni della verità, diramazioni che non assumono mai un carattere inoppugnabile, ma si rivelano sempre fragili, pronte a essere sgretolate da un nuovo punto di vista, da un nuovo racconto, da una qualsiasi voce o dall’assenza di questa voce; tutto questo genera un mormorio costante e inquieto, sempre nervoso, sempre tormentoso, irresolubile.
Se vivere equivale a rielaborare i fatti, la consolazione è che non esiste storia abbastanza mastodontica e coriacea da non poter essere inghiottita dall’oblio, dalla morte, da un niente che è l’unico pacificatore concesso a chi ha il peso di dover raccontare tutto, di racchiudere e ricreare le storie che ha vissuto, rielaborato, raccontato e raccontato di nuovo, sempre uguali e sempre diverse, accomunate dall’inattendibilità, dalla loro inefficacia nel dare una qualsiasi spiegazione del momento presente, del dolore passato, degli errori, di tutto.
Anche rielaborare il fatto, raccontare una storia completamente nuova in un mondo completamente nuovo, come succede nel racconto di fantascienza contenuto nel romanzo, L’assassino cieco appunto, non chiarifica, ma complica: creare una storia per un altro è un qualcosa che stratifica i non detti, non rivela e non nasconde, ma al massimo camuffa, permettendo un’onestà che però non porta da nessuna parte.
Che dire di quelli che seminano indizi perché noi ci inciampiamo? Perché si prendono questa briga? Egoismo? Pietà? Rivincita? Una semplice affermazione di esistenza, come scarabocchiare le proprie iniziali sul muro del bagno? La combinazione di presenza e anonimato – confessione senza penitenza, verità senza conseguenze – ha il suo fascino. Ti toglie il sangue dalle mani, in un modo o nell’altro.
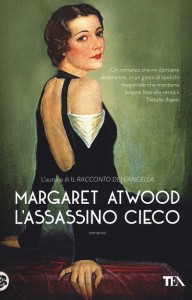 Tuttavia narrare, sembra dirci Atwood, è l’unico atto che riesce a dare un senso al nostro barcamenarci nella vita, un qualcosa che dà un ordine, per quanto illusorio, a un caos per noi inconcepibile, una qualche solidità alla nostra vita pur rivelandone l’irrilevanza e la fluidità. Perché raccontare, e raccontarcela, e partecipare ai racconti altrui, e farli nostri, forse equivale a vivere nella sua forma più pura e onesta.
Tuttavia narrare, sembra dirci Atwood, è l’unico atto che riesce a dare un senso al nostro barcamenarci nella vita, un qualcosa che dà un ordine, per quanto illusorio, a un caos per noi inconcepibile, una qualche solidità alla nostra vita pur rivelandone l’irrilevanza e la fluidità. Perché raccontare, e raccontarcela, e partecipare ai racconti altrui, e farli nostri, forse equivale a vivere nella sua forma più pura e onesta.
Margaret Atwood
L’assassino cieco (2000)
Trad. it. Raffaella Belletti
Milano, TEA, 2018
pp. 634