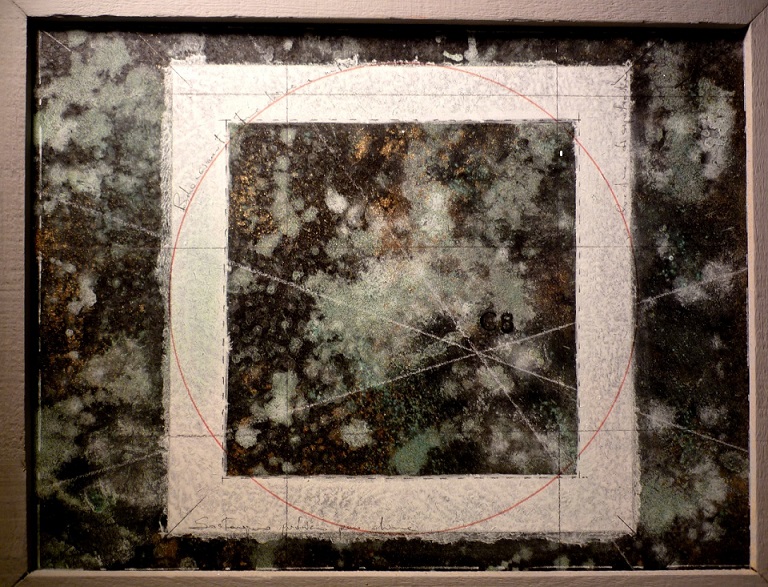L’intervista di Carlos Dámaso Martínez a Ricardo Piglia, realizzata il 15 Settembre 1985, è stata pubblicata in El arte de la conversación: Dialogo con Escritores Latinoamericanos (Alción, 2007) di Dámaso Martínez e in Crítica y Ficción (Anagrama, 2006) di Piglia, ed è tuttora inedita in Italia. Ringraziamo gli autori per averci autorizzato e tradurre e pubblicare il testo su CrapulaClub.
La traduzione è di Alfredo Zucchi.
Carlos Dámaso Martínez: Hai studiato storia all’Universidad Nacional de La Plata. Qual è il rapporto tra questa scelta e il tuo mestiere di narratore?
Ricardo Piglia: Scelta è una parola grossa. Quando m’iscrissi all’università volevo essere uno scrittore – o meglio, dicevo di volerlo essere. Avevo diciotto anni, avevo scritto due o tre racconti, leggevo e rileggevo Faulkner e scrivevo un diario privato che facevo leggere a tutti. E pensavo che se davvero si vuole scrivere, la cosa migliore è non studiare Lettere. Senza accorgermene stavo affrontando una questione complicata: come si forma uno scrittore? Difficile saperlo. Di sicuro c’è bisogno, sempre, di una deviazione, di un movimento egocentrico, di prendere strade laterali. Gli studi di Lettere sono fortemente centripeti, illudono che la letteratura sia classificata e ordinata. Quando uno invece comincia scrivere, legge in modo sempre più arbitrario. Bisogna cercare di rispettare questa arbitrarietà, che è il marchio stesso della passione per la letteratura.
CDM: Perché parli di lettura arbitraria?
RP: Intendo dire lettura funzionale. Ricordo che ritornavo ogni volta sui libri che mi piacevano – mi intrigava la domanda: come funziona questa cosa? Come si può costruire una cosa del genere? Come se fosse un oggetto meccanico, con viti e ingranaggi, da smontare. Il cono di Bernhard, diciamo, il cono di Tlön.
CDM: E questo presuppone una relazione non del tutto sistematica con la letteratura.
RP: Una relazione diversa. Se io voglio essere scrittore, non ho intenzione di leggere tutta la letteratura; voglio trovare i libri che mi interessano, che mi servono – e questo è sempre arbitrario. Prendiamo ad esempio la letteratura argentina: quanti libri possono essere letti per quello che valgono, sarebbe a dire che possono essere letti al posto di qualunque altro libro di qualunque altra letteratura? Diciamo venti, non di più, cominciando dal Facundo di Sarmiento. Per essere precisi, direi quindici libri: questi rappresentano tutta la letteratura argentina. Il resto sta lì, fa parte della storia, va bene, va molto bene, però è un’altra cosa. Ogni scrittore ha la sua biblioteca eccentrica – che cambia, si trasforma, però alla quale resta fedele.
CDM: Il progetto e le intenzioni che avevi allora erano diversi da quelli della Facoltà di Lettere.
RP: Direi che intuivo ciò di cui non avevo voglia. Non volevo annoiarmi sopportando le varie storie della letteratura e leggere letteratura per dare esami non mi sembrava interessante. Preferivo tenere la letteratura a parte e studiare altro, allora scelsi storia. Allo stesso tempo, scoprivo in quel periodo la letteratura nordamericana, e non avevo intenzione di leggere altro.
CDM: Leggevi in traduzione?
RP: No, prima di iscrivermi all’università avevo studiato inglese. C’era un personaggio fuori dal comune allora a Mar del Plata, Steve Ratliff, un nordamericano – tutti lo chiamavano “l’inglese”: lavorava nell’export del pesce, era stato amico di Conrad Aikien e aveva studiato con Eliot e non faceva altro che parlare di letteratura nel “Ambos Mundos”, un ristorante dove si mangia stufato che all’epoca aveva un bar all’ingresso. Fu lui a parlami per primo di Scott Fitzgerald: mi prestò Il grande Gatsby in una vecchia edizione di Scribner’s, piena di note e ricoperta di carta verde. Mi ero messo a studiare inglese e in poco tempo ero in grado di leggerlo, per quanto il primo testo che lessi per intero in lingua fu un racconto di Hemingway, “After the storm”. Ratliff aveva l’occhio fino, gli piaceva molto Hortense Calisher, ad esempio.
CDM: Ratliff quindi è stato come un mentore per te.
RP: Sì, è stato una specie di maestro involontario. Grazie a lui ho conosciuto la letteratura nordamericana: in modo ironico e aggressivo orientava le mie letture. Era un uomo colto, raffinato, sedotto dal mito – così nordamericano – della vita vissuta, dell’esperienza: s’imbarcò per conoscere il mondo, passò un anno a navigare, ebbe una storia tragica con una donna di Buenos Aires e decise di restare in Argentina. Era una specie di grande scrittore fallito, se mi passi l’ossimoro – o la tautologia. Non pubblicò niente a parte un racconto sul New Yorker, però passo la vita a scrivere. Nell’epistolario di Aiken il suo nome compare varie volte.
CDM: In che anno ti sei iscritto all’Università de La Plata?
RP: Nel ‘60. Andò bene: studiare storia mi permetteva di mantenere questa relazione di distanza e prossimità con la letteratura che stavo cercando. Uno storico è quanto di più vicino ci sia a un romanziere – registra i mormorii della storia, i suoi materiali sono una trama di finzioni, di storie private, di resoconti criminali, di statistiche, e bollettini di guerra, testamenti, relazioni confidenziali, lettere segrete, delazioni, documenti apocrifi. La storia è sempre appassionante per uno scrittore, non solo per gli elementi aneddotici – le storie che circolano, la lotta tra interpretazioni diverse – ma anche perché ci si imbatte in una moltitudine di forme narrative e modi raccontare.
CDM: Quando dici diverse forme di narrarazione a cosa ti riferisci?
RP: L’archivio come modello narrativo, ad esempio: la tensione tra materiali diversi che convivono annodati a un centro che è precisamente ciò che bisogna ricostruire. È una specie di poliziesco al contrario: tutti i dati sono lì, ma non si riesce a capire quale sia l’enigma da decifrare. Gli storici – questo è certo – lavorano sempre con la finzione, e la storia stessa è la proliferazione retrospettiva dei mondi possibili. Di norma preferisco i libri di storia ai cosidetti romanzi storici. Busaniche, ad esempio, è un grande narratore. E che dire allora del libro di Leroy Ladurie su Montaillou? È come un romanzo di Joyce scritto nel ‘300.
CDM: Di recente ho pensato a una frase di Respirazione artificiale, quando Maggi dice: “La storia è l’unico luogo in cui riesco a trovare conforto dall’incubo da cui cerco di svegliarmi”.
RP: Si tratta, è chiaro, di una inversione della frase di Joyce, di Stephen Dedalus in realtà, “la storia è l’incubo da cui cerco di svegliarmi”. Maggi la trasforma per Renzi, gli manda una sorta di messaggio cifrato – l’incubo, senza dubbio, è nel presente, nel 1976. E la storia è quel luogo in cui si vede che le cose possono cambiare e trasformarsi. In momenti in cui sembra non si dia uscita, e l’incubo del presente pare eterno, la storia, dice Maggi, prova che ci sono state situazioni analoghe, in cui si riuscì, alla fine, a trovare una via d’uscita. I tratti del futuro si trovano nel passato, il flusso calmo dell’acqua della storia scalfisce le pietre più dure. Maggi è un pensatore inattuale, in controtendenza rispetto al nichilismo deliberato che circola oggi. Di questi tempi va di moda lo scetticismo e la sfiducia nella storia. Circola il kitsch Cioran, direbbe Renzi, e persino Víctor Massuh è nietzscheano.
CDM: Tieni un diario da più di vent’anni: è un tentativo di scrivere la tua propria storia, o quale altra storia?
RP: La mia storia, come fosse quella di un altro. Il diario, senza dubbio, è un genere comico, converte automaticamente chi lo scrive in un clown. Una persona che scrive la sua storia giorno dopo giorno è una cosa abbastanza ridicola. È impossibile prendersi sul serio. La memoria serve per dimenticare, lo sanno tutti, e il diario è una macchina per lasciare tracce. Mi piacciono molto i primi anni del mio diario, perché lotto contro il vuoto totale: non succede nulla, non accade mai nulla in realtà, però allora mi preoccupavo, ero molto ingenuo, ero sempre in cerca di avventure straordinarie. Cominciai a rubare esperienze ai miei conoscenti, le storie che io immaginavo vivessero quando non erano con me. Scrivevo bene all’epoca, sia detto per inciso, molto meglio che ora, avevo una convinzione assoluta – la miglior garanzia, sempre, per costruire uno stile.
CDM: E che relazione hai ora con il tuo diario?
RP: Le cose sono cambiate nel tempo, ora è un po’ il laboratorio della finzione. Dico sempre che pubblicherò altri due o tre romanzi per rendere possibile l’edizione di questo diario che è diventato il centro della mia scrittura. È che la forma diario mi piace molto – la varietà di generi che si mescolano, i diversi registri. Il diario è l’ibrido per eccellenza, una forma estremamente seducente: combina relazioni, idee, note di lettura, polemiche, conversazioni, appuntamenti, diatribe, frammenti di verità; mescola politica, storie, viaggi, passioni, conti, promesse, insuccessi. Mi sorprendo, ogni volta che ci torno, di come tutto si possa scrivere, ogni cosa possa diventare letteratura e finzione.
CDM: Questo è anche il modello di Respirazione artificiale.
RP: In un certo senso sì. Eppure questo libro mi pare ancora troppo tradizionale. Bisognerebbe poter scrivere un romanzo che si leggesse come un trattato scientifico e come la descrizione di una battaglia, ma che fosse allo stesso tempo anche un poliziesco e una storia politica. Roberto Arlt ne sarebbe stato capace, ma morì troppo giovane.
CDM: A partire da questa idea del romanzo, si può dire che tu faccia anche una lettura, una ricognizione sullo stato del genere in Argentina.
RP: Si tratta di una serie di ipotesi sulla costituzione e lo sviluppo del genere in Argentina. Il romanzo presenta alcuni tratti unici, specifici e credo si possa parlare di una maniera “nazionale” di usare la finzione che viene da Sarmiento e arriva fino a Macedonio Fernandez e Marechal. Il nucleo è una relazione molteplice, ma sempre presente, tra finzione e politica, legame che definisce determinate forme molto specifiche. Mi interessa sempre di più studiare il luogo della finzione nella società perché mi pare che questo sia il contesto più importante per la letteratura.
CDM: Non si tratta dunque di fare una storia del romanzo.
RP: Di sicuro non si tratta di una ricostruzione storica puntale. La domanda è: come funziona la finzione nella società? Qual il potere della finzione? C’è una rete di finzioni che costituiscono le fondamenta della società, e il romanzo manipola precisamente queste narrazioni di carattere sociale, le ricostruisce, dà loro forma. La domanda sarebbe in realtà: in che modo il romanzo riproduce e trasforma le finzioni che si tramano e circolano in una società?
CDM: Emilio Renzi, personaggio delle tue opere narrative, e Ricardo Piglia: come si incontrano? Quando e come hai inventato Renzi?
RP: Renzi compare subito, nei primi racconti di La Invasión ed è presente in tutti i libri che ho scritto. Di sicuro, prima di tutto, è un effetto di stile, un tono, un modo di raccontare. Allo stesso tempo ci sono alcuni tratti autobiografici che vengono fuori leggermente parodiati. È un personaggio a cui guardo con molta ironia – in fondo, gli interessa solo la letteratura, vive e osserva ogni cosa dal punto di vista della letteratura e in questo senso faccio anche di me stesso oggetto d’ironia. Tutto ciò che non è letteratura mi annoia, come direbbe un tale ceco. Alla fine però sarebbe meglio dire che Emilio Renzi è una specie di Stephen Dedalus errante, un Quentin Compson che vive ad Almagro, voglio dire il giovane artista, l’esteta che osserva il mondo con disprezzo. In Respirazione artificiale c’è una tensione tra Renzi e Maggi – il quale prende in giro questo sguardo estetizzante, e in qualche modo questa tensione è il romanzo stesso, perché in fondo si racconta una sorta di educazione sentimentale di Renzi, un’educazione politica, storica.
CDM: Oltre alla storia, la politica è stata uno dei tuoi centri d’interesse. Come è entrata, o in che modo è presente questa dimensione nei tuoi libri?
RP: È un elemento che fa parte della finzione, per me. Dall’altro lato penso che tutti i grandi testi siano politici. C’è una politica nel crimine, una nel linguaggio, un’altra nei soldi e nel furto e ancora una nelle passioni. E di questo parlano i grandi testi: sono modelli del mondo, miniature allucinanti della verità. Come diceva Ernest Bloch: “Il carattere essenziale della letteratura è trattare ciò che non è ancora manifesto come se esistesse già”. C’è sempre un fondamento utopico nella letteratura – in ultima istanza, la letteratura è una forma privata dell’utopia.
CDM: La politica si definirebbe attraverso l’utopia?
RP: Non proprio così – le parole si sprecano più rapidamente che i soldi in Argentina, credo già esista un’utopia alfonsinista[1]. Quando dico utopia penso alla rivoluzione. La comune di Parigi, i primi anni della rivoluzione russa, questa è utopia – questa è politica: essere realisti è chiedere l’impossibile. Baudelaire e Marx avevano gli stessi nemici. O vogliamo invece intendere la politica come la rinnovazione parziale delle camere legislative o gli andirivieni di certi personaggi peronisti? Se è così, preferisco discutere della variante di Kasparov nella formazione Scheveningen della difesa Siciliana, o dell’uso del congiuntivo nella prosa di Musil – mi sembrano temi molto più interessanti e di maggiore utilità.
CDM: Ti sembra un dibattito chiuso del tutto?
RP: No, al contrario. Alcuni hanno perso speranza e fiducia, sono diventati sensati e conformisti. Corrono il rischio di diventare funzionari del senso comune. Per pensare bene, voglio dire per essere il contrario di un benpensante, bisogna credere che il mondo possa essere cambiato – bisogna posizionarsi in un luogo eccentrico, opposto all’ordine stabilito, fuori da ogni cosa. Non ho fiducia in nulla, non sono ottimista – proprio per questo credo che aspirare all’utopia e alla rivoluzione sia necessario. Solo per amore dei disperati conserviamo la speranza, diceva un amico di Brecht.
CDM: Aver cominciato a scrivere negli anni ‘60 rapprenta un tratto specifico, un certificato di origine della tua opera?
RP: Spero di sì. Perché credo che gli anni ’60 non siano una data ma una posizione. La circolazione degli stili, la lotta, la giustapposizione, le varianti, cambiare di genere e tono, manipolare collocazioni molteplici. La strategia delle citazioni e degli slogan. Un esempio chiarissimo di questo spirito è Oscar Masotta. O ancora i libri di Manuel Puig, anche Rodolfo Walsh. Fregarsene dei luoghi comuni, mescolare giornalismo e finzione, radioteatro e romanzo, i fumetti con Roberto Arlt, la politica con l’arte. Di fronte all’uniformità liberale della voce univoca, la proliferazione e il cambio. Quello che accadde con “Tucumán arde”, dove lavorarono Renzi, l’altro Renzi, Juan Pablo e Jacoby, installare nell’edificio dei sindacati un percorso attraverso cui entravano slogan, storie di vita, disegni, testi, panflets, fumetti, manifesti, foto. Mi riconosco in questa effervescenza che oggi si ritrova solo in alcuni gruppi marginali.
CDM: In quel periodo sei stato direttore dell’unico numero della rivista Letteratura e società.
RP: Sì, nel ’65. La rivista era un tentativo di intervenire nel dibattito della sinistra, affrontare la tradizione di Lukacs e del realismo, favorire l’ingresso dei problemi posti da Brecht, Benjamin, la tradizione dell’avanguardia russa degli anni ’20, Tretiakov, Tinianov, Lissitsky.
CDM: Com’è stata la tua esperienza di iniziazione al mondo editoriale – scrivere e pubblicare?
RP: Vinsi un concorso e pubblicai il mio primo racconto – in realtà il secondo che avevo scritto. Vincere un concorso è una cosa che a un certo punto, all’inizio, a metà o alla fine, accade a ogni scrittore argentino. È un’umiliazione per cui bisogna passare, se uno vuole essere uno scrittore realmente argentino. Così con uno dei miei primi racconti, nel ’62, vinsi un concorso organizzato dalla rivista El escarabajo de oro – condividemmo il premio con Briante, Rozenmacher e altri, Octavio Getino anche, credo.
CDM: Era un periodo più difficile per esordire?
RP: Non direi, allora pubblicare il primo libro era relativamente facile. In realtà bisognerebbe pubblicare tutti i primi libri che si scrivono: è il momento migliore, l’autore è sconosciuto, non si sa quello che può succedere. Dovrebbe esserci una casa editrice dedita unicamente a pubblicare le opere prime. Sarebbe materiale fantastico, decine di libri, si potrebbe realmente avere un’idea di come funziona la letteratura argentina. Una sorta di pubblicazione obbligatoria, sarebbe stranissimo, verrebbero fuori i libri più stravaganti. Le cose ovviamente funzionano al contrario: pubblicano solo quelli che hanno già pubblicato, per questo la letteratura argentina è così monotona. In ogni caso, in questi anni, vari scrittori hanno esordito. Alan Pauls, ad esempio, ha pubblicato El pudor del pornógrafo, che è un’eccellente opera prima.
CDM: In che modo si coniuga, nell’immaginario di uno scrittore, la sua propria esperienza?
RP: Credo che le esperienze vere siano sempre sociali. L’idea dell’esperienza individuale è una conseguenza della letteratura. Il bovarismo è la cifra del XX secolo. Si può dire che ci sono generi o tipi di esperienza, modelli, come si può parlare di forme e generi per una narrazione. Gli scrittori sono coloro che costruiscono e danno forma all’esperienza.
CDM: Pensavo a due scrittori mentre ti facevo la domanda: Malraux e Semprún.
RP: Malraux trovò l’esperienza come turista della storia, andò a spiare un po’ la rivoluzione cinese e la guerra civile spagnola e finì ministro di De Gaulle. Hermigway invece potrebbe servirci da esempio – perché il miglior Hemingway, quello delle prime narrazioni, riduce l’esperienza al punto zero. Nick Adams è un amo, un uomo anziano beve liquore all’anice in un bar pulito e ben illuminato. Lo stile diventa un mezzo per captare l’emozione che produce il vuoto: l’esperienza si è dissolta e Hemingway è il primo ad affermarlo chiaramente. Sono le epifanie di Joyce – momenti fugaci, quasi impercettibili – a condensare quello che rimana delle rovine dell’esperienza. Il primo romanzo di Semprún mi piace, Il grande viaggio è uno dei migliori romanzi politici che conosca. Poi però mi pare si sia lanciato nella retorica autobiografica, dedicandosi a esibire la sua vita come se fosse la cosa più importante della storia di Spagna.
CDM: Che immagine hai come scrittore all’interno della letteratura argentina?
RP: Nessuna.
CDM: In che senso nessuna?
RP: Che immagine dovrei avere? Quella che gli altri hanno di me. Bisogna andare oltre, io dico, scappare dal museo di cera in cui sono condotti gli scrittori. Una delle virtù della letteratura è proprio la possibilità di fregarsene di queste immagini in cui si rischia di restare cristallizzati. Si può sempre scrivere un altro libro, ricominciare da capo come sconosciuti.
CDM: Rispetto invece alla ricezione critica dei tuoi libri: influisce nel tuo “progetto creatore”, per dirla con Pierre Bourdieu?
RP: Dipende da cosa si intenda per progetto creatore. Credo che questo progetto possa definirsi solo come l’insieme delle convizioni e dei principi che uno scrittore ha rispetto al successo, al riconoscimento, al prestigio e persino al fallimento. La ricezione critica condensa la lettura sociale – in questo senso, mi pare si debba mantenere con la critica la stessa relazione che si intrattiene col mercato: interesse per gli effetti e l’impatto di ciò che si scrive, ma anche, allo stesso tempo, distanza e indipendenza.
CDM: Certa critica segnalava come Respirazione artificiale non raccontasse una storia.
RP: Ne raccontava varie, mescolandole. E narrava anche cose che, così pare, non dovrebbero avere spazio in un romanzo. Io invece penso che tutto possa convertirsi in finzione. Amori, idee, circolazione del denaro, la luce dell’alba. Sono sempre più convinto che si possa raccontare qualunque cosa: da una discussione filosofica all’attraversamento del Paraná da parte della cavalleria in fuga di Urquiza. Si tratta solo di saper raccontare, sarebbe a dire di essere capaci di trasmettere al linguaggio la passione di ciò che sta per accadere.
CDM: Come hai scritto i tuoi libri, e in particolare La città assente?
RP: Il problema per me non è costruire la trama, quanto trovare il tono di un testo. Narrare è entrare in un ritmo, in una respiro del linguaggio: una volta che si possiede questa musica, l’aneddoto funziona da solo, si trasforma, si ramifica attraverso vari registri – la questione, quindi, si complica. Per prima cosa, in generale, prendo appunti partendo da un aneddoto iniziale, che spesso non trova spazio nel testo o si perde. Lo sviluppo della storia dipende sempre da questo tono, da questo ritmo che non credo possa essere assimilato in modo univoco allo stile: si tratta piuttosto di un movimento, qualcosa che accade tra le parole e non con le parole.
CDM: Che differenza c’è tra La città assente e Respirazione artificiale?
RP: L’unica cosa che hanno in comune è il personaggio di Renzi, che in La città assente ha 60 anni e sta per morire. Mi piacerebbe sembrasse scritto da un altro autore – è una pretesa impossibile, è chiaro.
CDM: È un gesto avanguardista?
RP: Non saprei. Nel romanzo il gesto avanguardista per eccellenza è quello di Macedonio Fernandez o di Musil: trascorrere la vita intera a scrivere un solo romanzo che includa tutte le varianti e tutte le storie possibili. Il romanzo di una vita: quest’idea mi piace perché è estrema – bisogna però avere il coraggio di Macedonio o di Musil, e io non credo di essere capace di arrivare fino a lì, non per ora almeno. In ogni caso non mi interessa l’identificazione con l’avanguardia, non mi sono mai definito con questa figura, per quanto forse, in quest’epoca così conservatrice, non sarebbe male rivendicarne lo spirito. Preferisco parlare di sperimentazione – che rappresenta per me la cifra della grande letteratura.
CDM: Ho letto La città assente: si può dire che ci sia una sorta di spostamento verso il futuro, secondo un procedimento tipico della science-fiction?
RP: No, non ha niente a che vedere con la science-fiction, per quanto alcuni scrittori di questo genere mi piacciano molto, come Philip Dick, Thomas Disch o lo stesso Pynchon. Direi piuttosto che è un romanzo sul presente che trascorre nel futuro – allo stesso tempo, tutti i romanzi trascorrono nel futuro.
[1] Cfr. Raúl Alfonsin, presidente dell’Argentina dall’83 all’89.