
Ma mi trova, questa schifosa emicrania, non le importa cosa penso, mi assale mio malgrado, preme e schiaccia e punge dietro gli occhi, che vergogna, ma questa malattia teatrale l’ho presa da mio padre, era anche lui uno straccio da emicrania. Alla base, istinti di vendetta che colpiscono con stecche d’acciaio, provocando un perverso orgasmo dell’anima e, zac! subito è chiaro che razza di esseri meschini siamo e, zac! com’è misero questo crogiolarsi negli io-io-io e, per favore, aprite la tomba nella mia testa, così che ci sia una fine a questa grama esistenza di continua denigrazione, che si gira e rigira nel letto e piagnucola e digrigna i denti.
Prego?
Mai avuta compassione?, ascolto.
Mai.
(Apostoloff, p. 173)
Sibylle Lewitscharoff è una scrittrice che scava nell’intimo disagio dei suoi personaggi per trarne collante globale, cosmico, addirittura metafisico. Che si affronti un viaggio attraverso un’identità (personale, politica, storica) lacerata e dolorosa, come accade alle due protagoniste di Apostoloff, o si cerchi il senso di un miracolo, come accade in Blumenberg, si respira un legame incomprensibile, indissolubile e inquietante tra crisi esistenziale, sociale e universale.
C’è una sorta di riverbero, nei romanzi di Lewitscharoff, un rimpallarsi continuo di problematiche scorticanti ma elusive, che si spande in ogni angolo e al contempo contamina tutto ciò che tocca, aiutando i protagonisti a scavarsi dentro fino a percepirsi, a compiersi, a ricevere un’illuminazione accecante ma del tutto priva di grazia. Il fatto è che sia Apostoloff che Blumenberg hanno delle sfumature apocalittiche (nel senso di rivelatrici) che mozzano il fiato, irrobustite da finali esplosivi, traboccanti di una suspense esistenziale capace di far tremare cuore e ginocchia.
In segreto, dal leone fluiva inesauribile la rassicurazione che la rete di nomi che copriva cielo e terra, che gli uomini avevano ideato per la propria tranquillità, era ancora resistente agli strappi dei fisici, degli astronomi, dei biologi e dei filologi che raschiavano, tagliavano e intaccavano con lame e bulini, solerti, ogni nome e ogni metafora nata per conseguenza della denominazione. Il che non significava che fosse rimasta statica. Doveva mutare, ma più in senso di persistente metamorfosi, senza il rigido accantonamento di più vecchie concezioni e modelli di pensiero gettati alle ortiche.
(Blumenberg, p. 140)
Sia in Apostoloff che in Blumenberg si avverte l’intervento di una trascendenza potente ma non giudicante, priva di implicazioni morali o affettive: il leone che appare al filosofo Blumenberg, e che dà il via all’affresco di vite nel romanzo omonimo, è una scintilla di consapevolezza che spinge i protagonisti a essere quello che sono; il viaggio in Bulgaria (e la successiva gita) per seppellire il padre porta le due sorelle protagoniste di Apostoloff a una presa di coscienza del loro male personale attraverso il ricordo doloroso del male familiare e l’esame distaccato e sarcastico di quello politico. Tuttavia, tali agnizioni sono volatili, non si prestano a essere analizzate ma portano a un mistero più complesso, che non si è in grado di affrontare, e neanche di circoscrivere.
Lewitsharoff accompagna (segue?) i suoi protagonisti in territori completamente estranei, talvolta perturbanti.
All’interno di tali esplorazioni, i dialoghi e soprattutto i monologhi hanno un’importanza fondamentale, perché fanno emergere quell’inconoscibile che ci circonda e ci pervade, e che si riflette nelle nostre vite; tutti i personaggi di Lewitscharoff parlano tantissimo, lanciandosi in ipotesi e in riflessioni per districarsi in un mondo di lancinante e nebbiosa ambiguità. Addirittura, in Blumenberg è il narratore stesso che interviene, non per spiegare, ma per interrogarsi, al massimo per azzardare ipotesi che, però, non chiarificano mai ciò che accade, ma lo stratificano e lo complicano.
Secondo Epicuro, disse Gerhard, siamo avviluppati in discorsi infiniti, seppure non greci, seppure non divini. Tanto esonerati dalla cura che ci avviluppiamo solo per amor di viluppo e ci raccontiamo delle storie che non abbiamo sofferto.
Quelle che invece abbiamo sofferto è meglio non raccontarle, disse la Mehliss.
Isa alzò la testa e si guardò a destra e a sinistra. Ciò che abbiamo sofferto, sta lì, sopra le scale e ci guarda beffardo. Lassù c’è il mio vestito bianco e sta lì a sventolare.
Sventolare?, si meravigliò Gerhard.
Ondeggia.
Il privilegio dei deboli, di raccontare storie, mormorava Blumenberg tra sé e sé.
(Blumenberg, p. 222)
Guarda come dorme questo Noi senza occhi, anche l’universo dorme nella sua tana scura, tutti noi ci dormiamo protetti con un sorriso triste, come vecchie zitelle ossute che si risparmiano per l’amante divino, che magari viene persino, ma dopo un breve momento decide che è meglio non svegliarci, perché siamo del tutto insignificanti.
(Apostoloff, p. 84)
Il fatto è che la vita non è per sé unità di misura ideale, e lo stesso si può dire della percezione che si ha dell’esistere in generale; tanto più che è proprio nella lacerazione tra noi e le cose che si manifesta quel trascendente, ambiguo e fumoso, che per un secondo ci rivela a noi stessi, una scintilla di cui noi vediamo solo l’ombra, e con cui dobbiamo confrontarci, consapevoli che ne usciremo ancora più confusi.
Sibylle Lewitscharoff
Apostoloff (2009)
Trad. it. Paola Del Zoppo
Roma, Del Vecchio editore, 2012
pp. 238
Blumenberg (2011)
Trad. it. Paola Del Zoppo
Roma, Del Vecchio editore, 2013
pp. 230

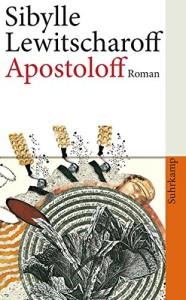

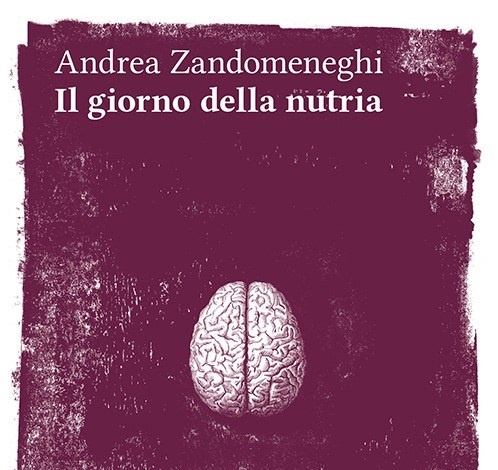

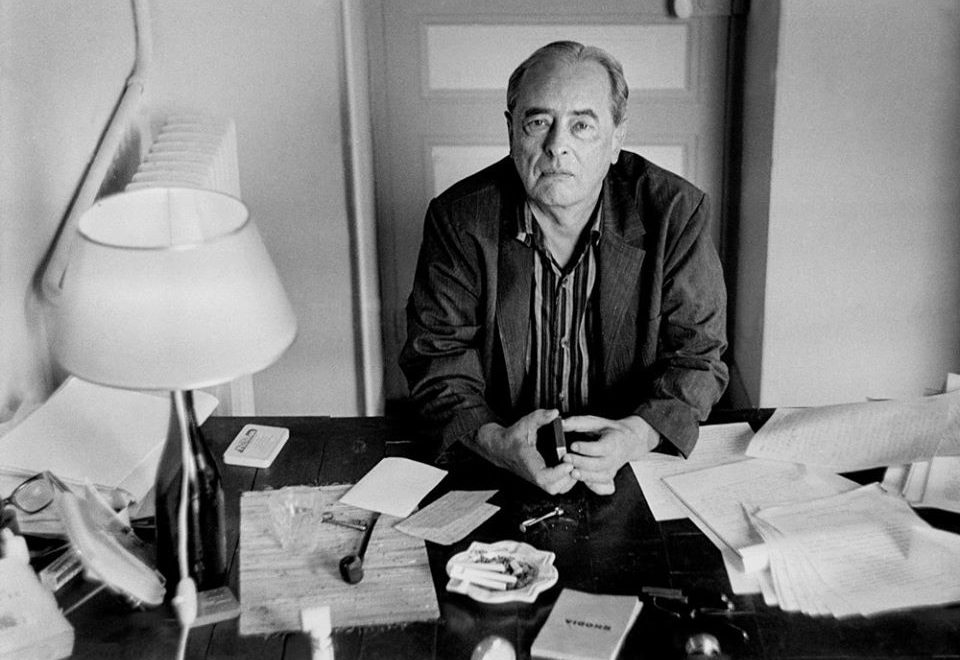
mi incuriosisce moltissimo… soprattutto Blumenberg, avendo letto anni fa “Naufragio con spettatore”
un saluto
Salve Caterina,
lieta di averti messo curiosità :-).
Da parte mia, posso solo dirti che ho ordinato il Naufragio che tu hai già letto proprio perché incuriosita da Lewitscharoff (per la serie: il moto perpetuo della curiosità).
Ricambio il saluto, e spero che mi farai sapere cosa ne pensi della Sibylle
Chiara