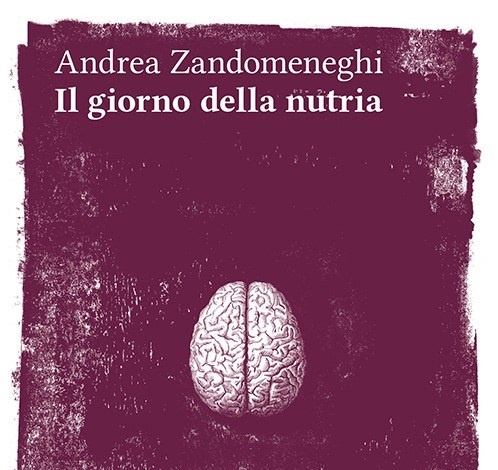Incipit.
E l’apostolo disse:
Dal Mediterraneo non si odono più risalire le scricchiolanti ombre di pesce che giungevano alla corte dei miei sogni, elettriche e furiose, scatenandosi dall’acqua fino alla mente. C’è una fossa ora nel mare: vi ribolle la luna, si spezzetta come le ostie impugnate in segreto, al riparo dalla frescura maligna.
La storia e il gotico siciliano.
A tre anni di distanza da Lo Scuru (Tunué, 2014), Orazio Labbate, in Suttaterra, attinge dal medesimo mondo, quello di Razziddu Buscemi di Gela che era morto raccontando, a Milton, in West Virginia – o, meglio, evocando, quasi a metter fuoco sotto il calderone dei ricordi per far fumigare la memoria – passando la parola al figlio di Razziddu, Giuseppe Buscemi (e con la medesima tecnica: intro in prima persona, poi passaggio alla terza, con la differenza che in Lo Scuru si chiude tornando in prima).
Giuseppe Buscemi è un becchino trentenne che ha perso la moglie da un anno; dalla moglie viene richiamato e così intraprende quel viaggio da Milton a Gela intitolato dall’autore “Viaggio verso la morta”.
Quanto avviene in questo viaggio (e in questo romanzo) è la programmatica attestazione di un genere cui Labbate solo presiede: il “gotico siciliano”. Labbate pare ricorrere a tutto il suo armamentario – una sfarzosa cassetta degli attrezzi del suo mestiere di “scrittore gotico siciliano”, costruita con studio profondo, attento, finalizzata a dotarlo di tutti gli strumenti possibili per strutturare i suoi castelli gotici: temi, metafore, immagini; in fondo l’adesione a un genere è pur sempre il rispetto degli schemi – per confermare sé stesso e la sua opera, quasi per dire “il gotico siciliano sono io”.
Cos’è il gotico siciliano di Labbate? Il genere gotico calato in terra sicula, il che, in Lo Scuru, ha funzionato. Ricordi, fantasmi, malinconia, morte, rito, superstizione e altro: tutto questo è comune a entrambi i romanzi. Ma in Suttaterra il gioco non regge: c’è come il sospetto di una maniera, la sensazione di un qualcosa di artefatto, e anche la difficoltà a seguire una trama che continuamente sfuma, che sempre vorrebbe spumeggiare tramite linguaggio, ma che proprio dal linguaggio – il problema – è sommersa, portata all’asfissia, salvo liberarsi in un’immagine finale di rara meraviglia che però, nella sua semplice e evidente bellezza, suggerisce che tutto il romanzo, fino a lì, ha sofferto un errore di percorso.
Errore di percorso: il linguaggio.
L’errore è il linguaggio. In Lo Scuru il linguaggio era il punto di forza, in Suttaterra il linguaggio è il limite. Resta un mistero il cambio di registro operato dall’autore tra il primo e il secondo romanzo, nonostante immaginario e scenari siano comuni.
Nel primo c’è un impasto di italiano e siciliano, senza eccedere nel dialetto ma talvolta italianizzandolo, che rende la litania di Razziddu Buscemi potente ed evocativa, tenendo il protagonista in bilico tra due mondi (e le lingue, lo sappiamo, sono mondi):
Razziddu, lupucùviu come un cenobita dissennato, rivoltava dallo stratùni un cane defunto e per intanto moveva la carne delle sue vràzza, accamòra rrappàta di altri quattordici anni, ché un apiario rimirava e verso il carcame della bestia e insino attorno a iddu. Poi, cacciati gli insetti con un vastùni di canna della macchia, incise le palpebre dell’animale grazie a un cutieddu nìcu fino a ricavare gli occhi, serbati infine in un sacco, col pensiero ‛dduluratu d’un juòrnu seppellirli propriamente nel Mediterraneo.
(Lo Scuru, p. 46)
Nel secondo, invece, il medesimo italiano del primo, composto di termini desueti e ricercati, privato dall’elemento dialettale, è una lingua falsa, inattuale, in un certo modo rumorosa (seppur con lodevoli eccezioni che non sorprendono, data l’innegabile qualità dell’autore), come vediamo qui, con quel sintomatico “viperinamente”:
Sentendosi in corpo il freddo farsi febbre, assieme a una fame perversa che gli percorreva viperinamente lo stomaco, Giuseppe si diresse di cattivo umore in cerca delle stanze e del refettorio.
(Suttaterra, p. 51)
 Il linguaggio artificioso e talvolta polveroso, da traduzione ottocentesca, usato da Labbate in Suttaterra costringe il lettore di continuo a annaspare in termini vetusti come “ove”, “rimembrare”, “principiare”, “qualcheduno” che figurano quali corpi estranei in una prosa né contemporanea e dunque viva né mimetica alla maniera del Michele Mari di Io venía pien d’angoscia a rimirarti. Non si comprende la necessità dell’arcaismo, laddove l’arcaismo non è bene innestato. Era ricchezza, al contrario, nel felice impasto linguistico di Lo Scuru.
Il linguaggio artificioso e talvolta polveroso, da traduzione ottocentesca, usato da Labbate in Suttaterra costringe il lettore di continuo a annaspare in termini vetusti come “ove”, “rimembrare”, “principiare”, “qualcheduno” che figurano quali corpi estranei in una prosa né contemporanea e dunque viva né mimetica alla maniera del Michele Mari di Io venía pien d’angoscia a rimirarti. Non si comprende la necessità dell’arcaismo, laddove l’arcaismo non è bene innestato. Era ricchezza, al contrario, nel felice impasto linguistico di Lo Scuru.
Che motivo ha questo cambio di registro? Perché depauperare quanto c’era di più bello e promettente e raro per complessità – lo scontro con il dialetto siciliano, lo scontro dell’autore col suo passato, con la sua terra di origine – e musicalità in Lo Scuru: il linguaggio?
Si spera di tornare a leggere, presto, lo scrittore di Lo Scuru, oppure lo scrittore più immediato e funzionale al genere gotico – salvo qualche eccesso nella scelta delle parole presente, seppur in maniera minore, anche qui (e suggerisco la lettura che ne fa Alfredo Zucchi in «Cattedrale») – dei racconti di Stelle Ossee (LiberAria, 2017).
Orazio Labbate
Suttaterra
Latina, Tunué, 2017
pp. 140