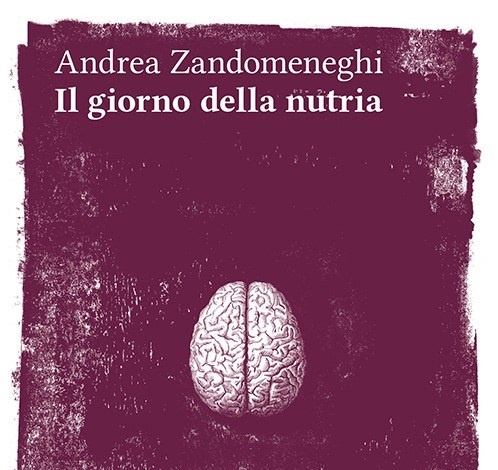Siamo lieti di presentarvi Tears of Lava, ultimo EP di The Softone, progetto musicale indipendente di Giovanni Vicinanza, in collaborazione con Antonio Ostuni.
Quello che una volta si sarebbe detto il disco, e che nell’epoca 2.0 potete invece ascoltare gratuitamente qui, conta sei tracce. Bisogna dire che l’EP vede la collaborazione anche di altri musicisti: Raffaele Polimeno (piano rhodes, moog synth, piano, backing vocals, hammond); Daniele Bove (drums, hammond); Corrado Tortoriello (backing vocals); Nicola Lucherini (sax). Che il disco è stato arrangiato, registrato e mixato al Lavalab, lo studio di registrazione di Giovanni, immerso nel verde dei vigneti vesuviani.
Una volta fatte le presentazioni, direi che possiamo metterci sulle tracce.
Prima l’evidenza: in questo EP, che appare così sonoricamente differente dalle produzioni precedenti di The Softone, proprio di quelle conserva in fondo dei segni che sono come un filo rosso, per non perdersi, non dimenticare le proprie radici. Nel nostro caso: il folk indipendente e un intimismo, cui non si sfugge neanche in Tears of Lava.
Innanzitutto: ciò che permane – quella cosa scomoda che per acconciarsi la bocca si chiama tradizione, e che oggi è mimeticamente l’esperienza personale. Dicevo del folk indipendente, le cui tracce in questo EP si ritrovano nelle strutture essenziali, minimali dei brani, nei testi asciutti, dove la natura più intima dell’esperienza (nodo cruciale, a mio avviso, nella scrittura di Giovanni Vicinanza) è smussata, ma occupa comunque spazi decisivi: l’inizio, il centro e la fine del filo rosso, che stiamo seguendo e che tradotto in musica suona in Walk away, He came at the dawn (in cui si avverte – o solo io avverto? – come una nostalgia dylaniana), Ray of light. Se si nota, poi, che Walk away e Ray of light siano la prima un invito al viaggio e la seconda una visione di morte (Ray of light please come and give me for a while), allora si ammetterà che il filo c’è ed è stato nascosto bene. E pure un filo è troppo poco.
La chiave di Tears of Lava, però, non è quel filo, è un’altra. La tradizione – o esperienza personale – stessa è diventata diversa, si è stratificata, ha accumulato beat, che venivano da un’altra parte, ma che sotto il Vesuvio avevano trovato un terreno fertile. Dico, il blues[1] (una precisazione: per blues non si intendano solo le dodici battute, le settime, i turn-around etc.) e il suo spazio è il suono. In fondo, se qualcosa salta all’orecchio in questo EP, è proprio la quantità di suoni mescolati ad arte in un tempo breve (nessun brano supera i 4 minuti). E se si ascolta bene, se si cerca di scomporre l’insieme, ecco che viene fuori tutta la qualità, che non solo è nella resa (o meglio nel lavoro di produzione, missaggio etc.), ma molto è nella presa, ossia nel suonato vero e proprio, fatto che si può desumere dall’ingombranza squassante del Big Muff, ad esempio, e dai riverberi profondi e saturi a tal punto di cazzimma da esploderti in faccia (vedi, Right o wrong). E ancora, per intenderci: qualche sera fa Giovanni mi parlava di come aveva scelto di inserire il sax in Somewhere over: “dopo aver ascoltato alcuni assoli, belli ma troppo complessi, ho chiesto se poteva suonare poche note, essenziali ma blue, come nei blues di Tom Waits”. Non si poteva essere più chiari.
Infine (anche se non è proprio l’ultimo pezzo): Son of a gun, dove la chitarra di Antonio Ostuni scava un solco profondo nello stomaco, quando entrando bassa e distorta e profonda si annuncia come uno squarcio, il colpo di pistola. Forse, e parlo per il mio solo gusto, questo è il pezzo più riuscito di un EP, che merita più di un ascolto.
[1] Per chi non lo sapesse: Sarno just like Missisippi, in quanto a indigenza!